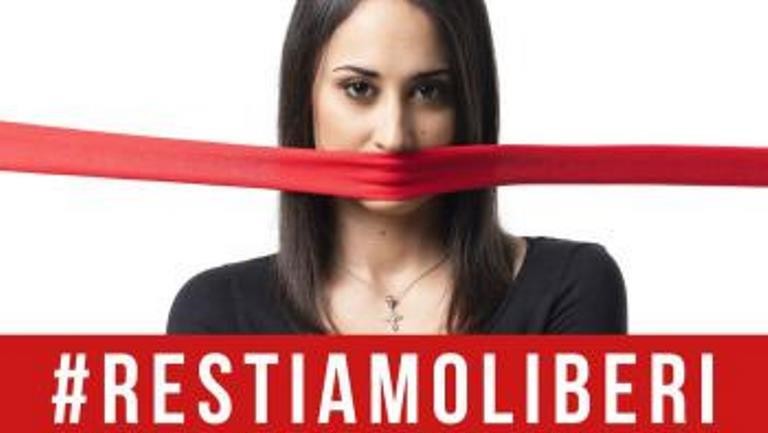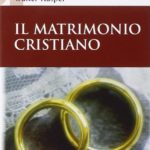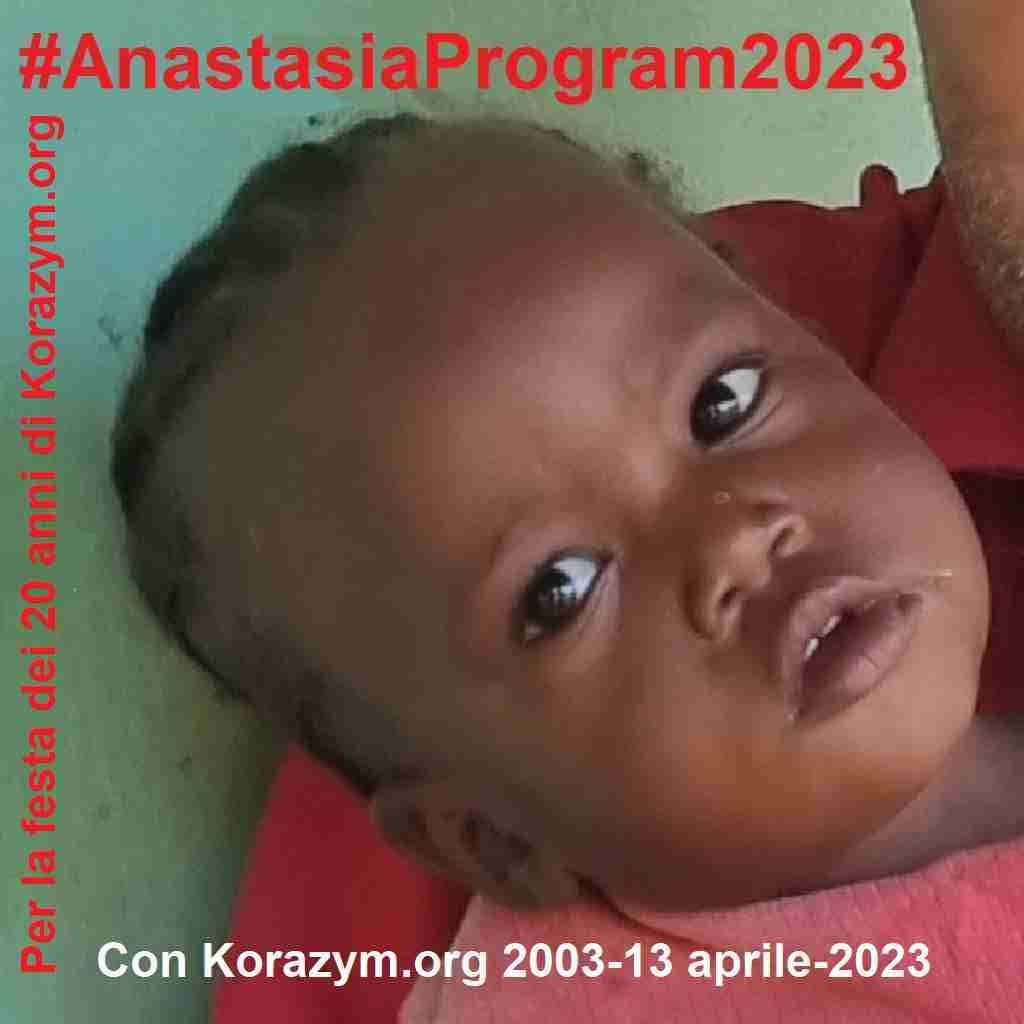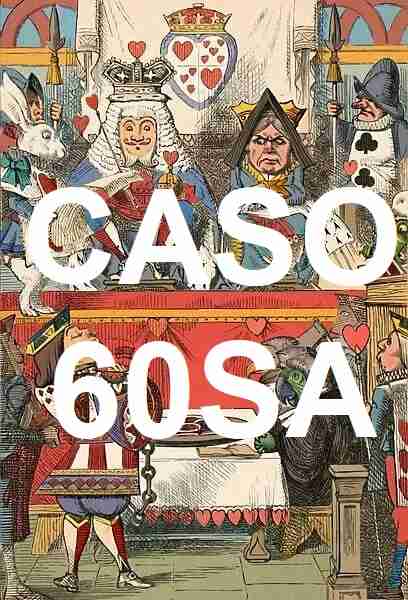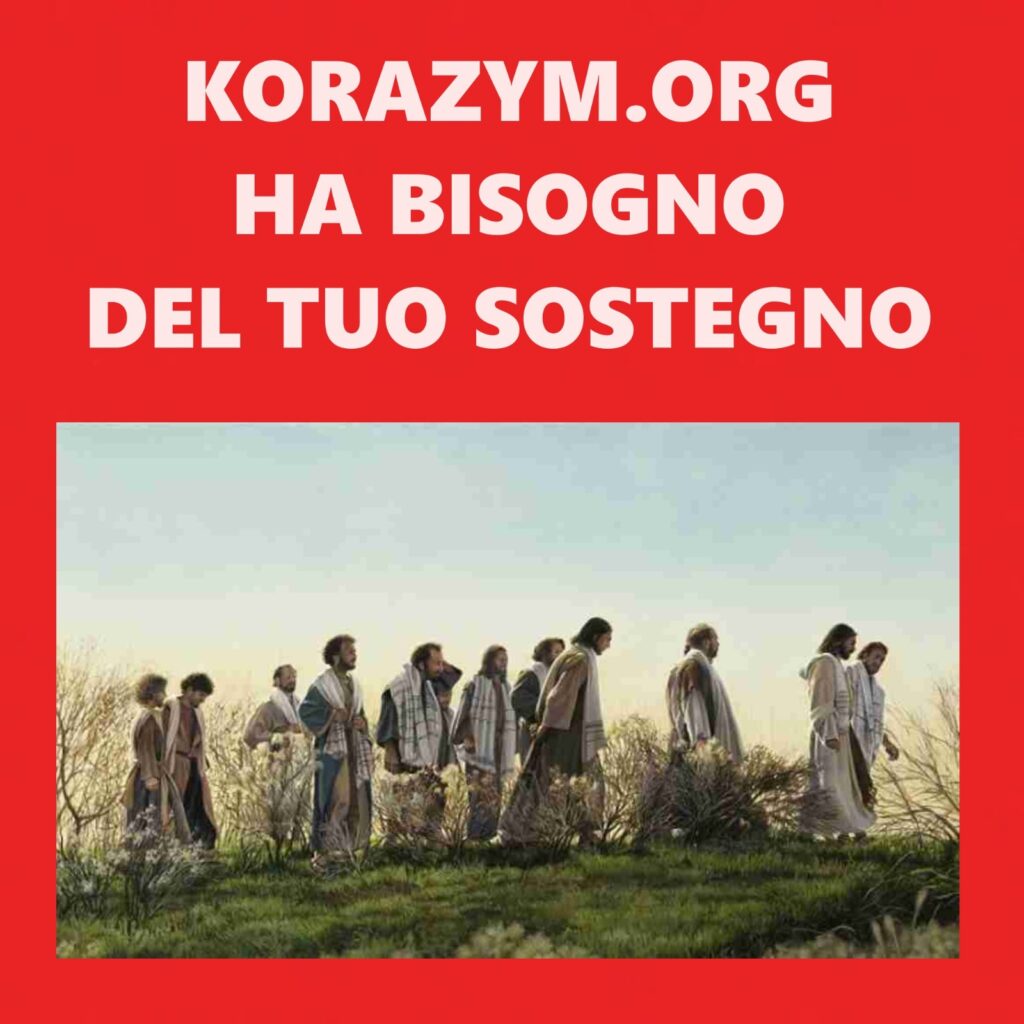Fratelli tutti: appello di teologi e teologhe per ‘salvare la fraternità, insieme’

Si intitola ‘Salvare la Fraternità – Insieme’ l’appello, scritto da dieci teologhe e teologi, convocati da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica accademia per la Vita, e da mons. Pierangelo Sequeri, preside dell’Istituto San Giovanni Paolo II, per una teologia capace di dialogare col mondo contemporaneo:
“E’ un appello alla Chiesa in tutte le sue componenti, e ai Saggi, uomini e donne di buona volontà. E’ un appello con il quale confrontarsi, non un’analisi da accogliere o respingere. Non è un ‘direttorio’ di tesi alle quali è chiesto di aderire, ma un ‘repertorio’ di temi sui quali ci appare decisivo riflettere e discutere”.
L’appello scaturisce direttamente dalla provocazione dell’enciclica di papa Francesco ‘Fratelli tutti’ per raccogliere il senso profondo di questa definitiva provocazione, rivolta ad una Chiesa sollecitata ad aprirsi e a un mondo tentato di chiudersi, inaugurando il clima di una ‘fraternità intellettuale’ che riabiliti il senso alto del ‘servizio intellettuale’ di cui i professionisti della cultura, teologica e non teologica, sono in debito nei confronti della comunità.
L’appello è “un appassionato invito alla teologia professionale (ed in generale ad ogni credente) perché offra uno spazio privilegiato e comune all’impegno di decostruzione del duplice dualismo che ci tiene attualmente in ostaggio: fra la comunità ecclesiale e la comunità secolare; fra mondo creato e il mondo salvato.
La Chiesa non è un’aristocrazia spirituale degli eletti, ma una tenda ospitale che custodisce l’arcobaleno dell’alleanza fra Dio e la creatura umana. La fede imparerà ad abitare i linguaggi del mondo secolare, senza pregiudizio per il suo annuncio della vicinanza di Dio. E la prossimità ecclesiale della fede sarà abitabile anche per la Cananea, la Samaritana, Zaccheo, il Centurione. Senza pregiudizio per la loro distanza”.
Come ha spiegato mons. Vincenzo Paglia nella postfazione che chiude l’Appello, “le istituzioni ecclesiali sono chiamate a fare la loro parte nella promozione di un dialogo più profondo e assiduo fra l’intelligenza della fede e il pensiero dell’umano. In questo rinnovamento, la teologia e la pastorale convergono, come le due facce dell’identica azione.
La recente enciclica ‘Fratelli tutti’ incoraggia ad immaginare la nuova prospettiva di questo dialogo come la declinazione efficace e necessaria di una fraternità intellettuale al servizio dell’intera comunità umana. L’impulso alla riscoperta della prospettiva inter-disciplinare e trans-disciplinare, da parte della stessa teologia va in questa direzione (Veritatis Gaudium)”.
Il presidente della Pontificia Accademia della Vita ha ribadito la necessità di incontrarsi per il confronto: “Questo appello, iscritto nel kairos di Dio e nel tempo delle cose, chiede l’onestà intellettuale della critica e dell’autocritica, nella stessa misura in cui impone un’alleanza testimoniale che chiede di esporsi personalmente all’impegno di onorare la dignità della vita umana in favore dell’altro…
L’appello allo spirito della fraternità non può essere consumato nel degrado di una visione empatica e sentimentale dell’unità della specie; né venire consegnato alla visione mitica e utopica di una romantica politica del benessere senza confini. la riabilitazione della fraternità è un tema serio, che va pensato ad una profondità ancora inesplorata, per la nostra epoca: dal cristianesimo e dalle religioni, dalla politica e dal potere, dalla filosofia e dalla scienza.
Il tema dell’appello è questo: dentro la fraternità intellettuale tutto può essere guadagnato, al di fuori di essa, tutto può venire perduto. L’umano che è comune, a cominciare da quello in mille modi avvilito e abbandonato, è il suo riscontro decisivo. E il tema del suo giudizio ultimo: per tutti”.
L’appello è l’invito ad aprirsi al kairos: “Il nuovo kairos che si è aperto nella storia della fede è il tempo in cui risuona l’attestazione del lavoro del regno di Dio nel campo del mondo secolare: non solo nel campo della comunità credente, ma nel campo totale della città dell’uomo.
Il compito della Chiesa è renderlo accessibile, non requisirlo. La vocazione storica del cristianesimo di questa epoca è questa. In questa prospettiva, la nostalgia di un mondo più accondiscendente, e il risentimento per un mondo troppo ostile, vanno ugualmente deposti. Non esiste un mondo già pronto per l’avvento del regno di Dio”.
Quindi la teologia è un bene comune: “La teologia ecclesiale deve perciò acquisire lo stile di un pensiero creativo e ospitale per tutti, non ridotto a un gergo per iniziati. Sembra evidente che questo comporterà un significativo mutamento delle istituzioni ecclesiali.
Quelle accademiche certamente, ma anche quelle di base. Il focus, e il canone, di questa trasformazione di base può essere riassunto in una immagine fondante della rivelazione medesima”.
Il kairos richiama il significato del dono: “Il kairos odierno impegna la teologia, in primo luogo, alla riabilitazione del dono della parola in cui l’umanità dei popoli si dice e si ascolta direttamente. La scienza non ha alcuna ragione per mortificare l’irriducibilità della testimonianza che l’umano rende a sé stesso.
Restituire dignità di parola e autorità di testimonianza all’immediatezza dell’umano che è comune, la vita quotidiana dei popoli, appunto, è la prima mossa che ci aspettiamo da una politica umanistica e da una cultura critica degna dell’autorità che le affidiamo”.
La fraternità richiama la ‘prossimità’ di Dio: “La formula della ‘fraternità’ ecclesiale, che il gesto dell’enciclica Fratelli tutti estende radicalmente alla ‘prossimità’ evangelica di Dio, indica un tratto relativamente inesplorato della sua destinazione.
La fraternità cristiana si purifica e si perfeziona nel dinamismo, sempre incompiuto, del pensiero e della contemplazione, della parola e dell’azione che portano alla luce la prossimità di Dio per chiunque”.
Il manifesto ha ribadito che occorre restituire la dignità del pensiero, che non è autoreferenziale: “E’ venuto il tempo di restituire al sapere dell’umano l’onore della sua rettitudine e l’onere della sua responsabilità: la conoscenza della verità non è mai esonerata dalla passione per la sua giustizia.
Non possiamo sostenere ancora a lungo una pratica della conoscenza che concede alla scienza di essere esonerata dalla sensibilità responsabile per l’umano che è comune”.
E’ un invito a non disprezzare il ‘Nome di Dio’: “Nessuno è senza scampo e senza speranza, fino a che questo nome è custodito per tutti. Tutti siamo più nudi e più cattivi quando il crocifisso è sbeffeggiato e il risorto deriso. La fede cristiana osa l’annuncio e la testimonianza di un Dio destinato all’uomo in modo irrevocabile, eterno, senza ripensamento: disposto a onorare il suo legame riportandoselo a casa, da ogni perdutezza.
L’onore di Dio, la giustizia del voler bene che genera vita e promessa di vita, è messo in gioco una volta per tutte e per sempre con questo legame: la sua gloria, per suo libero e sovrano intenerimento, è il nostro riscatto. Noi supplichiamo. Non sbeffeggiate il santo Nome di Dio: lasciatevi riconciliare con esso”.
La teologia è chiamata sconfiggere le ‘perversioni’ del sacro: “Senza l’apporto delle ragioni umane del senso, sempre di nuovo cercate per prove ed errori, il pensiero cristiano della fede non può realmente abitare la terra con l’onestà intellettuale che la sua testimonianza dell’incarnazione di Dio esige.
La teologia deve a sua volta accettare di fronteggiare criticamente le perversioni del sacro, per prove ed errori, in modo che non godano della complicità della fede. Di questa alleanza del pensiero sensibile all’umano e della decifrazione salvifica del sacro siamo in debito per le generazioni a venire”.