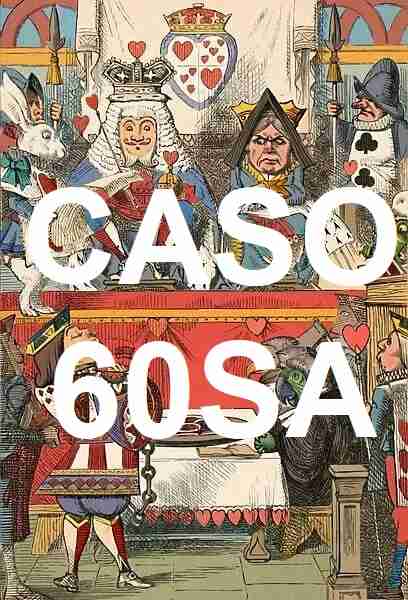La frontiera del vietato avanza ogni giorno. Persino a sinistra si comincia a soffocare. Anche Ezio Mauro ha detto basta

«Ezio Mauro invita a smetterla di censurare chi la pensa in maniera differente. Speriamo che alle parole seguano i fatti. In questi giorni è in discussione in Parlamento la legge Zan-Boldrini. Essa intende educare il popolo estirpandone, con la minaccia del carcere, l’odio di genere. In pratica si mette fuori legge qualunque espressione avversa ai matrimoni gay, alle adozioni per transgender eccetera. Un bel “no, fermatevi” sarebbe gradito» (Renato Farina).
«Se il politically correct domina, è anche perché non trova adeguate risposte. Solo imprecazioni e silenzi. La città è nelle mani degli stolti, dissero al sovrano i messi di una città in rivolta; ma i “savi” nel frangente che facevano, chiese loro il Re Carlo d’Angiò? Domandiamocelo pure noi» (Marcello Veneziani).
«Ho il diritto di avere le mie opinioni e di esprimerle. Sono stufato a sentirmi dire cosa mi sia permesso di dire o di pensare» (Vik van Brantegem, 2 luglio 2020).
Cresce il dibattito provocato dalla lettera aperta pubblicata il 7 luglio 2020 su Harper’s Magazine, a firma di 150 famosi scrittori, giornalisti, accademici e attivisti per criticare la cosiddetta “cancel culture” e per dire no ai bavagli, alle censure preventive e alla gogna collettiva contro chi la pensa diversamente. È un’espressione ormai diffusa, che indica la tendenza – cresciuta a dismisura negli ultimi anni sui social network, soprattutto in ambienti della sinistra, nei giovani e tra gli attivisti “Black lives matter” – ad attaccare le persone di cui emergono comportamenti, idee o dichiarazioni ritenute sbagliate e offensive, indipendentemente dall’importanza e dal fatto che siano attuali o molto antiche, chiedendo punizioni immediate come il loro licenziamento o il boicottaggio, e di creare piedistalli vuoti.
Intanto, appena pubblicato, il manifesto ha subito suscitato le stesse reazioni di indignazione e gli stessi inviti alla condanna, che i 150 firmatari denunciano come veleni per una libera e sana circolazione delle idee, degna di una democrazia. E questo nonostante l’elenco dei nomi rende impossibile una lettura ideologica. Ci sono autori cult della sinistra accanto a conservatori. Artisti afroamericani in compagnia di pensatori noti per la loro avversione a un uso del linguaggio epurato di riferimenti razziali. Accanto a Rowling, che è stata criticata per aver fatto commenti nei confronti dei transessuali, si trova la giornalista transgender Jennifer Finney Boylan, che ha però successivamente preso le distanze dai suoi co-firmatari. E proprio questa retromarcia, insieme a quella della storica afroamericana Kerri Greenidge, mette a nudo la forza della anti-cultura del politicamente corretto, che i firmatari della lettera hanno preso di mira. Boylan e Greenidge sono state accusate di essersi schierate con intellettuali che hanno indebolito le cause LGBT+ o dei diritti dei neri. E, sotto il peso delle critiche, hanno cambiato idea.
Manifesto liberale per il free speech
Pezzi da novanta della cultura contro censura e chiusura del dibattito
Il Foglio, 8 luglio 2020
I nomi sono uno più pesante dell’altro: la storica della Russia Anne Applebaum, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian Buruma, Yascha Mounk, David Brooks, Steven Pinker, Kamel Daoud, Francis Fukuyama, J.K. Rowling, Mark Lilla e tanti altri. Con un manifesto pubblicato dalla rivista Harper’s, questi studiosi e intellettuali di area liberale spiegano che una “necessaria resa dei conti” con alcuni torti delle democrazie ha “intensificato una nuova serie di atteggiamenti che tendono a indebolire le nostre norme sul dibattito aperto e la tolleranza delle differenze a favore del conformismo ideologico. Mentre applaudiamo al primo sviluppo, alziamo la nostra voce contro il secondo”. Sostengono che il libero scambio di informazioni e idee, “linfa vitale di una società liberale”, sta diventando sempre più limitato. “Mentre ci aspettiamo questo dalla destra radicale, la censura si sta diffondendo ampiamente anche nella nostra cultura. Editor che vengono licenziati per la pubblicazione di brani controversi; libri che vengono ritirati per presunta inautenticità; giornalisti cui è vietato scrivere su determinati argomenti; professori che vengono inquisiti per aver citato opere letterarie in classe…”.
Il risultato è quello di “restringere i confini di ciò che si può dire”. Questa “atmosfera soffocante” alla fine danneggerà le cause più vitali del nostro tempo, scrivono. “La restrizione del dibattito, da parte di un governo repressivo o di una società intollerante, fa invariabilmente male a chi manca di potere e rende tutti meno capaci di partecipazione democratica. Il modo per sconfiggere le cattive idee è attraverso l’esposizione, l’argomentazione e la persuasione, non cercando di zittire o allontanarle”. Come scrittori, concludono, “abbiamo bisogno di una cultura che ci lasci spazio alla sperimentazione, all’assunzione di rischi e persino agli errori. Dobbiamo preservare la possibilità del disaccordo in buona fede senza conseguenze professionali”. L’illiberalismo si batte sul terreno liberale, non della censura.

Editoriale
La democrazia e la rivincita del free speech
di Ezio Mauro
La Repubblica, 12 luglio 2020
Abbiamo paura di quel che diciamo, o che possiamo pensare. Dunque ci siamo costruiti dei binari che tengano dritto il corso delle nostre parole, e che ci garantiscano la stazione d’arrivo nel territorio protetto di un linguaggio rispettoso, onesto, tollerante: un modo di ragionare e di argomentare che tutti consideriamo civile, espressione di una società coesa e innocente, che non esiste nella realtà concreta con cui dobbiamo fare i conti nel quotidiano.

Il politicamente corretto ha stufato pure la sinistra. Una moda in declino
di Renato Farina
Libero, 14 luglio 2020
Il linguaggio politicamente corretto, con regole invisibili ma penetranti come l’umidità nelle ossa del vocabolario, è stato inventato – ricorda Ezio Mauro – nelle università americane per fini molto nobili. Doveva servire a difendere le minoranze emarginate dalle prepotenze di chi scarica le proprie pretese di superiorità su neri, omosessuali, islamici, donne, ciechi, sordi, paralitici schiacciandoli sotto una gragnola di parole-pietre. Si è trasformato però, ammette Mauro, nella pretesa di far confluire in una zona grigia e dunque priva di vivacità, di forza, di libertà, i differenti modi di intendere la vita e dunque le differenti opinioni. Per difendere la diversità, si arriva a negare la diversità. E dalla Bibbia sappiamo che dar nome alle cose è la massima espressione della libertà di ogni uomo/donna Sappiamo che le parole possono fare male. Ma metterle nei gulag è da regimi totalitari. I quali assicurano di farlo per il bene del popolo, per preservarlo dai sabotatori.
Ogni regime ha le sue parole tabù e quelle talismano. Il regime avanzante dice negro guai, nero sì, anzi meglio evitare e dire africano; bianco si può dire ma solo se è per stigmatizzarne la pretesa di superiorità, forse bisognerà dire come in America “caucasico”, qualunque cosa significhi. Gay si può, frocio solo se chi lo dice è gay, sodomita o pederasta no.
La frontiera del vietato guadagna ogni giorno centimetri. L’allarme scatta in qualunque ambito delle cose quotidiane. L’ultima scoperta è di ieri, prendendo il treno. L’altoparlante in stazione annuncia che «i livelli business ed executive» sono in coda. Dire “classe” crea apartheid, ghettizza e umilia chi prende la carrozza economica, vuoi mettere invece “livello”? Non si dice “classe seconda o economica” ma “livello standard”. Non so se sarà emanato un anatema, e se davanti a una signora o a un signore elegante si potrà elogiame “la clacce”. Non se ne può più. Ogni parola può essere una notizia di reato. Anche quelle riposte in un angolo della mente, ancora informi, magari germogliate nel sonno, sono trattate come un pericolo pubblico dal nostro gendarme interiore. E d si prepara con terrore all’arrivo di qualche app cinese sperimentata ad Hong Kong per smascherare chi le ospita in segreto e non le ha denunciate all’autorità competente per la derattizzazione.
EUNUCO
Il fatto è persino a sinistra si comincia a sentirsi soffocare. Non che si abbia amore sconfinato per il diritto degli altri ad esprimersi secondo i propri canoni. È che se uno non si aggiorna, anche se è il campione dei progressisti e purifica tre volte al giorno la lingua con la candeggina, awerte il rischio crescente di mettere per distrazione il piede su un escremento canino. Peggio ancora, a furia di penitenze linguistiche, l’immacolato si rende conto di essere ormai un eunuco della parola. Si accorge che per timore di urtare con un avverbio i fachiri o con un aggettivo le lottatrici di sumo, soffoca in sé immagini e concetti, li smussa prima ancora di averli partoriti, li fa nascere anemici, tisici, tiepidamente degni solo di essere vomitati.
E così Ezio Mauro ha detto basta. Finiamola. Nei dovuti modi. Senza mai debordare dai canoni interiorizzati del politically correct, ma si percepisce cha avrebbe una gran voglia di lacerare la cortina mielosa subentrata a quella di ferro. Chessò: un porca-vacca liberatorio. Banalizzo? Gente volgare noialtri. Devi fame di strada caro Ezio per entrare nel club, ma è un piccolo passo per te, e un gigantesco balw per la sinistra italiana. È infatti la prima volta che un intellettuale di riferimento di questa area tira una cannonata contro il feticcio che si è mostruosamente ingigantito con la penetrazione anche da noi del movimento “Black Lives Matter” (Le vite dei neri contano) che ha raccolto nel suo ventre, in nome della tolleran * za per i diversi, la caccia allo scalpo dei vivi e dei morti che non si adeguino alla loro intolleranza. Dice ora il direttore emerito di Stampa e di Repubblica che la difesa dei deboli deve potersi affermare senza il mitra di leggi e convenzioni che impediscano le espressioni anche radicalmente avverse. C’è un problema. La famosa “società aperta” teorizzata da Karl Popper ha sempre vissuto di un dogma: tolleranza con tutti meno che con gli intolleranti. Chi decide chi sono gli intolleranti? Come definire un “intollerante”? È facilissimo scivolare nel regime dei pensieri obbligatori. E la società aperta e liberale diventa allora il regno degli ipocriti, con i lager segreti dei diversamente pensanti.
Mauro, sulla prima pagina di Repubblica, si è posto sulla scia del manifesto dei 150 intellettuali pubblicato su Harper s. Costoro hanno scritto: «Abbiamo bisogno di una cultura che lasci spazio a esperienze, rischi e persino errori».
CONCESSIONE
Le firme vanno da Noam Chomsky, linguista e che dunque la sa lunga, a Salman Rushdie, che la sa lunga anche lui, essendo inseguito da una condanna a morte di Khomeini per i suoi “Versi satanici”; all’autrice della saga di Harry Potter, J. K. Rowlings; a Martin Amis, il favoloso autore più anticomunista tra i progressisti anglosassoni. Hanno costoro pesi e appartenenze diverse, ma nessuno di loro è accusabile di essere vicino a razzismo, fascismo o altre categorie da proscrizione che abbondano in Italia e nel mondo per mettere fuori gioco la destra politica o i tradizionalisti cristiani. Interessante: non è che per fare questo manifesto hanno scartato, in base a qualche elenco, gli “impresentabili”?
Mauro chiede che a destra, dinanzi alla concessione del diritto di praticare i campi del dialogo da parte dei 151 (i 150 più Mauro), si mettano insieme anche molti meno intellettuali non-progressisti, diciamo così, pronti a scrivere e firmare un manifesto in cui promettano di non approfittare dell’autorizzazione dei progressisti. Se ci passa una bozza magari, anche senza essere intellettuali, ci mancherebbe, gli diamo un’occhiata. Intanto, visto il peso formidabile che hanno Repubblica ed Ezio Mauro, una bella prova di coerenza attiva aiuterebbe. In questi giorni è in discussione in Parlamento la legge Zan-Boldrini. Essa intende educare il popolo estirpandone, con la minaccia del carcere, l’odio di genere. In pratica si mette fuori legge qualunque espressione avversa ai matrimoni gay, alle adozioni per transgender eccetera Un bel “no, fermatevi” sarebbe gradito.

Una lettera sulla giustizia e il dibattito aperto
Harper’s Magazine, 7 luglio 2020
Le nostre istituzioni culturali sono sotto processo. Le grandi proteste contro il razzismo e per la giustizia sociale stanno portando avanti sacrosante richieste di riforma della polizia, insieme a più ampie rivendicazioni per maggiori equità e inclusività nella nostra società, compresa l’università, il giornalismo, la filantropia e le arti. Ma questa necessaria presa di coscienza ha anche intensificato una nuova serie di atteggiamenti moralisti e impegni politici che tendono a indebolire il dibattito pubblico e la tolleranza per le differenze, a favore del conformismo ideologico. Mentre ci rallegriamo per il primo sviluppo, ci pronunciamo contro il secondo.
Le forze illiberali si stanno rafforzando in tutto il mondo e hanno un alleato potente in Donald Trump, che rappresenta una vera minaccia per la democrazia. Ma non bisogna permettere che la resistenza si irrigidisca intorno a un suo tipo di dogmatismo e coercizione, che i populisti di destra stanno già sfruttando. L’inclusione democratica che vogliamo si può raggiungere solo denunciando il clima intollerante che si è creato da entrambe le parti.
Lo scambio libero di informazioni e idee, la linfa vitale di una società liberale, viene soffocato ogni giorno di più. Se abbiamo imparato ad aspettarcelo dalla destra radicale, la tendenza alla censura si sta diffondendo anche nella nostra cultura: un’intolleranza per le opinioni diverse, l’abitudine alla gogna pubblica e all’ostracismo, e la tendenza a risolvere complesse questioni politiche con una vincolante certezza morale.
Noi sosteniamo l’importanza di una dialettica e di un contraddittorio espressi con forza e anche taglienti, per tutti. Ma è diventato troppo normale sentire richieste di tempestive e dure punizioni in risposta a quelli che vengono percepiti come sbagli di parola o di pensiero. Ed è ancora più preoccupante che i leader delle nostre istituzioni, nel tentativo preoccupato di contenere i danni, decidano punizioni frettolose e sproporzionate invece di piani di riforma più ponderati. Ci sono stati redattori licenziati per aver pubblicato articoli controversi, libri ritirati perché non abbastanza “autentici”; giornalisti a cui è stato vietato scrivere di certi temi; professori che subiscono indagini per aver citato certe opere letterarie a lezione; ricercatori licenziati per aver condiviso uno studio accademico pubblicato su una ricerca scientifica; dirigenti e manager fatti fuori per quelli che a volte sono solo goffi errori.
Qualunque siano le circostanze di ciascun caso, il risultato è che i limiti di quello che si può dire senza timore di ritorsioni si sono assottigliati. Stiamo già pagandone il prezzo, in termini di minore propensione al rischio tra gli scrittori, gli artisti e i giornalisti che sono preoccupati di perdere il lavoro se si allontanano dal consenso generale, o anche solo se non dimostrano sufficiente entusiasmo nel dirsi d’accordo.
Questa atmosfera opprimente finirà per danneggiare le cause più importanti dei nostri tempi. I limiti al dibattito, che dipendano da un governo repressivo o da una società intollerante, finiscono ugualmente per fare del male di più a chi non ha potere, e rendono tutti meno capaci di partecipare alla democrazia. Il modo di sconfiggere le idee sbagliate è mettendole in luce, discutendone, criticandole e convincendo gli altri, non cercando di metterle a tacere. Rifiutiamo di dover scegliere tra giustizia e libertà, che non possono esistere l’una senza l’altra. Come scrittori, abbiamo bisogno di una cultura che lasci spazio alla sperimentazione, all’assunzione di rischi, e anche agli errori. Dobbiamo preservare la possibilità di essere in disaccordo in buona fede, senza timore di catastrofiche conseguenze professionali. Se non difendiamo quello da cui dipende il nostro lavoro, non possiamo aspettarci che lo faccia il pubblico o lo stato.
A Letter on Justice and Open Debate
Harper’s Magazine, 7 July 2020
The below letter will be appearing in the Letters section of the magazine’s October issue. We welcome responses at letters@harpers.org
Our cultural institutions are facing a moment of trial. Powerful protests for racial and social justice are leading to overdue demands for police reform, along with wider calls for greater equality and inclusion across our society, not least in higher education, journalism, philanthropy, and the arts. But this needed reckoning has also intensified a new set of moral attitudes and political commitments that tend to weaken our norms of open debate and toleration of differences in favor of ideological conformity. As we applaud the first development, we also raise our voices against the second. The forces of illiberalism are gaining strength throughout the world and have a powerful ally in Donald Trump, who represents a real threat to democracy. But resistance must not be allowed to harden into its own brand of dogma or coercion—which right-wing demagogues are already exploiting. The democratic inclusion we want can be achieved only if we speak out against the intolerant climate that has set in on all sides.
The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a liberal society, is daily becoming more constricted. While we have come to expect this on the radical right, censoriousness is also spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral certainty. We uphold the value of robust and even caustic counter-speech from all quarters. But it is now all too common to hear calls for swift and severe retribution in response to perceived transgressions of speech and thought. More troubling still, institutional leaders, in a spirit of panicked damage control, are delivering hasty and disproportionate punishments instead of considered reforms. Editors are fired for running controversial pieces; books are withdrawn for alleged inauthenticity; journalists are barred from writing on certain topics; professors are investigated for quoting works of literature in class; a researcher is fired for circulating a peer-reviewed academic study; and the heads of organizations are ousted for what are sometimes just clumsy mistakes. Whatever the arguments around each particular incident, the result has been to steadily narrow the boundaries of what can be said without the threat of reprisal. We are already paying the price in greater risk aversion among writers, artists, and journalists who fear for their livelihoods if they depart from the consensus, or even lack sufficient zeal in agreement.
This stifling atmosphere will ultimately harm the most vital causes of our time. The restriction of debate, whether by a repressive government or an intolerant society, invariably hurts those who lack power and makes everyone less capable of democratic participation. The way to defeat bad ideas is by exposure, argument, and persuasion, not by trying to silence or wish them away. We refuse any false choice between justice and freedom, which cannot exist without each other. As writers we need a culture that leaves us room for experimentation, risk taking, and even mistakes. We need to preserve the possibility of good-faith disagreement without dire professional consequences. If we won’t defend the very thing on which our work depends, we shouldn’t expect the public or the state to defend it for us.
Elliot Ackerman
Saladin Ambar, Rutgers University
Martin Amis
Anne Applebaum
Marie Arana, author
Margaret Atwood
John Banville
Mia Bay, historian
Louis Begley, writer
Roger Berkowitz, Bard College
Paul Berman, writer
Sheri Berman, Barnard College
Reginald Dwayne Betts, poet
Neil Blair, agent
David W. Blight, Yale University
Jennifer Finney Boylan, author
David Bromwich
David Brooks, columnist
Ian Buruma, Bard College
Lea Carpenter
Noam Chomsky, MIT (emeritus)
Nicholas A. Christakis, Yale University
Roger Cohen, writer
Ambassador Frances D. Cook, ret.
Drucilla Cornell, Founder, uBuntu Project
Kamel Daoud
Meghan Daum, writer
Gerald Early, Washington University-St. Louis
Jeffrey Eugenides, writer
Dexter Filkins
Federico Finchelstein, The New School
Caitlin Flanagan
Richard T. Ford, Stanford Law School
Kmele Foster
David Frum, journalist
Francis Fukuyama, Stanford University
Atul Gawande, Harvard University
Todd Gitlin, Columbia University
Kim Ghattas
Malcolm Gladwell
Michelle Goldberg, columnist
Rebecca Goldstein, writer
Anthony Grafton, Princeton University
David Greenberg, Rutgers University
Linda Greenhouse
Rinne B. Groff, playwright
Sarah Haider, activist
Jonathan Haidt, NYU-Stern
Roya Hakakian, writer
Shadi Hamid, Brookings Institution
Jeet Heer, The Nation
Katie Herzog, podcast host
Susannah Heschel, Dartmouth College
Adam Hochschild, author
Arlie Russell Hochschild, author
Eva Hoffman, writer
Coleman Hughes, writer/Manhattan Institute
Hussein Ibish, Arab Gulf States Institute
Michael Ignatieff
Zaid Jilani, journalist
Bill T. Jones, New York Live Arts
Wendy Kaminer, writer
Matthew Karp, Princeton University
Garry Kasparov, Renew Democracy Initiative
Daniel Kehlmann, writer
Randall Kennedy
Khaled Khalifa, writer
Parag Khanna, author
Laura Kipnis, Northwestern University
Frances Kissling, Center for Health, Ethics, Social Policy
Enrique Krauze, historian
Anthony Kronman, Yale University
Joy Ladin, Yeshiva University
Nicholas Lemann, Columbia University
Mark Lilla, Columbia University
Susie Linfield, New York University
Damon Linker, writer
Dahlia Lithwick, Slate
Steven Lukes, New York University
John R. MacArthur, publisher, writer
Susan Madrak, writer
Phoebe Maltz Bovy, writer
Greil Marcus
Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center
Kati Marton, author
Debra Mashek, scholar
Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago
John McWhorter, Columbia University
Uday Mehta, City University of New York
Andrew Moravcsik, Princeton University
Yascha Mounk, Persuasion
Samuel Moyn, Yale University
Meera Nanda, writer and teacher
Cary Nelson, University of Illinois at Urbana-Champaign
Olivia Nuzzi, New York Magazine
Mark Oppenheimer, Yale University
Dael Orlandersmith, writer/performer
George Packer
Nell Irvin Painter, Princeton University (emerita)
Greg Pardlo, Rutgers University – Camden
Orlando Patterson, Harvard University
Steven Pinker, Harvard University
Letty Cottin Pogrebin
Katha Pollitt, writer
Claire Bond Potter, The New School
Taufiq Rahim
Zia Haider Rahman, writer
Jennifer Ratner-Rosenhagen, University of Wisconsin
Jonathan Rauch, Brookings Institution/The Atlantic
Neil Roberts, political theorist
Melvin Rogers, Brown University
Kat Rosenfield, writer
Loretta J. Ross, Smith College
J.K. Rowling
Salman Rushdie, New York University
Karim Sadjadpour, Carnegie Endowment
Daryl Michael Scott, Howard University
Diana Senechal, teacher and writer
Jennifer Senior, columnist
Judith Shulevitz, writer
Jesse Singal, journalist
Anne-Marie Slaughter
Andrew Solomon, writer
Deborah Solomon, critic and biographer
Allison Stanger, Middlebury College
Paul Starr, American Prospect/Princeton University
Wendell Steavenson, writer
Gloria Steinem, writer and activist
Nadine Strossen, New York Law School
Ronald S. Sullivan Jr., Harvard Law School
Kian Tajbakhsh, Columbia University
Zephyr Teachout, Fordham University
Cynthia Tucker, University of South Alabama
Adaner Usmani, Harvard University
Chloe Valdary
Helen Vendler, Harvard University
Judy B. Walzer
Michael Walzer
Eric K. Washington, historian
Caroline Weber, historian
Randi Weingarten, American Federation of Teachers
Bari Weiss
Sean Wilentz, Princeton University
Garry Wills
Thomas Chatterton Williams, writer
Robert F. Worth, journalist and author
Molly Worthen, University of North Carolina at Chapel Hill
Matthew Yglesias
Emily Yoffe, journalist
Cathy Young, journalist
Fareed Zakaria
Institutions are listed for identification purposes only.

Corso intensivo sul politicamente corretto
di Marcello Veneziani
Inchiostronero.it, 4 marzo 2020
Ma cos’è esattamente il politically correct? Lo citiamo ogni giorno senza magari coglierne tutto il significato. Provo a offrire una breve guida, un sunto critico e un succo concentrato.
Per cominciare, il politicamente corretto è un canone ideologico e un codice etico che monopolizza la memoria storica, il racconto globale del presente e prescrive come comportarsi. Nasce dalle ceneri del ’68, cresce negli Usa e nel nord Europa, si sviluppa sostituendo il comunismo con lo spirito radical (o radical chic secondo Tom Wolfe [1]) e sostituendo l’egemonia marxista e gramsciana col “bigottismo progressista” (come lo definisce Robert Hughes [2]). Rompe i ponti col sentire popolare, non rappresenta più il proletariato, almeno quello delle nostre società; separa i diritti dai doveri e li lega ai desideri, rigetta i limiti e i confini personali, sociali, sessuali e territoriali, nel nome di una libertà sconfinata, sostituisce la natura col volere dei soggetti.
E sostituisce l’anticapitalismo con l’antifascismo, aderendo all’establishment tecno-finanziario di cui intende accreditarsi come il precettore.
Il politically correct è una forma di riduzionismo ideologico che produce le seguenti fratture:
a) riduce la storia, l’arte, il pensiero e la letteratura al presente, nel senso che tutto quel che è avvenuto va letto, riscritto e giudicato alla luce del presente, in base ai canoni corretti e ai generi.
b) riduce la realtà al moralismo, nel senso che rifiuta le cose come sono e le riscrive come dovrebbero essere in base al suo codice etico e gender.
c) riduce la rivoluzione vanamente sognata nel Novecento e nel ’68 alla mutazione lessicale, nel senso che non potendo cambiare la realtà delle cose e l’imperfezione del mondo si cambiano le parole per indicarle, adottando un linguaggio ipocrita e rococò.
d) riduce le differenze ideologiche a una superideologia globale o pensiero unico, che se si nega come tale.
Per il politically correct la realtà, la natura, la famiglia, la civiltà finora conosciute, vissute e denominate, sono sbagliate. Il politicamente corretto è il moralismo in assenza di morale, il razzismo etico in assenza di etica, il bigottismo in assenza di religione. Ecco, in breve il politically correct.
Alle quattro riduzioni di cui sopra, il politically correct aggiunge una serie di sostituzioni:
1) sostituisce il sentire comune, l’interesse popolare, il legame famigliare e comunitario con la priorità assegnata ad alcune diversità e minoranze, ritenute discriminate o emarginate. E adotta uno schema vittimistico: non sono i grandi, gli eroi, i geni a meritare onori, strade, elogi unanimi ma le vittime (retaggio cristiano, notava René Girard [3]).
2) sostituisce la preferenza per ciò che è nostrano – la nostra identità, le nostre tradizioni, il nostro modo di vedere, la nostra civiltà e religione, i nostri legami e le nostre appartenenze – con la preferenza per tutto ciò che è remoto – le culture e i costumi altrui, i migranti, i mondi lontani, le ragioni di chi viene da fuori (quella che Roger Scruton chiamava oicofobia).(T.P.I)
3) sostituisce l’antica dicotomia tra il compatriota e lo straniero, o quella politico-militare tra l’amico e il nemico con la dicotomia tra il Bene e il Male, per cui chi non è allineato al canone non è uno che la pensa differentemente né un avversario da combattere ma è il male assoluto da sradicare e annientare. Col nemico si può arrivare a patti, lo puoi sconfiggere e sottomettere; il Male no, va cancellato e dannato nella memoria.
4) sostituisce l’oppositore, il dissidente, l’antagonista col razzista, nemico dell’umanità, del progresso e della ragione. E gli riserva un trattamento a metà strada fra la patologia e la criminologia, accusandolo di fobie: è omofobo, sessuofobo, islamofobo, xenofobo, e via dicendo. Di conseguenza non c’è contesa con lui, ma lo si isola tramite cordone sanitario, lo si affida alla profilassi medica e prevenzione nelle scuole, università, media; o quando il caso è conclamato, lo si affida ai tribunali e alla condanna. Il pregiudizio ideologico riduce i dissidenti al rango di pregiudicati, ovvero di condannati dalla storia, dal progresso, dalla ragione. Non conflitti ma bombe umanitarie, operazioni di polizia culturale o internazionale.
Per il politically correct la realtà, la natura, la famiglia, la civiltà finora conosciute, vissute e denominate, sono sbagliate. Il politicamente corretto è il moralismo in assenza di morale, il razzismo etico in assenza di etica, il bigottismo in assenza di religione. Ecco, in breve il politically correct.
Postilla finale dedicata a come si reagisce. Chi rifiuta l’imposizione del politicamente corretto e reagisce con l’insulto contro i suoi totem e i tabù, entra a pieno titolo nel suo gioco e ne conferma l’assunto e l’assetto: visto che avevamo ragione a dire che il razzismo, l’odio, l’intolleranza albergano nei nostri nemici? È una forma stupida e istintiva di risposta che rafforza il politically correct. Non migliore sul piano dell’efficacia è la risposta opposta, mimetica, di chi sta al gioco, asseconda, tace o compiace, rispondendo con ipocrisia all’ipocrisia parruccona del politicamente corretto. Anche in questo caso si resta sul suo terreno, si fa il suo gioco, si mira a una sopravvivenza immediata e individuale pregiudicando in prospettiva una visione alternativa più ampia.
Spesso ci si limita a opporre all’ideologia la realtà, alla sua narrazione la vita pratica. Invece, partendo da quella, si dovrebbe tentare lo sforzo opposto: smontare i loro tic, totem e tabù, usando l’arma dell’intelligenza, del paragone culturale, del senso critico e ironico. E indicando percorsi alternativi, letture diverse, altre priorità. Qui, purtroppo, l’intolleranza degli uni s’imbatte nell’insipienza degli altri, frutto di ignoranza, ignavia e indifferenza.
Se il politically correct domina, è anche perché non trova adeguate risposte. Solo imprecazioni e silenzi. La città è nelle mani degli stolti, dissero al sovrano i messi di una città in rivolta; ma i “savi” nel frangente che facevano, chiese loro il Re Carlo d’Angiò?
Domandiamocelo pure noi.
[1] Tom Wolfe, all’anagrafe Thomas Kennerly Wolfe Jr. (Richmond, 2 marzo 1930 – New York, 14 maggio 2018), è stato un saggista, giornalista, scrittore e critico d’arte statunitense. Nel 1965 pubblica il libro The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, composta dalla raccolta di alcuni suoi articoli. Anche il successivo The Pump House Gang è una raccolta di articoli. Nel 1970 pubblica Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, un libro composto da due articoli già pubblicati sul New York Magazine, dove per la prima volta conia il termine radical chic. Nel corso del decennio pubblica altri libri, tra i quali The Painted Word (una forte critica verso il mondo dell’arte) e The Right Stuff, grazie al quale ha ottenuto il National Book Award. Il tono mordace dei suoi articoli, il suo linguaggio vivace e la penetrazione psicologica degli ambienti sociali descritti, fanno di Tom Wolfe un personaggio famoso e apprezzato, uno tra i più grandi reporter americani.
[2] Robert Studley Forrest Hughes (Sydney, 28 luglio 1938 – New York, 6 agosto 2012) è stato un critico d’arte e saggista australiano, che ha vissuto per oltre trent’anni a New York. «È una vera fortuna scoprire una seconda città oltre la propria che diventi una vera città natale… Una quarantina di anni fa ho avuto un colpo di fortuna: ho incontrato Barcellona» (Robert Hughes, Barcellona l’incantatrice, 2005)
[3] René Girard (Avignone, 25 dicembre 1923 – Stanford, 4 novembre 2015) è stato un antropologo, critico letterario e filosofo francese. Il suo lavoro appartiene al campo dell’antropologia filosofica e ha influssi su critica letteraria, psicologia, storia, sociologia e teologia. È stato professore di letteratura comparata presso la Stanford University (Stati Uniti) fino al momento del ritiro. Cattolico, ha scritto diversi libri, sviluppando l’idea che ogni cultura umana è basata sul sacrificio come via d’uscita dalla violenza mimetica (cioè imitativa) tra rivali. Le sue riflessioni si sono indirizzate verso tre idee principali: il desiderio mimetico, il meccanismo del capro espiatorio, la capacità del testo della Bibbia di svelare sia l’uno che l’altro.
Articoli collegati
– La dittatura del relativismo e il conflitto tra due visioni del mondo – 13 luglio 2020
– Testo unificato Zan “anti-omotransfobia”: perché è liberticida e discriminatorio – 13 luglio 2020
– Si inginocchiano a tutto e a tutti, quelli che non credono in Dio. “Chi rifiuta Dio finisce per credere negli idoli” (Benedetto XVI) – 12 luglio 2020
– In cui credo – 10 luglio 2020
– Campagna #RestiamoLiberi contro Disegno di legge liberticida sull’omotransfobia. Nota del Vescovo di Trieste – 6 luglio 2020
– La legge liberticida sull’omotransfobia è il maggiore attacco dal 1945 alla libertà di pensiero, opinione ed espressione – 2 luglio 2020