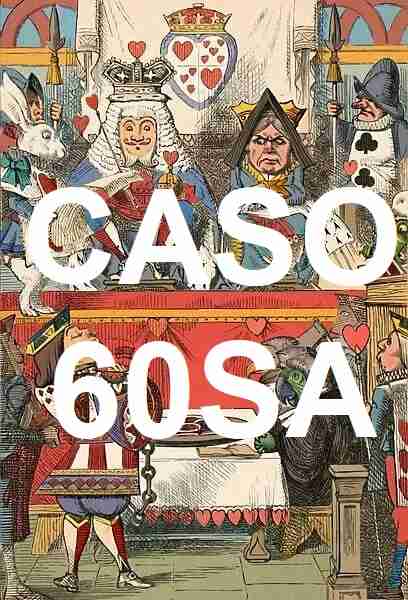Il funerale non è un servizio come un altro: la Chiesa mostri il suo volto materno

Poco tempo fa è morta una donna di 47 anni che conoscevo bene perché entrambe abbiamo fatto parte della stessa associazione di volontariato. Un brutto male l’ha messa a dura prova per dieci anni, obbligando lei a una vita sempre più restrittiva e le sue due figlie a crescere in fretta.
Un brutto male, che però questa donna ha affrontato con umiltà straordinaria fino alla fine. Tanto è vero che il suo ultimo pensiero, affidato ai social, è stato: ‘Non dimenticare mai di ringraziare la vita per ciò che hai, anche in tempi difficili’. Esattamente il giorno dopo avrebbe avuto l’ennesima crisi e sarebbe morta.
Con la sua grinta, con quella voglia di vivere e di far dono del suo tempo (e, negli ultimi mesi, anche del suo dolore sempre più acuto), mi è stata sempre di grande esempio.
Mi sono commossa, il giorno del funerale, ripensando alla sua vita. Il brano del Vangelo scelto per l’ultimo saluto è stato quello in cui Gesù parla del giudizio e dice: ‘Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi’ (Mt 25, 31-40).
Nessuno sa cosa avviene quando un’anima si presenta al cospetto di Dio, ma è stato bello immaginare che quelle parole siano state pronunciate dal Signore proprio per lei. La chiesa era gremita: è così, quando lasci un segno. Ed è così quando la morte si presenta troppo presto. Eppure, non ho potuto non provare un po’ di tristezza vedendo come la funzione del funerale sia vissuta, in alcuni casi, come ‘un servizio’ alla stregua di tanti altri.
Non sta a me giudicare nessuno: né la comunità (non si trattava neppure della mia parrocchia), né il sacerdote che ha celebrato, ma sento davvero l’urgenza di una riflessione che ci faccia mettere in discussione come realtà ecclesiali.
Quando muore una donna di 47 anni, piena di qualità apprezzabili, dopo una lunga malattia, con due figlie giovani (una poco più che bambina) la Chiesa è chiamata a portare la carezza di Cristo e una speranza che oltrepassa le certezze di questo mondo. È chiamata a farsi carico delle domande che possono assalire delle persone sgomente, che siano vicine o lontane dalla fede.
Tra quelle mura c’era gente che frequenta la Chiesa solo in occasioni simili. E che in simili occasioni con molte probabilità si limiterà a imprecare contro Dio, perché ‘porta via solo le persone migliori’.
Dobbiamo fare di tutto, come comunità, perché chi entra quasi per caso e pieno di rabbia, scopra poi la dolcezza di Dio, ne senta nostalgia e abbia voglia di tornare. Non abbiamo bisogno di omelie impersonali, svincolate dal contesto e noiose. Non abbiamo bisogno che il sacerdote al termine della celebrazione si limiti a stringere la mano ai famigliari, per poi congedarsi in fretta.
Credo che noi cristiani dobbiamo essere in grado di fare di più, o meglio di essere di più. I primi seguaci di Gesù si riconoscevano perché si volevano bene. Sappiamo noi considerarci veramente fratelli? Le nostre comunità sono specchio di questo amore o sono luoghi in cui regnano indifferenza e formalità?
Forse, come Chiesa dobbiamo offrire di più che una stretta di mano ad una ragazzina che ha perso la madre a quattordici anni. I giovani lamentano proprio questo: sentono il bisogno di una Chiesa più prossima. Che sappia far suo il dolore dei suoi figli.
Il mondo grida forte le sue bugie e in ogni dove ci sono dati motivi per perdere la speranza. Dove siamo noi che abbiamo conosciuto un Dio risorto? Siamo in grado di dar ragione della speranza che è in noi? Siamo capaci di dire a quella ragazzina, probabilmente delusa e arrabbiata col Cielo per aver perso una madre così presto: ‘Ti va di tornare per parlare un po’?’
Siamo in grado di tendere l’orecchio ‘ai fedeli’ (che così fedeli non sono più), oltre a riempirli di parole – talvolta poco comprensibili in un mondo che è cambiato? Non voglio far la moralista, non voglio attaccare la Chiesa (la amo profondamente, perché so che è lì che Gesù ha scelto di rimanere!). Vorrei solo che ci facessimo tutti un esame di coscienza e ci chiedessimo se sappiamo chinarci sull’uomo caduto e picchiato come ha fatto il samaritano del Vangelo.
Le associazioni di volontariato, non legate in alcun modo alla Chiesa, quel giorno hanno mostrato grande vicinanza alla famiglia intera e hanno continuato a farlo anche dopo. La Chiesa sa mostrare empatia? Sa lasciare quell’impronta che è la presenza di Dio? O come i sacerdoti della parabola, guarda un attimo e poi passa oltre?