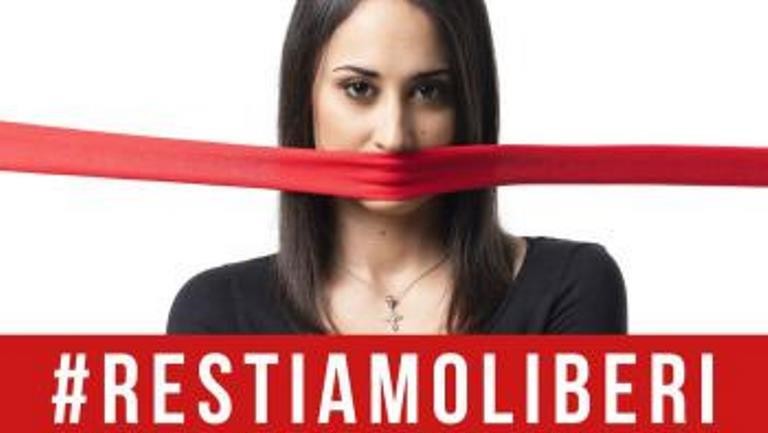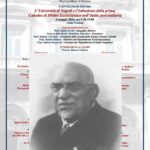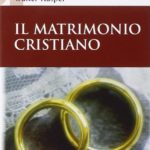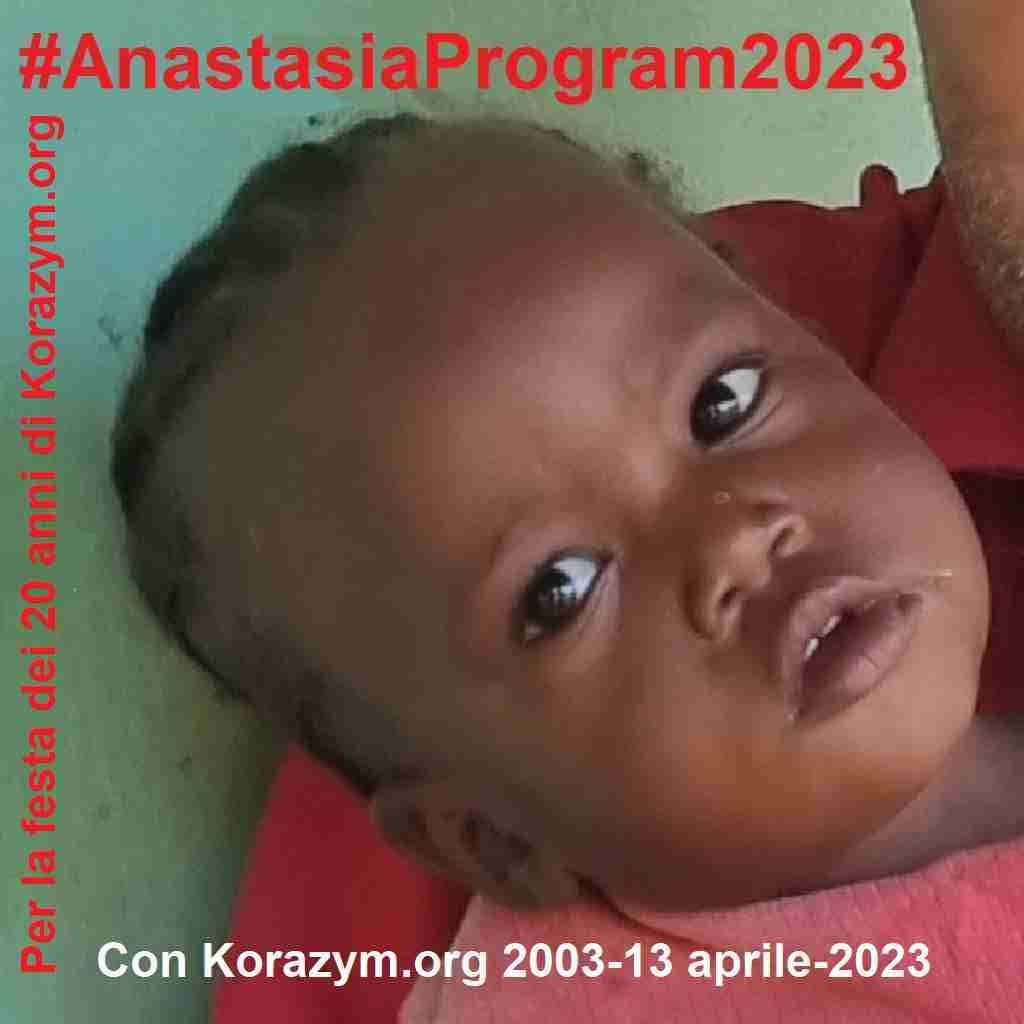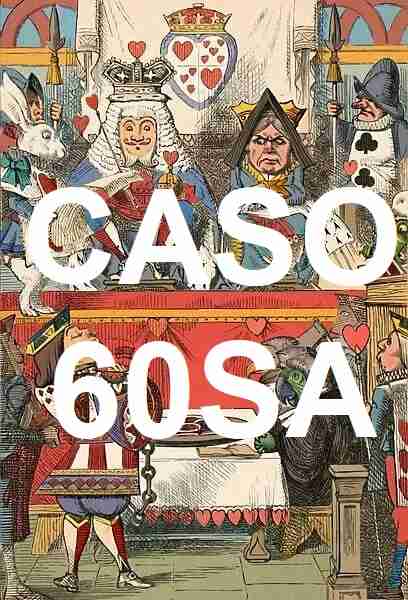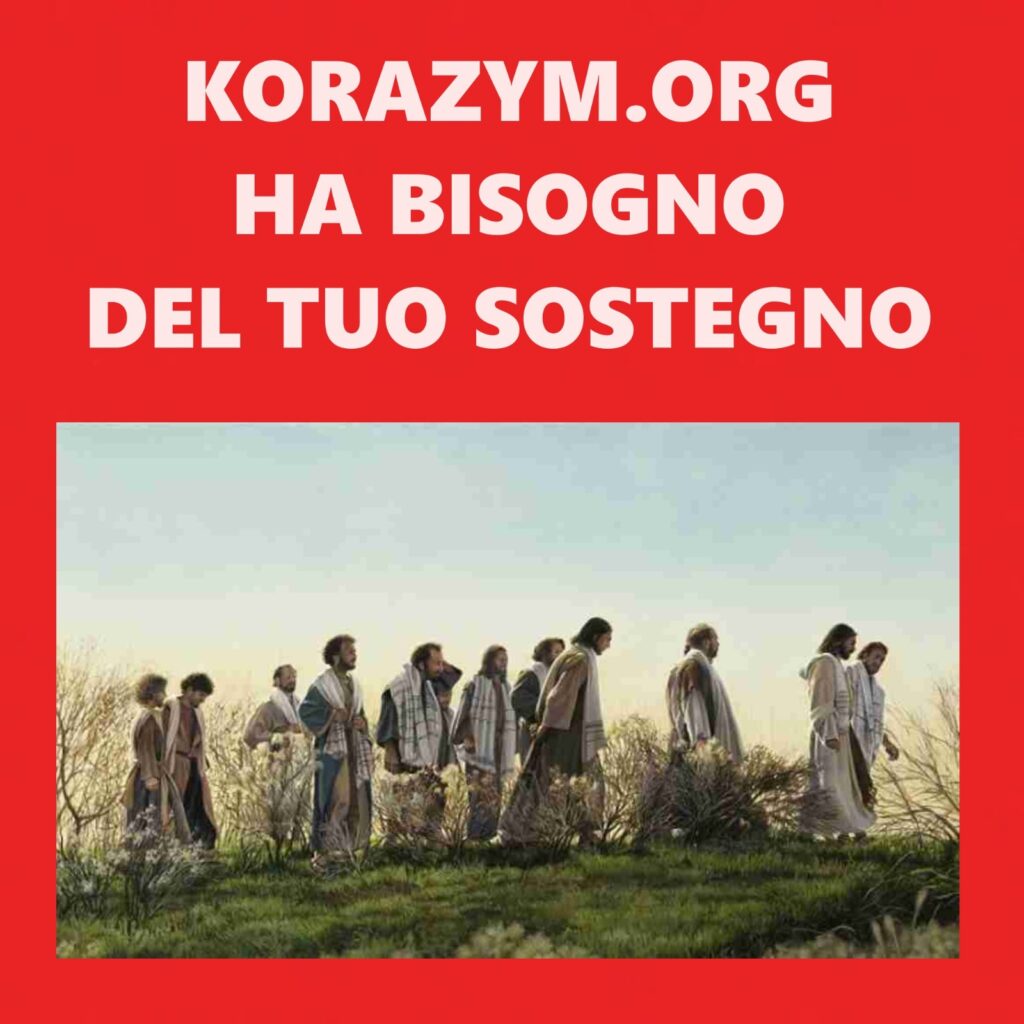Tag Archives: Relazioni
Impostori di sabbia
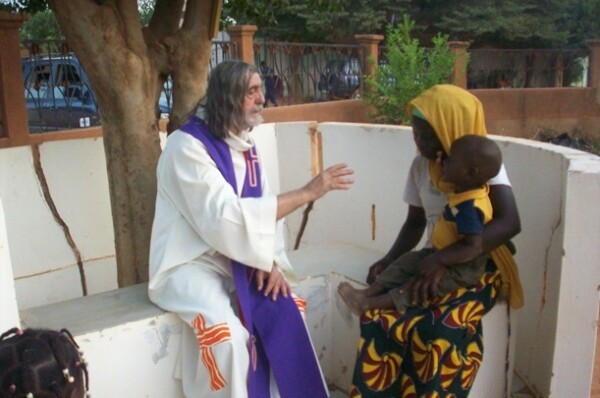
Eppure il cambiamento era dietro l’angolo. Il mondo vecchio stava scomparendo e bastava una spallata per buttarlo giù. Erano gli anni operai delle assemblée, delle 150 ore retribuite in fabbrica per la licenza media e il testo faro di don Milani ‘Lettera a una professoressa’. Il terrorismo e le manipolazioni della sedicente rivoluzione proletaria. Il sospetto, col tempo, che tutto fosse giocato d’avanzo e che l’italico Paese, colonia degli Stati Uniti Vaticani, divenne preda scelta di manovre eversive delle stragi che avrebbero insanguinato banche, piazze, treni e stazioni. Credevamo che il cambiamento fosse una questione di stagioni.
Facciamo la pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno a Milano

Sabato 10 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13, nella sede di Caritas Ambrosiana (via San Bernardino 4, Milano) si terrà il Convegno Mondialità dal titolo ‘Facciamo la pace? – Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno’, promosso da Caritas Ambrosiana insieme agli Uffici per la Pastorale migranti e per la Pastorale missionaria della Diocesi di Milano.
La Fondazione ‘Patrizio Paoletti’ analizza le emozioni dei giovani

A fine ottobre alla Biblioteca della Camera dei Deputati la Fondazione ‘Patrizio Paoletti’ ha presentato il report ‘Mai più soli. Focus adolescenza: sfide e risorse positive nel post-pandemia’, facente parte del progetto ‘Prefigurare il futuro’, come approccio neuro-psicopedagogico di intervento a favore degli adolescenti nelle scuole italiane, e gli studi di ricerca condotti in collaborazione con l’Università di Padova che fotografano le problematiche che stanno mettendo a rischio il benessere degli adolescenti.
Eliana Gagliardoni fotografa gli eremiti nella città
Patriarca Pizzaballa: da Gerusalemme un invito a credere alla Resurrezione

“In questo giorno ti affidiamo, Signore, la città di Gerusalemme, prima testimone della tua Risurrezione. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l’auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la Regione”.
Papa Francesco: la testimonianza dipende dalla fede professata

“Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua. Tornano alla mente le parole di san Francesco d’Assisi: ‘Laudato si’ mi’ Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et pretiosa et casta’. In queste parole semplici sentiamo la bellezza del creato e la consapevolezza delle sfide che implica il prendersene cura. In questi giorni si svolge a New York la seconda Conferenza dell’Acqua dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Papa Francesco ribadisce la necessità della cura delle relazioni
Venezia celebra la festa della Salute: dare valore alla maternità

Lunedì 21 novembre Venezia ha celebrato la festa della Madonna della Salute, la cui devozione è religiosa ma anche civile, fin da quando la Serenissima la istituì nel XVII secolo per ringraziare la Madonna di aver liberato la città dalla pestilenza che l’aveva duramente colpita. Ecco perché il patriarca, ricordando il bene comune di un tempo, ha invocato quello necessario per il presente.
Papa Francesco ai giovani: la Chiesa ha bisogno di voi

Continuando il viaggio apostolico nel Bahrain papa Francesco ha incontrato nella scuola del ‘Sacro Cuore’ i giovani, accolto con grande festa e dalla direttrice suor Roselyn Thomas, che lo ringrazia: “Esprimiamo la nostra ammirazione e l’apprezzamento per il Suo umile servizio di guida amorevole verso la pace e l’armonia, ed anche per i passi coraggiosi che ha compiuto in questa direzione”.
Il vescovo Paul Hinder: i cristiani in Bahrein sperano di essere rafforzati dal Papa

Fino a domenica 6 novembre papa Francesco si recherà in Barhain, partecipando anche al ‘Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence’ e celebrerà una messa solenne al ‘Bahrain National Stadium’ sabato 5 novembre ‘alla quale i cattolici del Bahrain e delle altre nazioni del vicariato del Nord Arabia sono invitati a partecipare’, come ha sottolineato mons. Paul Hinder, amministratore apostolico dell’Arabia Settentrionale.