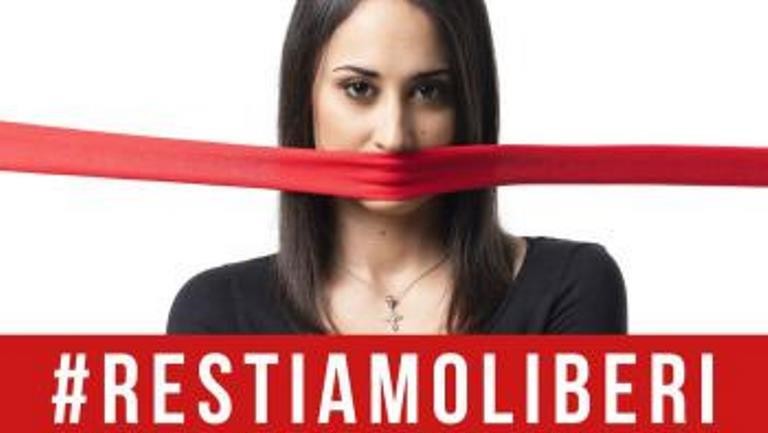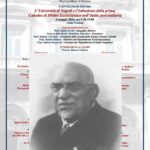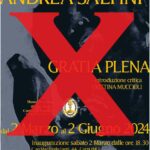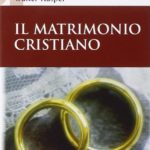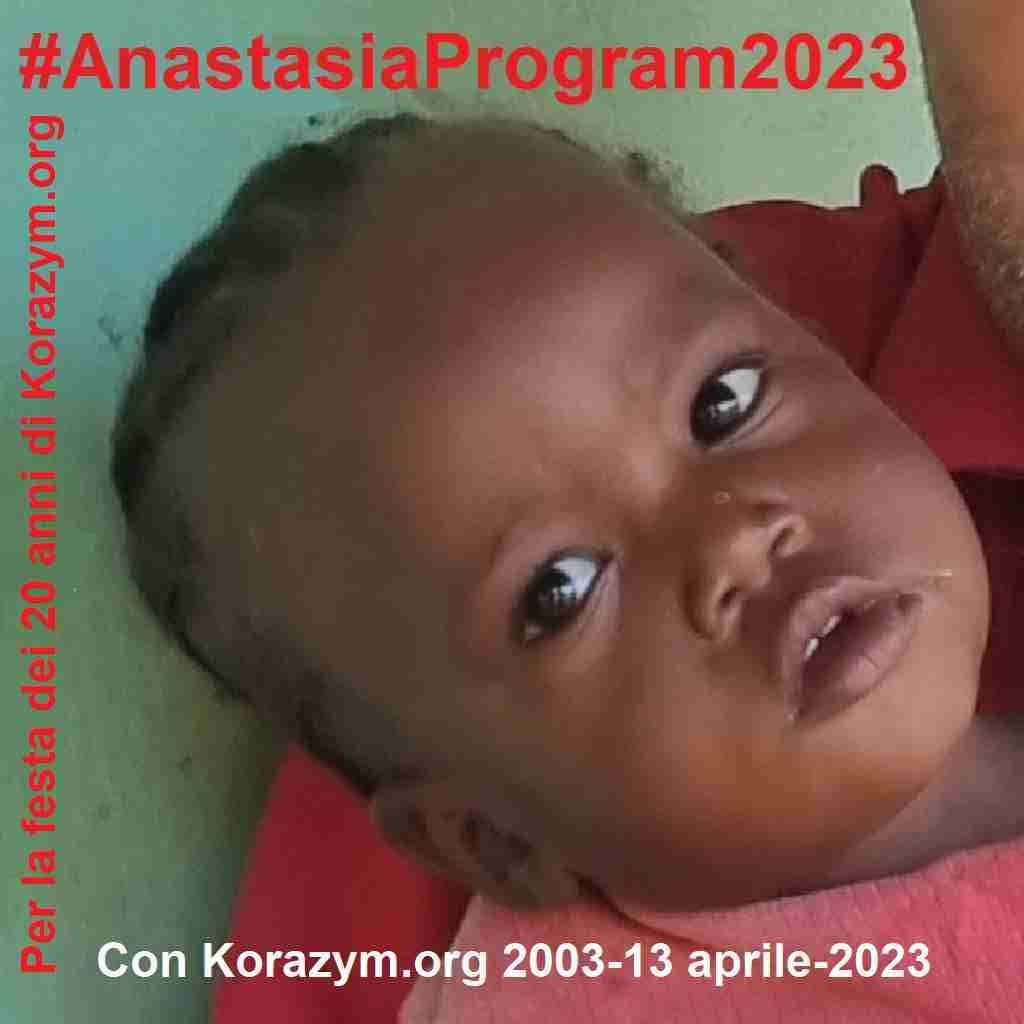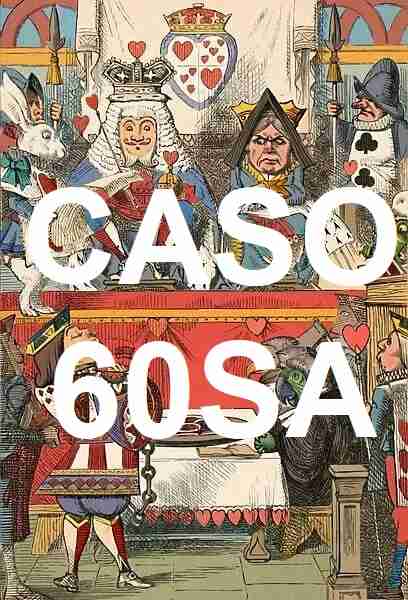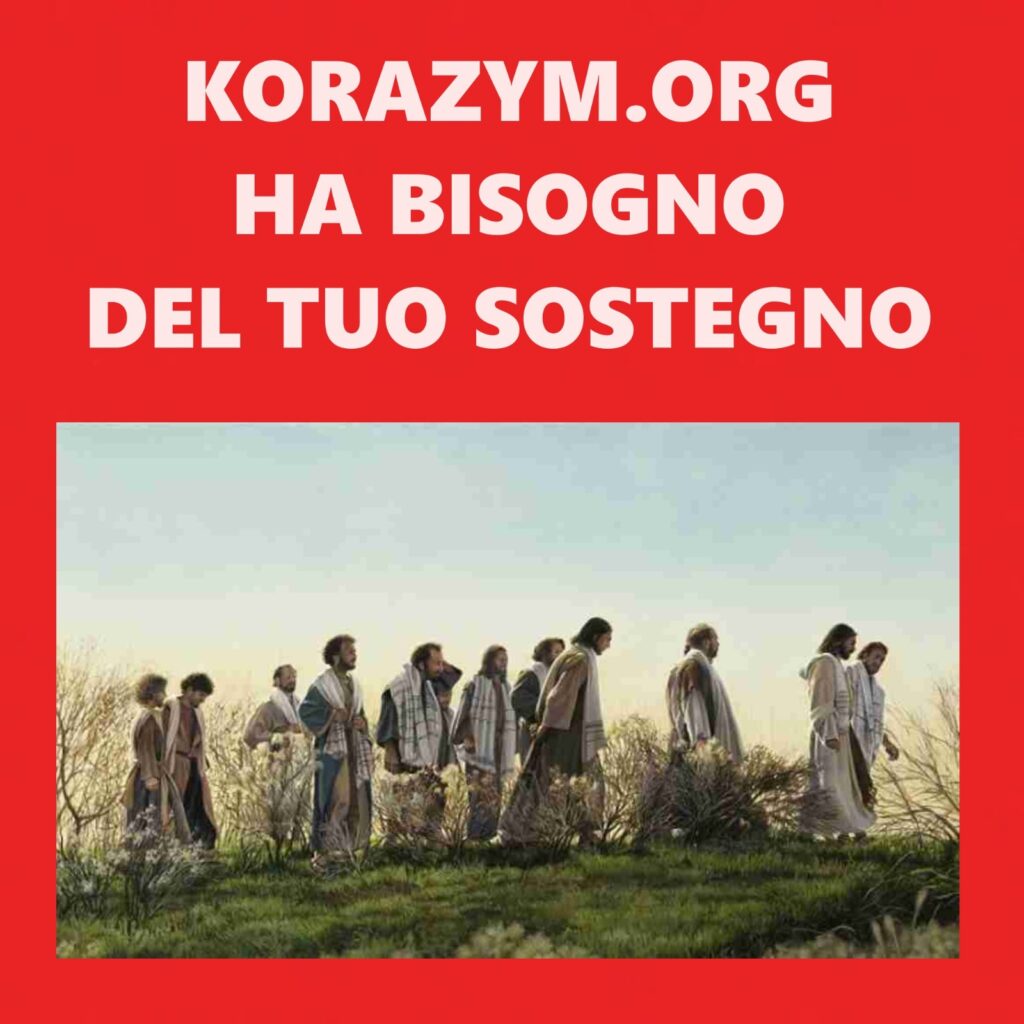Tag Archives: Missione
Firenze ha un nuovo vescovo

La diocesi di Firenze ha un nuovo arcivescovo, mons. Gherardo Gambelli, che è nato a Viareggio ed ordinato presbitero nel 1996, cappellano del carcere di Sollicciano dallo scorso anno quando è rientrato a Firenze dopo 12 anni trascorsi come missionario in Ciad, che ha ringraziato il papa per la nomina: “Sento di poter dire che la scelta di un prete di Firenze è un segno grande di stima e di fiducia da parte del Vescovo di Roma nei confronti di tutta la nostra diocesi”.
Inoltre ha aggiunto che tale nomina vescovile è una chiamata di Dio: “Nel dare la mia disponibilità al Papa, accettando la mia nomina, ho percepito una chiamata di Dio a rendermi ancora più disponibile per sdebitarmi del dono immenso del Vangelo ricevuto prima e dopo la mia ordinazione sacerdotale. Le belle testimonianze di fede rese da parte di tante persone incontrate durante il mio servizio pastorale mi hanno fatto comprendere progressivamente che, nella logica del Vangelo, il modo migliore per custodire i doni ricevuti sia quello di condividerli. Gli anni passati in Africa me lo hanno ulteriormente confermato”.
Ha sottolineato la coincidenza con la domenica in cui si legge la parabola del buon Pastore: “La Provvidenza di Dio ha voluto che l’annuncio della mia nomina cadesse nella settimana che precede la quarta domenica di Pasqua che per noi cattolici è la domenica del Buon Pastore. Ascolteremo le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10: ‘Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare’. E’ Lui il vero pastore della Chiesa, il modello della scelta evangelizzatrice che ci spinge ad andare verso le periferie geografiche ed esistenziali nel nostro impegno missionario”.
Un saluto anche per le altre confessioni religiose, ricordando il fruttuoso dialogo interreligioso intrapreso dalla diocesi: “Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle delle altre confessioni cristiane, i membri della comunità ebraica e musulmana, e di altre religioni presenti sul territorio della nostra Diocesi di Firenze. La bella tradizione di impegno nel dialogo ecumenico e nel dialogo interreligioso della parrocchia della Madonna della Tosse, di cui sono stato parroco quest’anno, mi ha permesso di incontrare e di conoscere personalmente il Rabbino, l’Imam e diversi pastori delle Chiese di Firenze con i quali sono nate promettenti amicizie che spero di poter rafforzare nel tempo”.
Ed ha ribadito una collaborazione della diocesi con le autorità civili: “Saluto le autorità e le istituzioni della città, esprimendo la mia ferma volontà di proseguire nella collaborazione ‘gomito a gomito’ per la costruzione di una società più giusta e solidale, nell’attenzione e nel rispetto della dignità di ogni persona, soprattutto dei più poveri ed esclusi. Davanti alla minaccia dell’espansione delle guerre nel mondo, ci sentiamo più che mai interpellati alla responsabilità di lavorare con più coraggio e tenacia per la pace, che si costruisce in maniera artigianale, nell’attenzione ai gesti quotidiani di perdono e riconciliazione”.
Infine un saluto per i detenuti del carcere di Sollicciano, nel quale è stato cappellano, con il proponimento di non perdere l’abitudine di visitarli: “Vorrei concludere rivolgendo un ultimo saluto ai fratelli e alle sorelle detenuti, particolarmente quelli e quelle della casa circondariale di Sollicciano, in cui ho svolto il mio ministero come cappellano durante quest’anno pastorale. Anche se non potrò continuare a visitarvi regolarmente, non dimenticherò le parole della Scrittura che dice: ‘Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere’. Con l’aiuto del Signore, mi impegnerò come Vescovo a essere attento alle vostre necessità, come a quelle di tanti fratelli e sorelle spesso dimenticati e scartati dalla nostra società”.
Ha concluso il saluto alla diocesi con l’affidamento del suo servizio alla Madonna ed ai santi: “Nel dire il mio sì alla volontà di Dio, mi affido all’intercessione di Maria santissima madre della Chiesa, a quella dei santi Vescovi Zanobi e Antonino, del Venerabile Elia Dalla Costa, dei Santi e della Sante della Chiesa fiorentina, perché mi aiutino a fidarmi sempre più della Provvidenza del Signore, capace di far concorrere tutto al bene. Certo della preghiera e del sostegno di voi qui presenti e di tanti fratelli e sorelle, proseguiamo con fiducia il nostro cammino, tenendo fisso lo sguardo sul Signore che libera dal laccio il nostro piede, perché è capace di amarci sempre e nuovamente di un amore infinito e incrollabile”.
Nell’annuncio per il nuovo vescovo della città il card. Giuseppe Betori ha ringraziato il papa per la nomina di un vescovo ‘fiorentino’: “Sono molto contento di questa scelta del papa che nomina un vescovo fiorentino, 87esimo vescovo fiorentino sulla cattedra di san Zanobi e sant’Antonino. La scelta del papa cade su un prete fiorentino, che conosce bene la nostra diocesi: qui è diventato prete. Da figlio di questa diocesi, diventerà padre: questo cambia molto nel suo rapporto nei nostri confronti”.
Inoltre ha ricordato i suoi servizi svolti sempre per amore di Dio: “La radice della sua persona l’ho sempre individuata nell’amore per la Parola di Dio. Ha fatto molte cose, ha avuto molte funzioni ma questi sono i frutti di una radice che è nel legame con la Parola di Dio, letta e studiata, che lo ha plasmato nella sua identità sacerdotale. Questa capacità di attingere nella Parola di Dio lo abbiamo visto in due momenti della sua vita, quando è stato vicario parrocchiale a Santo Stefano in Pane a Rifredi e parroco dell’Immacolata a Montughi.
Lì avvenne una cosa in cui c’entro anch’io: mi chiese di partire missionario come sacerdote ‘fidei donum’ a servizio di una chiesa dell’Africa, la diocesi di Ndjamena. Lì ha insegnato Sacra Scrittura, è stato parroco, ha servito negli ospedali, nel carcere. Poi ha seguito un nuovo passaggio: dalla diocesi id Ndjamena è nato il vicariato apostolico di Mongo. Si è trasferito lì, servendo come parroco e continuando il suo servizio al carcere. Periferie geografiche, umane hanno dato forma al suo carattere, al suo sacerdozio.
Poi, tornato a Firenze, in obbedienza, ha accettato di fare quello che gli ho chiesto. Tre cose: la nomina mette in rilievo la sua funzione di parroco alla Madonna della Tosse, altra parrocchia significativa. Ma gli ho chiesto di fare anche il vicedirettore spirituale al seminario accanto a mons. Carolla e il cappellano del carcere di Sollicciano. Dimensione spirituale, dimensione pastorale, servizio alle persone. Tutto questo non lo deve abbandonare ma ripensare in una forma nuova che è quella del governo della diocesi. Per questo gli siamo vicini e chiedo a tutti voi di essere collaboratori nei suoi confronti. Questo è come lo conosco, e per questo ringrazio il Papa che ce lo dà come arcivescovo”.
Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha inviato un messaggio di benvenuto al nuovo arcivescovo di Firenze, sottolineando come alla guida della Chiesa fiorentina arrivi un toscano, 40 anni dopo la figura di Silvano Piovanelli, ma ha anche definito significativo il fatto che il nuovo arcivescovo sia un missionario, la cui sua esperienza di fede è maturata in Africa, in Ciad; “Lo spirito missionario, l’attenzione agli ultimi, ai più poveri, ai più fragili, saranno un tesoro prezioso per la Chiesa, ma anche un grande dono per tutta la comunità fiorentina e toscana”.
Infine il presidente della regione toscana ha rivolto un saluto al card. Giuseppe Betori, che ha guidato la diocesi fiorentina dal 2008 con ‘sapienza e cura’.
(Foto: arcidiocesi di Firenze)
Terza domenica di Pasqua: Essere testimoni veri del Risorto
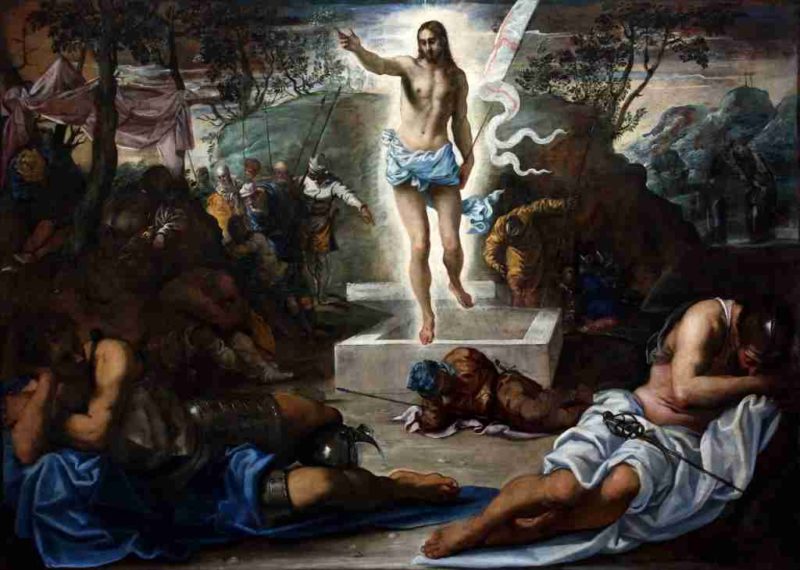
‘Di questo voi siete testimoni’. E’ una consegna ufficiale che Gesù dà ai suoi discepoli. Gli Apostoli capirono abbastanza bene la loro missione, non si scoraggiarono, compresero che il loro compito sarebbe stato uno solo: Rendere testimonianza di ciò che avevano visto compiersi in Gesù di Nazareth. Il termine ‘apostolo’ divenne sinonimo di testimone della risurrezione. Il Maestro divino si presenta ai suoi, che aveva scelto, rassicurandoli: non sono un fantasma, avvicinatevi, toccatemi e poi mangia con loro per tranquillizzarli. In tutto prevale nel Vangelo l’amore di Dio per l’uomo, che è caratterizzato da tre verbi: guardare, toccare, mangiare.
Il ‘guardare’ non è solo vedere, è un richiamo all’interesse per non avere dubbi. Il ‘toccare’ richiede la vicinanza ma anche il contatto fisico. L’amore, l’interesse spinge sempre ad essere sempre più vicini. Il buon Samaritano nella parabola non si limita a guardare, ma scende da cavallo, medica le ferite e si interessa sino a portare l’altro all’ospedale e pagare le spese. Il ‘mangiare’ insieme è l’espressione più vera e tangibile dell’amore dal quale si evince la condivisione e il nutrimento.
L’amore per Cristo Gesù porta il vero discepolo a prendere coscienza che Egli è il Risorto, a testimoniare tale realtà davanti a tutti e a nutrirsi del suo corpo e sangue per avere la vera gioia cristiana. Allora è veramente Pasqua. Il brano del Vangelo di questa domenica si articola in due scene: l’apparizione del Risorto agli undici Apostoli ; la missione di Gesù affidata ad essi.
L’apparizione avviene all’improvviso e agli Apostoli viene data una ulteriore prova della sua risurrezione: Gesù chiede qualcosa da mangiare e mangia in mezzo ad essi: non è perciò un fantasma. La fede degli Apostoli in Gesù risorto non è una conquista ma un dono dello Spirito Santo, di Dio. Gesù ha voluto conferire loro questo dono ed essi lo hanno testimoniato nel mondo con il martirio.
Simon Pietro, che durante la passione di Gesù tremava e lo aveva per paura rinnegato davanti ad una cameriera, ora, dopo la Risurrezione, parla apertamente della passione, morte e risurrezione di Gesù davanti ad ascoltatori che avevano preso parte agli avvenimenti in forma diretta: ‘Voi lo avete rinnegato di fronte a Pilato, avete chiesto che fosse graziato un assassino (Barabba) e avete ucciso l’autore della vita. Ma il Dio di Abramo, Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri lo ha risuscitato e noi siamo testimoni. Voi l’avete respinto, rifiutato; noi, i testimoni della sua risurrezione, siamo chiamati a testimoniarlo a voi’.
Pietro è un apostolo ed invita alla conversione: ‘So bene che avete agito per ignoranza: convertitevi, cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati’. Pentirsi e cambiare vita sono i due momenti della conversione. Gesù non è morto per condannare all’inferno i suoi crocifissori; diceva. ‘Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno’. Nel sacrificio di Cristo Gesù in croce, che è morto per tutti noi, si fonda la speranza cristiana; il Crocifisso intercede per ciascuno di noi solo per un giudizio di salvezza eterna.
La risurrezione di Cristo Gesù è la garanzia che saremo salvati se aderiamo a Cristo; conversione, umiltà, perdono, fede ed amore, e Gesù ci garantisce un posto presso il Padre nel Regno dei cieli. Ogni cristiano è un ‘chiamato’ ha una vocazione perché riceve dallo Spirito Santo nel Battesimo i tre doni (Fede, Speranza, Carità) che lo abilitano, conforme ai talenti e ai carismi ricevuti, ad essere un apostolo, un testimone di Cristo Risorto.
E’ la vocazione del cristiano, sacerdote o laico, uomo o donna,: tutti con eguale dignità e responsabilità anche se con ruoli diversi. Le vie dell’amore sono diverse, ma tutte conducono alla stessa meta, lo Spirito spira dove, come e quando vuole; tutti siamo chiamati ad essere testimoni del Risorto. Stupenda è l’esperienza del Papà e della Mamma che si amano, si perdonano a vicenda ed insegnano al figlio ad amare e perdonare. Pasqua è amore e Dio ci insegna ad amare.
Se ti senti debole, Gesù ti ripete: ‘Prendete e mangiate: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue’ venite a me ed io vi ristorerò. Questa è la missione affidata da Gesù agli Apostoli e a quanti si dicono suoi discepoli. Questo è vivere la Pasqua di risurrezione.
Papa Francesco: la RAI è un servizio pubblico

Questa mattina papa Francesco ha ricevuto in udienza i dirigenti ed il personale della RAI-Radiotelevisione Italiana nell’Aula Paolo VI, consegnando due parole su cui riflettere: servizio e pubblico, per cui 70 anni fa nacque:
“Settant’anni di televisione, cento di radio: un doppio compleanno, che da un lato vi invita a guardare indietro, alla vostra storia, tanto intrecciata con quella italiana; e dall’altro vi sfida a guardare avanti, al futuro, al ruolo che avrete in un tempo tutto da costruire, dove ogni vita è sempre più connessa con le altre, a livello globale. Inoltre, siamo in Vaticano, e molti di voi conoscono bene questi luoghi, perché la RAI fin dalla sua nascita ha sempre seguito da vicino i passi dei Successori di Pietro”.
Queste due parole costituiscono la missione del servizio pubblico: “Essa, però, in tutti questi anni, non è stata solo testimone dei processi di cambiamento della nostra società: in parte, li ha anche costruiti, e da protagonista. I media, infatti, influiscono sulle nostre identità, nel bene e nel male. E qui è il senso del servizio pubblico che svolgete. Perciò vorrei riflettere con voi proprio su queste due parole (servizio e pubblico), perché esse descrivono molto bene il fondamento della vostra missione: la comunicazione come dono alla comunità”.
Per il papa il servizio non è solamente una parola strumentale: “E’ una parola che spesso riduciamo al suo significato strumentale, finendo per confondere il servire con il servirsi, la dedizione con l’uso. Il vostro lavoro, invece, vuole essere soprattutto una risposta ai bisogni dei cittadini, in spirito di apertura universale, con un’azione capace di articolarsi sul territorio senza diventare localista, nel rispetto e nella promozione della dignità di ogni persona. Un contributo alla verità e al bene comune che assume risvolti precisi nell’informazione, nell’intrattenimento, nella cultura e nella tecnologia”.
Il servizio è la promozione della verità: “Nel campo dell’informazione, servire significa essenzialmente cercare e promuovere la verità, tutta la verità, ad esempio contrastando il diffondersi delle fake news e il subdolo disegno di chi cerca di influenzare l’opinione pubblica in modo ideologico, mentendo e disgregando il tessuto sociale. La verità è una, è armonica, non si può dividere con gli interessi personali”.
Per questo papa Francesco ha sottolineato che la verità è sinfonica: “Significa evitare ogni riduzione ingannevole, ricordando che la verità è ‘sinfonica’ e che la si coglie meglio imparando ad ascoltare la varietà delle voci, come in un coro, piuttosto che gridando sempre e soltanto la propria idea. Ho voluto sottolineare questo”.
Verità è dare un’informazione non inquinata: “Significa, ancora, servire il diritto dei cittadini a una corretta informazione, trasmessa senza pregiudizi, non traendo conclusioni affrettate ma prendendo il tempo necessario per capire e per riflettere e combattendo l’inquinamento cognitivo,perché anche l’informazione deve essere ecologica”.
Inoltre, l’informazione deve garantire il pluralismo delle idee, come affermava san Giovanni Paolo II: “Per questo vi esorto a coltivare il dialogo, tessendo trame di unità. E per coltivare il dialogo bisogna ascoltare. Tante volte vediamo che l’ascolto serve a prepararmi per dare la risposta, ma non è vero ascolto pensare alla mia posizione senza ricevere quella degli altri”.
Richiamando il prossimo messaggio per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali papa Francesco ha ribadito che il pluralismo è molto ampio: “Penso al cinema, alla fiction, alle serie tv, ai programmi culturali e di intrattenimento, al racconto dello sport, ai programmi per bambini. In proposito, nella nostra epoca ricca di tecnica ma a volte povera di umanità, è importante promuovere la ricerca della bellezza, avviare dinamiche di solidarietà, custodire la libertà, lavorare perché ogni espressione artistica aiuti tutti e ciascuno ad elevarsi, a riflettere, a emozionarsi, a sorridere e anche a piangere di commozione, per trovare nella vita un senso, una prospettiva di bene, un significato che non sia quello di arrendersi al peggio. Quanto alla tecnica e alla tecnologia, poi, sono tante le domande che ci interpellano”.
Inoltre il servizio radiotelevisivo è pubblico: “Ess(o) sottolinea prima di tutto che il vostro lavoro è connesso al bene comune di tutti e non solo di qualcuno. Ciò comporta in primo luogo l’impegno a considerare e a dar voce specialmente agli ultimi, ai più poveri, a chi non ha voce, a chi è scartato”.
Il servizio pubblico è uno strumento importante per ‘sognare’: “Implica inoltre la vocazione ad essere strumento di crescita nella conoscenza, a far riflettere e non ad alienare, ad aprire nuovi sguardi sulla realtà e non ad alimentare bolle di indifferenza autosufficiente, a educare i giovani a sognare in grande, con la mente e gli occhi aperti. Questa parola può spaventarci: sognare. Non perdere mai le capacità di sognare, ma sognare alla grande!”
Un servizio pubblico non ha bisogno di confrontarsi con gli indici di ascolto: “Non bisogna inseguire gli ascolti a scapito dei contenuti: si tratta piuttosto di costruire, attraverso la vostra offerta, una domanda diffusa di qualità. Del resto la comunicazione, proprio in quanto dialogo per il bene di tutti, può svolgere nel nostro tempo un ruolo fondamentale anche nel ritessere valori socialmente vitali come la cittadinanza e la partecipazione”.
E’ stato un incoraggiamento ad offrire un servizio per gli ascoltatori: “Cari fratelli e sorelle, la RAI entra ogni giorno in tante case italiane, praticamente in tutte, ed è bello pensare alla sua presenza non come a una ‘cattedra di tuttologi’, ma a un gruppo di amici che bussano alla porta per fare una sorpresa (non dimenticare questo: la vera comunicazione è sempre una sorpresa, ti sorprende: tu aspetti una cosa e ti sorprende), per offrire compagnia, per condividere gioie e dolori, per promuovere in famiglia e nella società unità e riconciliazione, ascolto e dialogo, per informare e anche per mettersi in ascolto, con rispetto e umiltà. Vi incoraggio a camminare su questa strada, è bella!”
(Foto: Santa Sede)
Santa Teresa di Lisieux, perché la fiducia conduce all’Amore?

“E’ la fiducia e null’altro che la fiducia che deve condurci all’Amore! Queste parole così incisive di santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo dicono tutto, sintetizzano il genio della sua spiritualità e sarebbero sufficienti per giustificare il fatto che sia stata dichiarata Dottore della Chiesa. Soltanto la fiducia, ‘null’altro’, non c’è un’altra via da percorrere per essere condotti all’Amore che tutto dona. Con la fiducia, la sorgente della grazia trabocca nella nostra vita, il Vangelo si fa carne in noi e ci trasforma in canali di misericordia per i fratelli”.
Partendo dall’incipit dell’esortazione apostolica ‘C’est la confiance’ in occasione del 150^ anniversario della nascita di santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto santo, a suor Maria Chiara ed alle sorelle delle Carmelitane Scalze di Tolentino abbiamo chiesto di raccontarci per quale motivo la fiducia conduce all’Amore:
“Troviamo risposta a questa domanda osservando le dinamiche tra genitori e figli piccoli. Pensiamo a quando un bimbo sale sulle ginocchia del papà e si lascia abbracciare. Il piccolo si fida: non pensa che il papà possa lasciarlo cadere o fargli del male. Perciò gode di essere coccolato ed è libero di giocare con il papà, o di addormentarsi.
La grande intuizione di Teresa è stata che questo abbandonarsi fiducioso vale, a maggior ragione, nel rapporto tra noi e Dio: ‘E’ la fiducia che ci sostiene ogni giorno’, dice il papa nell’esortazione apostolica, e la fiducia ci porta ad abbandonarci senza riserve all’Amore di Dio: ‘Se siamo nelle mani di un Padre che ci ama senza limiti, questo sarà vero qualunque circostanza accada, potremo andare avanti qualunque cosa succeda’ (sono ancora parole del papa).
‘Si chiude il cerchio’, prosegue l’Esortazione, ‘C’est la confiance: è la fiducia che ci conduce all’Amore e così ci libera dal timore, è la fiducia che ci aiuta a togliere lo sguardo da noi stessi, è la fiducia che permette di porre nelle mani di Dio ciò che soltanto Lui può fare. Questo ci lascia un immenso torrente d’amore e di energie disponibili per cercare il bene dei fratelli’.
E’ un’esperienza che constatiamo anche nelle relazioni fra di noi: in un clima di reciproca fiducia, il cuore si dilata, i rapporti si approfondiscono in libertà e confidenza, lavoriamo e collaboriamo meglio, ci sentiamo sereni e interiormente forti, perché non siamo soli, sappiamo di poter contare sull’aiuto di chi ci vuole bene. Se noi ci radichiamo nella certezza che Dio ci ama, anzi che Dio può solo amarci, ci apriamo ad orizzonti inattesi di pace e di gioia.
Questo è il tesoro spirituale che Teresa ci trasmette e in questo consiste la cosiddetta ‘via dell’infanzia spirituale’, che forse, più correttamente, andrebbe chiamata ‘via dell’infanzia evangelica’. Nel confronto costante con il Vangelo, emergono dal cuore i sentimenti del Figlio, Gesù, che pienamente si è abbandonato alle mani del Padre e ha reso la sua vita un’offerta d’amore”.
Perché ella aveva un’anima missionaria?
“La giovanissima Teresa Martin si era appassionata per la ‘missio ad gentes’ e sapeva che i suoi genitori avrebbero desiderato un figlio sacerdote e missionario. Intuendo che ogni gesto di amore e ogni preghiera si diffondono come un profumo sino ai confini del mondo, già da ragazzina compie tutto quello che le è possibile per esercitare la carità, lavorando su di sé per diventare amabile e servizievole, e pregando per il bene degli altri, per la salvezza di tutti.
Entrata al Carmelo a 15 anni, ma con la maturità di una donna adulta nella fede, trova piena corrispondenza e dona luce nuova alla passione apostolica e missionaria della sua (e nostra) fondatrice, santa Teresa d’Avila. La giovane monaca di Lisieux scrive in una lettera: ‘Una carmelitana che non fosse apostola si discosterebbe dalla finalità della sua vocazione e cesserebbe di essere figlia della serafica Santa Teresa, che desiderava offrire mille vite per salvare una sola anima’.
Teresa vive in pienezza la sua vocazione contemplativa, ma sempre con uno slancio apostolico: la sua preghiera non è mai ricerca intimistica e alienante del proprio benessere. E’ incessantemente protesa nel servizio alle consorelle. Vive una solidarietà spirituale senza confini nell’offerta di ogni fatica e sofferenza, e in particolare prendendosi cura del cammino vocazionale e spirituale di due seminaristi missionari. Come scrisse Balthasar: ‘Teresa viene a trovarsi nella legge unica e unificante dell’amore, dalla quale provengono sia la passività ricettiva che la fecondità, sia Maria che Marta. Questo trascendente punto di unità è la più grande intuizione concessa a Teresa’.
Ella ha ricevuto una singolare luce sul versetto del Cantico dei Cantici: ‘attirami (attira me), noi correremo’ e su questo ha fondato la certezza che, nella sua tensione spirituale verso l’Amore misericordioso del Padre, avrebbe portato con sé tutti i fratelli e le sorelle nel mondo”.
Per quale motivo papa Francesco ha definito santa Teresa ‘Dottore della sintesi’?
“Questo titolo inedito, che Papa Francesco ha coniato per la più giovane e la storicamente vicina a noi tra i Dottori della Chiesa, inquadra bene la fisionomia caratteristica di Teresa di Lisieux. In soli 24 anni e senza alcuno strumento di cultura ‘accademica’, Teresa ha posto lo sguardo su ciò che essenziale nella vita spirituale e anche nella vita della Chiesa: l’Amore, l’Amore come quello di Gesù, spinto sino alle estreme conseguenze di un’offerta libera e gratuita per la salvezza di tutti”.
Ed infine raccontano il motivo per cui santa Teresa ‘appassiona’: “La ‘piccola’ Teresa, giovane donna appassionata, ha conquistato innumerevoli cuori, di credenti e anche di non credenti, di cristiani e di appartenenti ad altre religioni (come dimostra il santuario a lei dedicato a Il Cairo, frequentato ugualmente da cristiani e musulmani). La pioggia di rose delle grazie ottenute per sua intercessione non si è mai fermata, e il tempo non ha indebolito il fascino del suo messaggio, che può essere ugualmente vissuto da uomini e donne, consacrati e laici”.
Teresa di Gesù Bambino nasce ad Alençon, in Normandia nel 1873 e la sua breve esistenza terrena, bruciata dall’amore, si conclude nel Carmelo di Lisieux il 30 settembre 1897. Beatificata il 29 aprile 1923 da papa Pio XI, è proclamata santa dallo stesso pontefice il 17 maggio 1925. Monaca di clausura dall’età di 15 anni, è patrona delle Missioni dal 1927 insieme a san Francesco Saverio. Il 19 ottobre 1997, nel centenario della sua morte, è proclamata da Giovanni Paolo II Dottore della Chiesa: degli attuali 37 Dottori, è la più giovane e storicamente la più vicina a noi.
Inoltre l’UNESCO ha accolto ufficialmente Teresa tra le personalità significative da valorizzare nel biennio 2022-2023 presentandola come ‘Donna di cultura, di educazione e di pace’ con un importante riconoscimento del ‘messaggio universale di Teresa di Lisieux per l’Amore e la riconciliazione al servizio della pace’: “Questa celebrazione contribuirà ad apportare una più grande visibilità e giustizia alle donne che hanno promosso, con le loro azioni, i valori della pace”.
(Tratto da Aci Stampa)
Papa Francesco: la cura è carità

Oggi papa Francesco, ancora non in piena salute, ha ricevuto in udienza la comunità dell’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ in occasione del 100° anniversario della donazione dell’Ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati, e nel discorso, letto ancora da mons. Filippo Ciampanelli, ha sottolineato il valore di questo ospedale per i bambini:
“Il dono fu accolto da Pio XI, che vide nell’opera l’espressione della carità del Papa e della Chiesa verso i piccoli infermi, e da allora è conosciuto come ‘Ospedale del Papa’. Fermiamoci allora un momento a riflettere, con riconoscenza, sulla ricchezza di questa istituzione, sviluppatasi in un secolo di storia, sottolineandone tre aspetti: il dono, la cura e la comunità”.
Innanzitutto l’ospedale è sorto come ‘dono’ per la cura di bambini i cui genitori non avevano risorse per curarli: “Oggi il ‘Bambino Gesù’ è un centro di ricerca e di cura pediatrica tra i più grandi in Europa, punto di riferimento per famiglie che vengono da tutto il mondo. Resta però fondamentale, nella sua storia e nella sua vocazione, l’elemento del dono, con i valori di gratuità, generosità, disponibilità e umiltà”.
E ne ha raccontato la storia: “E’ bello ricordare, in proposito, il gesto dei figli della duchessa Arabella Salviati che, all’inizio della vostra storia, regalarono alla mamma il loro salvadanaio per realizzare un ospedale per i bambini: esso ci dice che questa grande opera si fonda anche su doni umili, come quello di questi ragazzi a beneficio dei loro coetanei malati.
E nella stessa ottica fa bene, ai nostri giorni, menzionare la generosità dei molti benefattori grazie a cui si è potuto realizzare, a Passoscuro, un Centro di Cure Palliative per giovanissimi pazienti affetti da malattie inguaribili”.
Però il dono ha bisogno di impegno, che si compie nella cura: “La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi l’Ospedale Bambino Gesù. Essa è la risposta concreta che date alle accorate richieste di aiuto di famiglie che domandano per i loro figli assistenza e, ove possibile, guarigione. L’eccellenza nella ricerca biomedica è dunque importante”.
E’ stato un incoraggiamento ad avanzare nella ricerca: “Vi incoraggio a coltivarla con lo slancio di offrire il meglio di voi stessi e con un’attenzione speciale nei confronti dei più fragili, come i pazienti affetti da malattie gravi, rare o ultra-rare. Non solo, ma perché la scienza e la competenza non restino privilegio di pochi, vi esorto a continuare a mettere i frutti della vostra ricerca a disposizione di tutti, specialmente là dove ce n’è più bisogno, come fate ad esempio contribuendo alla formazione di medici e infermieri africani, asiatici e mediorientali”.
Inoltre la cura dei bambini ha necessità di accoglienza per i genitori: “A proposito di cura, sappiamo che la malattia di un bambino coinvolge tutti i suoi familiari. Per questo, è una grande consolazione sapere che sono tante le famiglie seguite dai vostri servizi, accolte in strutture legate all’ospedale e accompagnate dalla vostra gentilezza e vicinanza.
Questo è un elemento qualificante, che non va mai trascurato, anche se so che a volte lavorate in condizioni difficili. Piuttosto sacrifichiamo qualcos’altro, ma non la gentilezza e la tenerezza. Non c’è cura senza relazione, prossimità e tenerezza, a tutti i livelli”.
Per questo è necessaria la comunità: “Una delle più belle espressioni che descrivono la missione del ‘Bambino Gesù’ è ‘Vite che aiutano la vita’. E’ bella, perché parla di una missione portata avanti insieme, con un agire comune in cui trova posto il dono di ciascuno. Questa è la vostra vera forza e il presupposto per affrontare anche le sfide più difficili. Il vostro infatti non è un lavoro come tanti altri: è una missione, che ognuno esercita in modo diverso.
Per alcuni essa comporta la dedizione di una vita intera; per altri l’offerta del proprio tempo nel volontariato; per altri ancora il dono del proprio sangue, del proprio latte (per i neonati ricoverati le cui mamme non possono provvederlo), fino al dono di organi, cellule e tessuti, offerti da persone viventi o prelevati dal corpo di persone decedute”.
Ugualmente ai membri ai membri della fondazione ‘Mons. Camillo Faresin’ di Maragnole di Breganza nel vicentino ricevuti in occasione del ventesimo anniversario di fondazione, ha chiesto di non dimenticare gli ‘ultimi’: “Ricordiamo, in proposito, che il nome del Vescovo Camillo è annoverato, a Gerusalemme, tra quelli del ‘Giardino dei Giusti’, proprio perché, prima ancora di poter partire per il Brasile, bloccato a Roma a causa della seconda guerra mondiale, non si è lasciato fermare dalle circostanze, prodigandosi con carità e coraggio nell’assistere gli ebrei perseguitati.
Così è stato per tutta la sua vita, come sacerdote e poi come vescovo, con un impulso irresistibile a farsi vicino ai più sfortunati. Fino a quando, terminato il suo mandato episcopale, ha chiesto e ottenuto di poter rimanere fra la sua gente, nel Mato Grosso, fino alla sua morte, come umile servo degli umili, continuando così nel nascondimento, come amico e compagno di cammino, lo stesso ministero che per tanti anni aveva svolto come guida e pastore”.
E’ un invito a non abbandonare il suo esempio: “Quello che ci ha lasciato è un esempio grande da imitare: stare con gli ultimi, sempre! Ma in che modo? Scegliendo e privilegiando, nei vostri progetti, le realtà più povere e disprezzate come luoghi speciali in cui rimanere, e come ‘terre promessa’ verso cui mettervi in marcia e in cui ‘piantare le vostre tende’ per iniziare nuove opere.
E farlo con una presenza concreta e vicina alle comunità che servite, dal di dentro, in loco, lavorando tra i poveri e condividendone il più possibile la vita. Solo così, infatti, si sente ‘il polso’ dei bisogni reali dei fratelli e delle sorelle che il Signore mette sulla nostra strada; e soprattutto ci si arricchisce della luce, della forza e della saggezza che vengono dallo stare con Gesù, presente in modo unico nelle membra più sofferenti del suo Corpo”.
(Foto: Santa Sede)
La Chiesa è sinodale e missionaria

Ieri sono stati pubblicati due documenti della Segreteria Generale del Sinodo: ‘Come essere Chiesa sinodale in missione? Cinque prospettive da approfondire teologicamente in vista della Seconda Sessione’; ‘Gruppi di studio su questioni emerse nella Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi da approfondire in collaborazione con i Dicasteri della Curia romana’, presentati dal card. Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo; dal card. Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di Luxembourg e relatore generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi; da mons. Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi; da mons. Piero Coda, Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale, da p. Giacomo Costa, Consultore della Segreteria Generale del Sinodo, e da suor Simona Brambilla, Segretaria del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che ha puntualizzato:
“La Relazione di Sintesi (RdS) pubblicata lo scorso ottobre a conclusione della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità porta il titolo: ‘Una Chiesa sinodale in missione’. La domanda guida che ci accompagna nei lavori verso la II sessione dell’ottobre 2024 è: ‘Come essere Chiesa sinodale in missione?’… Tra i membri del Sinodo ci sono sia il Prefetto sia il Segretario del Dicastero. Per entrambi, l’esperienza di immersione nella dinamica sinodale è stata coinvolgente e stimolante. Ci siamo accorti, con stupore e commozione, di trovarci a vivere un momento forte dello Spirito che segna una svolta.
L’Aula Paolo VI in Vaticano come un grande cenacolo. I tavoli rotondi disposti attorno alla Parola e all’icona della Madre, la Salus populi romani che, come a Cana, vigila con premura e discrezione sullo svolgersi del banchetto, custodendo la comunione, la gioia, la festa. Sedute alla mensa della Parola, che risuona nella Scrittura e nella voce dell’altro, oltre 400 persone provenienti dai cinque continenti e dalle più diverse esperienze di Chiesa (cardinali, vescovi, preti, diaconi, consacrati e consacrate, laici e laiche) uniti da ciò che li rende profondamente fratelli e sorelle, al di là di ogni ruolo, titolo, funzione, servizio, responsabilità: il Battesimo, l’immersione in Cristo, la vocazione cristiana!”
Nel primo documento riguardante la missione della Chiesa si sottolinea che il Sinodo ha evidenziato la natura missionaria della Chiesa: “Il processo sinodale ci ha resi sempre più consapevoli della nostra missione. Nella Prima Sessione assembleare, questa consapevolezza ha progressivamente ‘preso carne’, orientando il cammino in vista della Seconda Sessione (ottobre 2024)…
L’obiettivo è identificare le vie da percorrere e gli strumenti da adottare nei diversi contesti e nelle diverse circostanze, così da valorizzare l’originalità di ogni battezzato e di ogni Chiesa nell’unica missione di annunciare il Signore risorto e il suo Vangelo al mondo di oggi. Non si tratta dunque di limitarsi al piano dei miglioramenti tecnici o procedurali che rendano più efficienti le strutture della Chiesa, ma di lavorare sulle forme concrete dell’impegno missionario a cui siamo chiamati, nel dinamismo tra unità e diversità proprio di una Chiesa sinodale”.
E muta il luogo della missione secondo i ‘segni dei tempi’: “Viviamo in un tempo nel quale il rapporto delle persone e delle comunità con la dimensione dello spazio sta mutando profondamente. La mobilità umana, la presenza in uno stesso contesto di culture ed esperienze religiose diverse, la pervasività dell’ambiente digitale (l’infosfera) possono essere considerati ‘segni dei tempi’ che occorre discernere.
In un mondo segnato da violenza e frammentazione, appare sempre più urgente una testimonianza dell’unità dell’umanità, della sua comune origine e del suo comune destino, in una solidarietà coordinata e fraterna verso la giustizia sociale, la pace, la riconciliazione e la cura della casa comune, superando quindi il potenziale divisivo di alcuni modi errati di intendere il riferimento a un luogo, ai suoi abitanti e alla sua cultura”.
Nel secondo documento è stato dato risalto alle relazioni tra Chiese orientali cattoliche e Chiesa latina: “L’Assemblea sinodale ha evidenziato la necessità di una maggiore conoscenza reciproca e di un dialogo tra i membri delle Chiese orientali cattoliche e della Chiesa latina. In un contesto di crescente migrazione, che ha visto lo sviluppo di comunità cristiane orientali in diaspora, le comunità di tradizioni orientali e latina coesistono oggi nella maggior parte del mondo…
Sulla scia di quanto proposto dalla RdS, si dà vita a un Gruppo di studio formato da teologi e canonisti orientali e latini, coordinato dalla Segreteria Generale del Sinodo e dal Dicastero per le Chiese orientali, che, dopo il necessario approfondimento, possa formulare indicazioni: relative alla partecipazione alle Conferenze Episcopali dei Vescovi orientali al di fuori del territorio canonico; relative a linee guida per le Diocesi latine sul cui territorio vivano presbiteri e fedeli orientali, in modo da aiutarli ‘a preservare la loro identità e a coltivare il loro patrimonio specifico’, e con lo scopo di ‘trovare modalità che rendano visibile e sperimentabile una effettiva unità nella diversità’”.
Poi si è evidenziata la necessità dell’ascolto del ‘grido’ dei poveri: “Il cap. 16 della RdS esprime la consapevolezza che ‘ascolto è il termine che meglio esprime l’esperienza più intensa che ha caratterizzato i primi due anni del percorso sinodale e anche i lavori dell’Assemblea’, ed afferma che ‘una Chiesa sinodale non può rinunciare a essere una Chiesa che ascolta, e questo impegno deve tradursi in azioni concrete’…Mettersi in ascolto consente alla comunità cristiana di ‘assumere l’atteggiamento di Gesù nei confronti delle persone che incontrava’”.
Fondamentale è anche l’ambiente digitale, indicando i giovani più adatti a questa nuova missione: “Il cap. 17 della RdS costituisce l’orizzonte al cui interno cogliere l’importanza per la Chiesa di portare avanti la missione di annuncio del Vangelo anche nell’ambiente digitale, che coinvolge ogni aspetto della vita umana e va quindi riconosciuto come una cultura e non solo come un’area di attività. Tuttavia la Chiesa stenta a riconoscere l’azione nell’ambiente digitale come una dimensione cruciale della propria testimonianza nella cultura contemporanea.
Pur riguardando tutti, l’azione nel mondo digitale è contrassegnata da un’attenzione particolare al mondo giovanile: molti giovani ‘hanno abbandonato gli spazi fisici della Chiesa in cui cerchiamo di invitarli a favore degli spazi online’… al tempo stesso, i giovani, e tra di loro i seminaristi, i giovani preti e i giovani consacrati e consacrate, che spesso ne hanno una esperienza diretta, sono i più adatti per aiutare la Chiesa a portare avanti la missione nell’ambiente digitale”.
(Foto: Santa Sede)
‘E’ Gesù che cercate quando sognate la felicità’: la Missione Popolare dei Missionari del Preziosissimo Sangue a Celano

“La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue fondata da San Gaspare del Bufalo il 15 agosto 1815, fedele al carisma del Fondatore e alla tradizione secolare delle missioni popolari, continua anche oggi, da oltre 200 anni, questo servizio alla Chiesa attraverso l’attività apostolica e missionaria del ministero della Parola”: spiega don Flavio Calicchia, direttore del Centro per la Predicazione della Provincia Italiana.
“La missione popolare, continua don Flavio, è un tempo di predicazione straordinaria che mira a raggiungere tutti, non lasciando indietro nessuno: famiglie, scuole, associazioni sportive, ospedali, RSA, persone anziane o comunque in condizioni di fragilità, carceri… e poi ancora, i luoghi di vita quotidiana: attività commerciali, piazze, bar, sale giochi, centri di aggregazione…
I missionari, in stretta collaborazione con i Vescovi e i Parroci, organizzano il tempo e il modo dello svolgimento della missione tenendo conto della motivazione di tale richiesta e i bisogni reali della parrocchia e del territorio dove essa quotidianamente svolge il suo servizio. L’obiettivo centrale della missione? La prossimità, che nasce dalla consapevolezza di un bisogno e l’incontro personale con Gesù, il prossimo per eccellenza! E’ Lui l’unica fonte di ogni nostra ispirazione! La missione è un vero e proprio tempo di Grazia!”
Don Gabriele Guerra, parroco del Sacro Cuore, a Celano, in una lettera rivolta a tutta la comunità parrocchiale condivide: “Carissimi, la missione popolare che vivremo qui in Parrocchia dal 2 al 17 marzo, è un momento di Grazia che il Signore ci offre. Mi torna alla mente il versetto del Libro dei Re, quando Elia cerca di cogliere la presenza di Dio nei grandi segni e invece Dio si rende presente in un leggero soffio di vento.
Sappiamo riconoscere in questi giorni il Signore che passa nelle nostre vite. Saranno molti gli appuntamenti che ci vedranno coinvolti e saremo cosi aiutati dai Missionari del Preziosissimo Sangue a saper cogliere quello che Dio vuole dirci, affidando a Maria la nostra vita. Faccio mio quello che san Gaspare del Bufalo scrisse: Maria, non abbia mai da accadere che questa Missione che è riposta sotto il vostro patrocinio debba finire restando qualche peccatore interessato ma non convertito.
Dicono i Dottori che come quella buona donna Ruth andava dietro ai mietitori, raccogliendo le spighe sfuggite di mano ad essi, così la Madonna ha questo uffizio nella Chiesa di convertire quelle Anime che son sfuggite di mano ai predicatori. Voi crederete che per chi non si è convertito a quest’ora non rimanga altra possibilità per lui. Ma che dite mai? Rimane l’arma più potente! Rimane Maria!”
Durante le due settimane di predicazione, ci sarà la presenza di nove Missionari del Preziosissimo Sangue, due seminaristi della stessa Congregazione, una suora Adoratrice del Sangue di Cristo, una famiglia missionaria e numerosi laici.
Giornata Missionaria: per papa Francesco la missione è invito al banchetto

“Per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno ho tratto il tema dalla parabola evangelica del banchetto nuziale. Dopo che gli invitati hanno rifiutato l’invito, il re, protagonista del racconto, dice ai suoi servi: ‘Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze’. Riflettendo su questa parola-chiave, nel contesto della parabola e della vita di Gesù, possiamo mettere in luce alcuni aspetti importanti dell’evangelizzazione.
I salesiani raccontano l’emergenza a Goma

“Pochi giorni fa si sono intensificati gli scontri tra l’esercito regolare ed i ribelli dell’M23 nel territorio di Masisi verso Mushaki, Karuba, villaggi sovrastati da alte montagne; altri villaggi, Shasha, Kirotshe, Kihindo, hanno vissuto la stessa situazione. Da mercoledì 7 febbraio 2024 moltissime famiglie si sono trasferite in massa a Minova e a Sake. Ma gli scontri si sono avvicinati, le bombe cadono sulla città, si sente il crepitio di proiettili”: così hanno denunciato le Missioni Don Bosco la situazione umanitaria, che rischia di peggiorare.
I Salesiani, presenti in forza nella regione, continuano a fare il possibile per aiutare i bisognosi, muovendosi su tutti i fronti possibili con Missioni Don Bosco Onlus: “Sake si trova a 27 chilometri dalla città di Goma, nel territorio di Masisi. I leader tradizionali e gli abitanti di questa entità sono profondamente colpiti dalla situazione: più di 3.000 nuclei familiari hanno già abbandonato le loro case e il loro lavoro. Girovagano senza meta, non hanno né acqua né cibo. A causa delle cattive condizioni igieniche, il colera colpisce alcune persone ed è un rischio per tutti”.
Nel racconto i Salesiani hanno evidenziato il caos che si sta creando: “E’ sempre più difficile tenere il conto delle migliaia di persone che continuano a scappare in cerca di un posto sicuro lontano dagli scontri, è la seconda volta che gli sfollati provenienti da Shasha, Kirotshe, Kichonga, Ngungu, Karuba e altre località del territorio di Masisi si aggiungono alle migliaia di altri sfollati che si trovano nei campi della città di Goma. I campi sembrano non avere più spazio sufficiente.
Centinaia di bambini, anziani e giovani si ritrovano in condizioni inaccettabili ai lati della strada alla ricerca di famiglie ospitanti e altri prendono di mira i campi dove hanno la possibilità di essere accolti. I campi di Bushagala, Bulengo e Rusayo sono i più vicini, a seconda delle affinità altri preferiscono viaggiare molto per raggiungere le proprie famiglie in altri campi più lontani da Sake, questi sono i campi di Don Bosco Ngangi e quello di Kanyaruchinya.
Questa situazione si sta delineando proprio nel momento in cui i soldati che sono al fronte stanno lanciano bombe verso Goma, una è caduta sull’aeroporto, un’altra sulla scuola di Nengapeta mentre fortunatamente gli studenti erano già tornati a casa. Altre due sono cascate a pochi metri dall’Università di Goma e al nuovo mercato chiamato ‘Kisoko’ a Mugunga, ai margini dell’Ecole du Cinquantenaire, un’importante scuola tecnica di Goma. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha espresso preoccupazione per l’escalation di violenza”.
Il salesiano Pascal Bauma ha testimoniato che sulla strada Sake-Goma ci sono sfollati già da diversi mesi: “Vivevano in quattro siti: Mama Zaina, Mayutsa, Kizimbo e Tshabiringa. Oggi, l’arrivo di nuovi sfollati dai villaggi di Shasha, Kirotshe, Mwambaliro, Buhunga e zone circostanti ha complicato la situazione della sicurezza: tutti sono in stato di vulnerabilità e costretti a fuggire di nuovo.
Molti si sono diretti verso Mugunga, a ovest di Goma. Lungo la strada si vedono bambini, giovani e anziani, seduti, stanchi, non sanno dove andare. Si tratta di un secondo esodo per le stesse persone. A Goma trovano altre migliaia di sfollati che sono scappati da Rutchuru e dalle località del Nord”.
Così i salesiani sono al fianco degli sfollati e continuano a distribuire aiuti di prima necessità, il campo sfollati di Don Bosco-Ngangi attualmente conta più di 3.500 famiglie, quello di Don Bosco Shasha ne ha circa 1.000 famiglie:
“Ai bambini più piccoli viene distribuita una pappa una volta al giorno, oltre al pasto che viene distribuito a tutti, sembra poco, ma significa tantissimo soprattutto per coloro che soffrono di malnutrizione. E’ necessario razionare cibo e acqua per poter aiutare tutti, nonostante sia impossibile prevedere quante altre persone possano raggiungere i campi nei prossimi giorni o mesi”.
Il direttore della comunità salesiana di Shasha, don Kizito Tembo, alcuni giorni fa ha inviato un messaggio ai suoi confratelli: “La situazione si sta infuocando, in breve tempo abbiamo sentito volare proiettili provenienti da tutte le direzioni e il panico ha attanagliato il villaggio. Per evitare di cadere in un’imboscata, ho chiesto a tutti di restare dove erano. E poiché l’assalto è stato improvviso, non siamo riusciti ad evacuare nessuno.
Nella comunità ci siamo chiusi in casa con 6 uomini, 8 donne e 18 bambini. Ci affidiamo alla misericordia divina, abbandonandoci nelle mani della Madonna. Il giorno dopo abbiamo appena trascorso una domenica più o meno tranquilla, a volte disturbata alcuni spari e qualche bomba che proveniva dalle montagne del Kiluku. Vi chiediamo di continuare a pregare per noi, perché ritorni completamente la calma e le persone ritornino alle loro varie attività”.
(Foto: Missioni Don Bosco)
Papa Francesco: camminare con il popolo di Dio per la crescita spirituale

Oggi papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al Convegno internazionale sulla formazione permanente dei sacerdoti, promosso dal Dicastero per il Clero, in corso fino a sabato 10 febbraio, raccomandando di camminare nella testimonianza della Parola di Dio, secondo il titolo del convegno ‘Ravviva il dono di Dio che è in te’, senza offrire risposte preconfezionate: