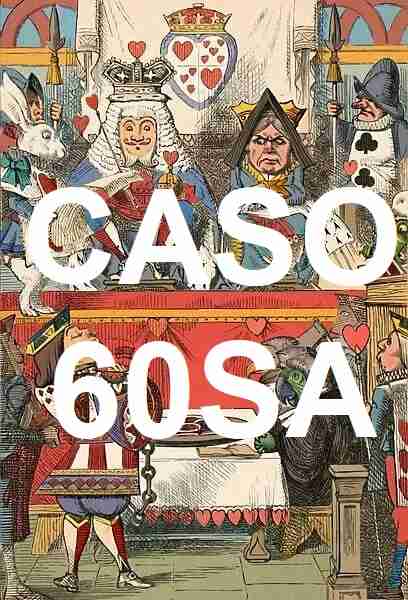Turchia, salvo il partito di governo. Ma il Paese rimane bifronte

 Sospiro di sollievo per la democrazia turca: l’Alta Corte ha respinto l’istanza di chiusura del partito di governo Akp, che però si vedrà dimezzare i fondi pubblici. L’accusa è quella di aver agito contro la laicità dello Stato, un totem per il Paese, sin dai tempi di Atatürk. Se accolto, il ricorso avrebbe creato uno scenario paradossale con la messa al bando di un partito che esprime premier e capo dello Stato.
Sospiro di sollievo per la democrazia turca: l’Alta Corte ha respinto l’istanza di chiusura del partito di governo Akp, che però si vedrà dimezzare i fondi pubblici. L’accusa è quella di aver agito contro la laicità dello Stato, un totem per il Paese, sin dai tempi di Atatürk. Se accolto, il ricorso avrebbe creato uno scenario paradossale con la messa al bando di un partito che esprime premier e capo dello Stato.
Il presidente della Corte costituzionale, Hasim Kilic, ha voluto lanciare in ogni caso un messaggio chiaro. ”Sei membri della Corte Costituzionale (che ne conta 11, ndr) – ha detto in una dichiarazione televisiva a rete unificate – si sono espressi a favore della chiusura del partito, mentre gli altri quattro hanno votato per il taglio della metà dei fondi pubblici destinati al finanziamento del partito rispetto all’ultima erogazione”.
I quattro giudici contrari alla chiusura del partito, ha precisato l’alto magistrato, hanno ritenuto che l’Akp, ”sebbene abbia dato segni di essere un centro focale di attività antilaiche” come era stato accusato, ”tuttavia non lo ha fatto al punto da meritare la chiusura”. Il giudizio contro l’Akp era cominciato il 14 marzo scorso, quando il Procuratore Generale della Cassazione, Abdurrahman Yalcinkaya, aveva presentato alla Corte Costituzionale un documento con 17 capi d’accusa relativi ad ”attività antilaiche”: le proposte di proibizione degli alcolici, la separazione di uomini e donne nei parchi pubblici, piscine e mezzi di trasporto, la liberalizzazione del velo e la penalizzazione dell’adulterio.
IL CONTESTO. Se il rischio della chiusura dell’Akp al momento è scongiurato, sullo sfondo, rimangono tuttavia le contraddizioni di uno Stato bifronte in cui convivono istanze spesso agli antipodi. In Turchia, la difesa strenua della laicità si scontra con le spinte estremistiche di alcuni settori; la prospettiva europea con un assetto di potere che contrappone a fasi alterne mondo politico ed esercito; la bandiera dell’identità turca con un sistema che di fatto ostacola la libertà religiosa, non riconoscendo sul piano giuridico le minoranze (cristiani in primis) e riconducendo al controllo dello Stato il culto della maggioranza musulmana.
Come dimostra la sentenza della Corte costituzionale, il Paese difende in modo ossessivo la propria laicità, intesa però non in chiave europea e liberale (libera Chiesa in libero Stato), ma come subordinazione del fenomeno religioso al controllo statale. Un contesto in cui i piani spesso si confondono, producendo una sintesi turco-islamica basata sull’idea che un buon turco debba essere per forza un buon musulmano e non certo un cristiano: condizione che in certi settori della politica e della società si manifesta in un mix di ultranazionalismo e di fondamentalismo islamico.
Ecco così che, se da una parte il cammino delle riforme ha fatto il suo corso (dall’abolizione della pena di morte alla riforma del codice civile), dall’altra il tema dell’identità mescola rivendicazioni ed estremismi. Si pensi al linciaggio di chi affronta il tema del genocidio armeno (la scrittrice Elif Shafak è stata processata e poi assolta, in forza dell’articolo 301 del codice penale) o alle polemiche e azioni contro il cristianesimo, visto per paradosso come una presenza straniera (e nel migliore dei casi, occidentale), dedita a conversioni forzate o a pagamento. Schegge impazzite di uno stato profondo, in cui migliaia di persone manifestano al mausoleo di Atatürk ad Ankara e al funerale dell’ex premier Ecevitt per ribadire che la Turchia è laica; e nel maggio 2006, in pieno dibattito sulla legge antivelo nelle scuole, Mustafa Yucel Ozbilgin, giudice della corte di cassazione, muore, ucciso da un avvocato nazionalista, con una pistola uguale a quella usata dall’omicida ragazzino di don Andrea Santoro.
A tutto questo si deve aggiungere la dialettica costante tra l’esercito (dai tempi di Atatürk custode della laicità, anche attraverso colpi di Stato) e sfera politica. Un vero e proprio gioco delle parti che usa la minaccia e l’allarme del fondamentalismo per legittimare il ruolo dello Stato laico, e in definitiva per mantenere lo status quo. Quello di un esercito, forte di 800mila persone, in grado di assorbire più di un terzo della ricchezza nazionale e controllare la politica (al limite del veto), in virtù di prerogative costituzionali. Un ruolo anche e, soprattutto, economico, grazie al colosso produttivo del Paese, il fondo pensionistico Oyak, che gestisce e condiziona interi settori dell’economia: le banche in primo luogo, ma anche decine di compagnie finanziarie, industrie e società di servizi.
Il tutto, in uno scacchiere in cui operano in contemporanea oligarchie economiche colluse con le mafie (il caso della Russia post sovietica è illuminante), gruppi fondamentalisti legati indirettamente al governo e ben infiltrati nella polizia, partiti nazionalisti appoggiati dall’esercito e collegati ai servizi segreti.
Nella Repubblica turca, nulla viene lasciato al caso e a dominare è una sorta di equilibrio fragile che, tra l’altro, produce atteggiamenti contradditori rispetto all’ingresso nell’Unione Europea. Una prospettiva appoggiata più per un vantaggo economico e strategico che ideale, dal momento che il sistema sarebbe costretto a cambiare radicalmente, cancellando una rete di interessi che permette ad ogni attore sociale e politico di ritagliarsi un ruolo.
In questo senso, agitare lo spauracchio del nemico esterno (politico o religioso che sia) diventa un escamotage utile. Lo ha fatto la Corte costituzionale con il partito del premier Recep Tayyip Erdoğan, confermandosi come ultimo baluardo laico, dopo l’elezione alla presidenza della Repubblica, del musulmano Abdullah Gul.