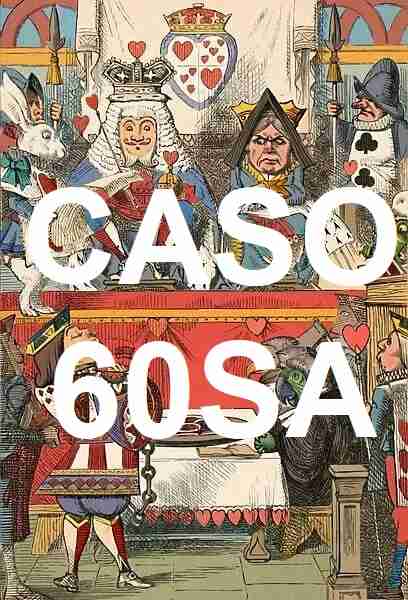“Modalità Francesco” la Terra Santa di Bergoglio*

Un viaggio in “modalità Francesco”, gesti spiazzanti e poco protocollo. Tre giornate di fuoco, tappe forzate tanto da non riuscire ad essere a Nazaret. Perché al di là della politica quello di Papa Francesco è stato un viaggio per far ripartire il dialogo. Tra le tre grandi religioni del libro, con quell’abbraccio tra il Papa e i suoi due amici, uno ebreo e uno islamico, davanti al Muro Occidentale. Nel quale lascia il testo del Padre Nostro. Tra le nazioni, con quell’invito “nella mia casa in Vaticano” ai presidenti di due Stati che ancora non si riconoscono. Ma soprattutto tra i cristiani, con la prima preghiera comune dopo molti secoli, davanti all’edicola del Santo Sepolcro. L’immagine del Papa di Roma e del Patriarca di Costantinopoli chinati a baciare la pietra dove Gesù è risorto è il più grande schiaffo allo scandalo della divisione dei seguaci di Cristo. E poi quei muri, quello santo del Tempio di Salomone, quello dannato che divide le famiglie tra Gerusalemme e Betlemme. E poi i bambini. Quelli per la cui vita il Papa ha pregato e gridato sulla Piazza della Mangiatoia di Betlemme, segno “diagnostico” per capire la salute di una famiglia, di una società, del mondo. Perché “Quando i bambini sono accolti, amati, difesi, tutelati nei loro diritti, la famiglia è sana, la società è migliore, il mondo è più umano”.
Come i bambini che lo hanno accolto nel campo profughi di Dheisheh e che lamentano la occupazione israeliana. A loro risponde con sapienza popolare il Papa, “non lasciate mai che il passato determini la vostra vita. Guardate sempre avanti. Lavorate e lottate per ottenere le cose che volete. Però, sappiate una cosa, che la violenza non si vince con la violenza! La violenza si vince con la pace! Con la pace, con il lavoro, con la dignità di far andare avanti la patria!”
I bambini come quelli che hanno aiutato Francesco a deporre una corona di fiori al monumento di Herzel dove da tre anni tutti capi di Stato in visita sono invitati ad andare. Due cattolici nati in Israele, che parlano ebraico, e che sono integrati nel sistema scolastico israeliano e i cui genitori appartengono alle comunità cattoliche di lavoratori migranti.
Così come i bambini allo Yad Vashem,, cittadini di Israele, cattolici di lingua ebraica: un figlio di immigrati dalla Russia e il figlio di profughi vietnamiti. “ Mai più!! Mai più!!” Scrive il Papa nel libro d’onore.
É per questi bambini, come per quelli disabili che il Papa abbraccia nella chiesa in costruzione vicino al luogo dove si ricorda il Battesimo di Gesù in Giordania, che il Papa chiede insistentemente la pace. Costruire la pace è difficile ma vivere senza è un tormento dice Francesco. Pace e violenza sono le parole che si intrecciano in ogni angolo della Terra Santa.
La pace che chiedono i capi di stato, la pace per cui pregano i capi religiosi e la violenza che denunciano gli ebrei come gli islamici. E in mezzo i cristiani. Quelli che da secoli vivono in questa terra e quelli che sono arrivati con le migrazioni recenti, quelli che fuggono perché non si vive tra due fuochi, e quelli che per lavoro arrivano da ogni parte del mondo. Ma soprattutto poveri come quelle famiglie che a Betlemme hanno condiviso la tavola del Papa.
C’era una famiglia di Ikrit, un villaggio dell’alta Galilea, che nel 1948 venne evacuato dall’esercito israeliano e raso al suolo. Solo la chiesa venne risparmiata. E poi una delle 58 famiglie che hanno terreni nella zona di Cremisan, a Beit Jala. Secondo il tracciato previsto del muro di separazione deciso da Israele, questi terreni resteranno oltre il muro, inaccessibili ai proprietari. Qualcuno parla anche italiano. Il Papa ha avuto una parola per tutti.
Pace con un simbolo che è il simbolo stesso di una terra sempre in guerra: l’ulivo. Ne ha piantati due il Papa. Uno nel giardino della residenza del Presidente Peres, e l’altro nel Getsemani. Lo aveva fatto anche Paolo VI, e l’ulivo è ancora lì, visibile per tutti.
“Questo albero è un simbolo di pace e tutti ci auguriamo che il viaggio del Pontefice porti abbondanti frutti di pace” dice fra Benito José Choque, il francescano della Custodia di Terra Santa responsabile del convento e della basilica, argentino come il Papa. Il Giovedì Santo, durante la messa crismale celebrata nella basilica di San Pietro, Francesco aveva consacrato oli ottenuti dalla spremitura di olive degli alberi che si trovano vicino alla basilica dell’Agonia. Non un ulivo qualsiasi quello che ha piantato il Papa ma una talea presa da uno degli otto alberi millenari del giardino, ulivi che hanno 900 anni trapiantati ai tempi dei crociati da alberi più antichi, forse quelli che hanno visto l’agonia di Gesù.
Una pace per la quale si pregherà in Vaticano, forse già nei primi giorni di giugno, come aveva proposto il presidente israeliano nella sua visita al Papa. Un incontro, uno di quegli incontri personali e di preghiera tanto amati da Francesco. Niente diplomazia o politica, solo persone che si guardano negli occhi. Con la speranza che non sia solo un modo di prendere tempo. Qualcuno ricorda che il mandato di Peres termina a luglio e che in Israele il presidente non ha potere decisionale. E così forse anche per Abu Mazen sempre in un difficile equilibrio tra Olp e Hamas. Ma su questo sarà solo la storia a farci capire se si è trattato solo di un fatto di cronaca. Ma è stato bello per molti sentire il presidente Simon Peres riprendere la linea che è stata sempre della Santa Sede: “Una pace basata su due Stati uno accanto all’altro: uno ebraico, Israele e uno arabo, la Palestina”.
É a Gerusalemme che il viaggio del Papa ha avuto il respiro della storia. Cinquant’anni fa. Paolo VI in Terra Santa, Paolo VI che incontra Atenagora a Gerusalemme, Pietro che torna da dove è partito. Due Papi dopo di lui sono tornati in Terra Santa: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ora Francesco ricorda quel viaggio di cinquant’anni fa. Quando Paolo VI ne parlò alla Curia Romana il 24 dicembre del 1963 disse: “ Noi speriamo di incontrare il Signore nel nostro viaggio”. Fu un tripudio di emozioni. Di organizzazione ce n’era ancora molto poca. Nessun rapporto diplomatico con Israele, lo stato palestinese era solo una teoria. Eppure fu un enorme successo. Era il tempo delle grandi speranze. “ Paolo VI calza i sandali e si avvolge nel mantello e si mette in cammino” scrisse François Mauriac all’epoca ricordando Pietro che liberato dalla prigione ascolta l’angelo dire: “Mettiti il mantello e seguimi”.
Al rientro nella udienza generale dice che il viaggio è stato come “un colpo d’aratro che ha smosso un terreno indurito e ormai inerte, e ha sollevato la coscienza di pensieri e di disegni divini che erano stati sepolti, ma non spenti, da una secolare esperienza storica, che ora sembra aprirsi a voci profetiche.”
É un viaggio ecumenico quello di Paolo VI. Ma non interreligioso.
Fu Giovanni Paolo II, il santo, ad aggiungere quell’aspetto di universalità al suo essere nella terra che vide la vita di Gesù. E ci vollero altri 36 anni perché accadesse. Il Papa polacco non fa un blitz, ma rimane sei giorni in Terra Santa. E’ l’anno del Giubileo. L’anno delle richieste di perdono della Chiesa cattolica. L’anno in cui il mondo è pellegrino a Roma.
“Questa terra è santa per gli Ebrei, per i Cristiani e per i Musulmani” dice davanti ai capi delle tre religioni monoteiste. Al Centro Notre Dame propone un progetto che ancora non è stato realizzato: “Se le varie comunità religiose nella Città Santa e nella Terra Santa riusciranno a vivere e a lavorare insieme in amicizia e in armonia, apporteranno benefici enormi non solo a se stessi, ma anche alla causa della pace in questa regione. Gerusalemme sarà veramente una Città di Pace per tutti i popoli.”
Pochi mesi ancora una volta sarà la voce della violenza ad avere la meglio.
Ma ormai la strada è aperta. Benedetto XVI va in Terra Santa e incontra una Chiesa viva anche se sofferente. Maggio 2009, otto giorni ancora tra Giordania, Israele e Territori Palestinesi. Fede, politica e diplomazia si intrecciano in un viaggio in cui il Papa visita non solo i luoghi religiosi, ma anche i luoghi della carità. Lo racconta bene ai giornalisti che saluta in aereo al rientro dal pellegrinaggio: disponibilità al dialogo interreligioso, un clima ecumenico molto incoraggiante e un profondo desiderio di pace da parte di tutti.
La cronaca ci ha detto che questi tre punti di forza non hanno ancora portato i frutti desiderati. Ma questo non scoraggia la Chiesa. Non scoraggia Pietro. Non scoraggia Francesco che riparte proprio dal Santo Sepolcro. Anzi riparte da una dichiarazione congiunta, un testo condiviso che mette al centro non solo il “considerarci gli uni gli altri come membri della stessa famiglia cristiana, sotto un solo Signore e Salvatore, Cristo Gesù, e ad amarci gli uni gli altri, di modo che possiamo professare la nostra fede nello stesso Vangelo di Cristo”. Ma aggiunge i temi “caldi” della difesa della dignità della persona umana in ogni fase della vita, l’importanza del matrimonio e della famiglia, la promozione della pace e il bene comune; e in risposta alle sofferenze che continuano ad affliggere il nostro mondo, il riconoscimento che la fame, la povertà, l’analfabetismo, la non equa distribuzione delle risorse devono costantemente essere affrontate.
C’è tutto questo negli occhi di Pietro ed Andrea che insieme si inginocchiano, pregano, si abbracciano, si sostengono. Perché, dice Bartolomeo di Costantinopoli “la storia non può essere programmata, e l’ultima parola nella storia non appartiene all’uomo, ma a Dio.” Ecco tutte le strategie umane si infrangono “di fronte al giudizio e alla volontà di Dio. Qualsiasi sforzo dell’umanità contemporanea di modellare il suo futuro autonomamente e senza Dio è una vana presunzione.” La risposta di Francesco suona forte nella sua essenzialità: “Non priviamo il mondo del lieto annuncio della Risurrezione! E non siamo sordi al potente appello all’unità che risuona proprio da questo luogo, nelle parole di Colui che, da Risorto, chiama tutti noi “i miei fratelli” .
Certo la strada per la piena comunione è lunga ma “le divergenze non devono spaventarci e paralizzare il nostro cammino. Dobbiamo credere che, come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi.”
E conclude riprendendo un tema che sembrava dimenticato, ma che la stessa rinuncia di Benedetto XVI ha riaperto: l’esercizio del ministero petrino. “Desidero rinnovare l’auspicio già espresso dai miei Predecessori -ha detto il Papa davanti al sepolcro di Cristo- di mantenere un dialogo con tutti i fratelli in Cristo per trovare una forma di esercizio del ministero proprio del Vescovo di Roma che, in conformità con la sua missione, si apra ad una situazione nuova e possa essere, nel contesto attuale, un servizio di amore e di comunione riconosciuto da tutti.” Non ci sono grandi novità, ma c’è uno slancio che nasce anche dalla capacità di Bartolomeo, che dopo anni riesce ad indire un Concilio pan ortodosso.
La tappa finale del viaggio è in un luogo che parla di amore ma anche di discordia: il cenacolo. O meglio l’edificio costruito nel luogo dove la tradizione vuole fosse quella “stanza di sopra” che ha visto nascere la Chiesa. Da secoli è luogo di discordia. Custodisce luoghi santi agli ebrei e i francescani del vicino convento non possono celebrarvi la messa. Lo fece Giovanni Paolo II in privato e ora lo fa Francesco. Non c’è stata nel viaggio una grande messa per i cristiani di Israele come invece in Giordania e Palestina, ma la mancata tappa a Nazaret potrebbe essere recuperata presto. Il Papa, dicono, vorrebbe portare lì i risultati del Sinodo sulla famiglia.
La strada che indica il Papa è quella di un’esodo verso la pace, come ha detto alle autorità palestinesi. É la strada della libertà religiosa per cui, dice in Giordania citando Benedetto XVI: “I cristiani si sentono e sono cittadini a pieno titolo ed intendono contribuire alla costruzione della società insieme ai loro concittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto.”
“E che il Signore ci difenda tutti da quella paura del cambiamento al quale ha fatto riferimento il Re.” conclude citando il sovrano Hascemita.
Ma il gesto che più dovremo imparare a riconoscere è il bacio della mano. Non al Papa, ma del Papa. Al Patriarca di Costantinopoli al Santo Sepolcro come ai sopravvissuti dei campi allo Yad Vashem. É la “modalità Francesco”.
articolo pubblicato su TEMPI n 22- 4 giugno 2014