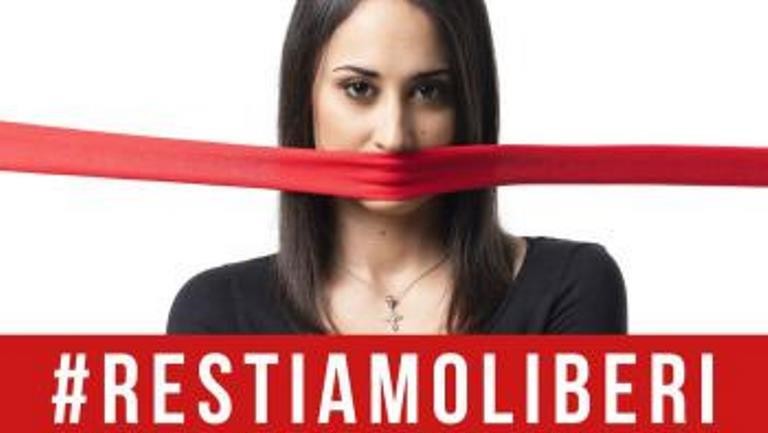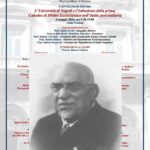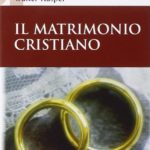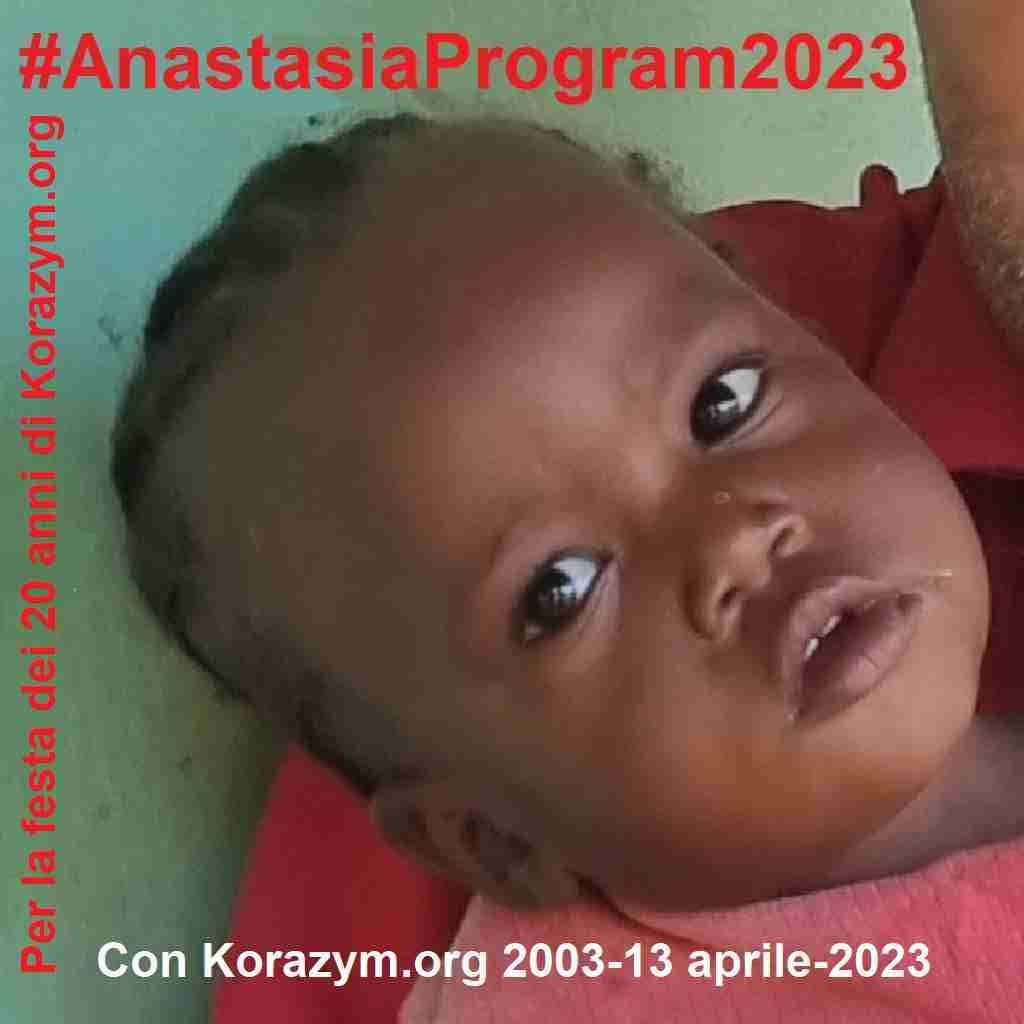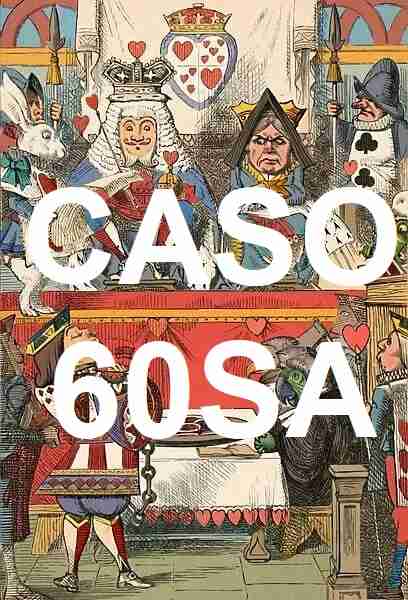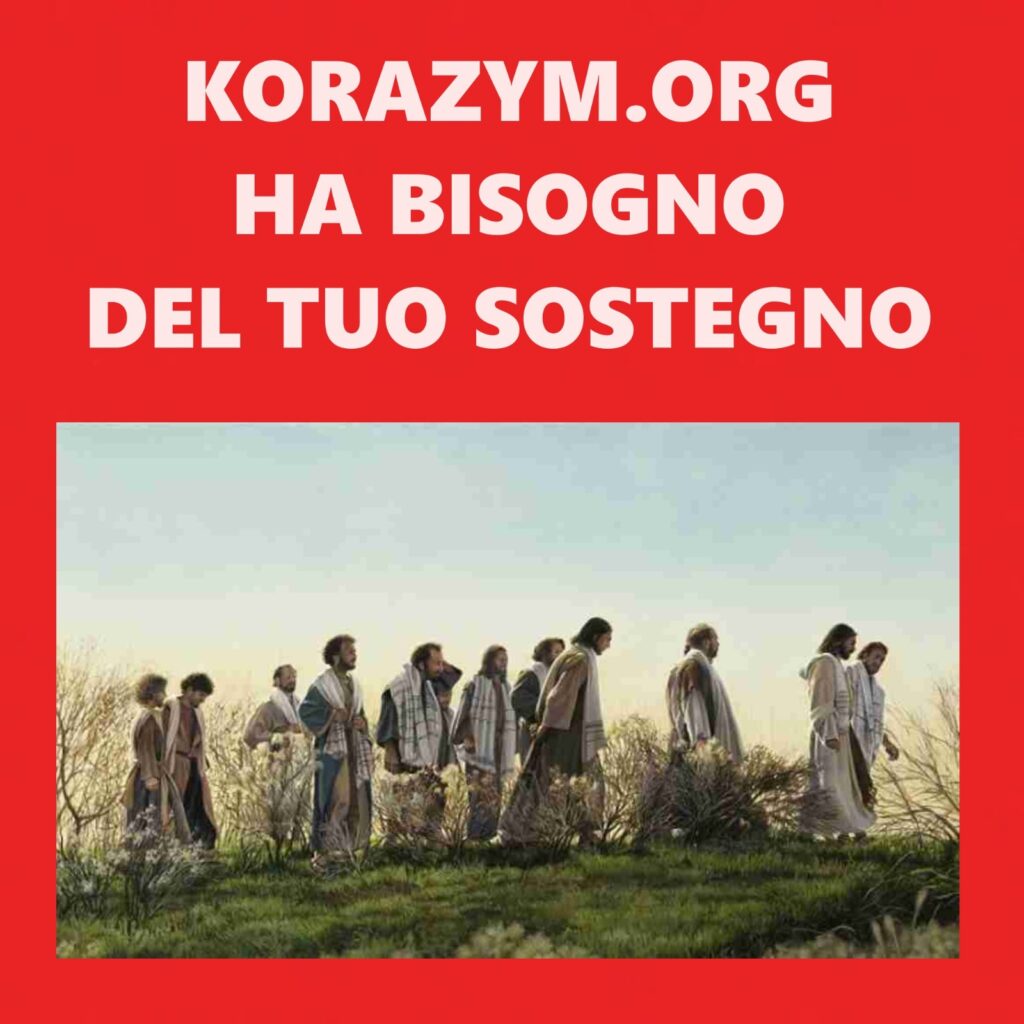Tag Archives: terra
La terra è a rischio

L’Earth day, la Giornata della Terra, è il giorno in cui si celebrano l’ambiente, le risorse naturali e la salvaguardia del pianeta Terra, nata il 22 aprile 1970. Quel giorno, parallelamente all’Earth day, nasceva anche quello che oggi è diventato il moderno movimento ambientalista. Il movimento, che vide la luce negli Stati Uniti, contò circa 20.000.000 di cittadini americani che si mobilitarono in una storica manifestazione in difesa dell’ambiente.
Dopo 54 anni l’Earth day acquista ancora più significato: mai come oggi è di fondamentale importanza rivedere e ripensare il nostro rapporto col pianeta. Un pianeta dalle risorse finite, con ecosistemi sempre più sottopressione e con i cicli naturali che stanno cambiando in maniera così rapida, da non essere in grado di sapere quali saranno le conseguenze nel medio e lungo periodo.
E secondo Coldiretti il consumo di suolo fertile brucia in Italia € 1.000.000.000 di cibo all’anno, con cementificazione e fotovoltaico selvaggio che erodono migliaia di ettari di terreni agricoli aggravando la dipendenza alimentare dall’estero.
Guerre e pandemia non hanno fermato il consumo di suolo che, secondo l’ultimo rapporto Ispra, anzi, ha accelerato arrivando a ‘cancellare’ 76,8 km quadrati ettari di terreni, alla velocità di 2,4 metri quadrati al secondo. Un dato in aumento del 10% rispetto all’analisi precedente e che ci dicono che, complessivamente, le superfici occupate ammontano a poco meno di 2.200.000 di ettari (il 7,14 % del totale nazionale):
“Ai danni causati dalla cementificazione, si stanno aggiungendo quelli del fotovoltaico selvaggio con la copertura di intere aree agricole produttive con distese di ettari di pannelli a terra. Impianti spesso realizzati da fondi di investimento speculativi e resi possibili da un far west normativo che deriva dall’assenza di regole di governo del territorio”.
La provincia di Viterbo rappresenta un caso simbolo, dove gli agricoltori della Coldiretti stanno lottando contro la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra e di pale eoliche in una situazione in cui quasi la metà della superficie agricola utilizzata in provincia è stata già occupata dai pannelli:
“L’erosione di terreni fertili mette oggi a rischio la sovranità alimentare del Paese ed è necessario invertire la rotta, mettendo finalmente dei paletti al fotovoltaico selvaggio. Un altro passo essenziale è accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio”.
Per tale motivo la terra resta un richiamo irresistibile per oltre 6 italiani su dieci (61%) che a primavera dedicano parte del tempo libero alla cura di orti, giardini, balconi e terrazzi per garantirsi frutta, verdura e aromatiche da portare in tavola o fiori per abbellire la propria casa.
La forma di coltivazione più diffusa è quella nell’orto o nel giardino, seguita a breve distanza dai terrazzi e dai balconi, soprattutto nelle grandi città, dove c’è anche chi deve accontentarsi del davanzale della finestra. Una minoranza si mette al lavoro in uno degli orti pubblici messi a disposizione dalle amministrazioni locali. In Italia occupano circa 2.000.000 di metri quadrati, secondo l’analisi Coldiretti sugli ultimi dati Istat:
“Ma ci sono anche molti italiani che non si accontentano e hanno a disposizione almeno un ettaro di terreno a uso familiare. Si tratta in larga maggioranza di famiglie che hanno ereditato aziende o pezzi di terreno da genitori e parenti dei quali hanno voluto mantenere la proprietà per esercitarsi nel ruolo di coltivatori e allevatori, piuttosto che venderli come accadeva spesso nel passato.
E c’è anche chi ha acquistato terreni o piccole aziende agricole anche in aree svantaggiate per ristrutturarle e avviare piccole attività produttive, dall’olio al vino, dall’allevamento delle galline a quello dei cavalli”.
E non è un costo esoso realizzare un giardino: “L’investimento per realizzare un orto tradizionale in giardino si può stimare intorno ad € 300 per 20 metri quadrati ‘chiavi in mano’ per acquistare terriccio, vasi, concime, attrezzi, reti per delimitare le coltivazioni, sostegni vari, sementi e piantine. Individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole fondamentali per ottenere buoni risultati”.
Inoltre un recente studio di ActionAid ha rivelato che i finanziamenti privati alle cause della crisi climatica superano di 20 volte gli investimenti pubblici nelle soluzioni per contrastarla. Nei 7 anni successivi all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, le principali banche private mondiali hanno investito complessivamente $ 3.200.000.000 nell’espansione dei combustibili fossili, mentre altri $ 370.000.000.000 sono stati destinati sotto forma di prestiti e garanzie all’agricoltura industriale.
Antonio Caschetto: in Quaresima con ‘Laudate Deum’

“Sono passati ormai otto anni dalla pubblicazione della Lettera enciclica Laudato si’, quando ho voluto condividere con tutti voi, sorelle e fratelli del nostro pianeta sofferente, le mie accorate preoccupazioni per la cura della nostra casa comune. Ma, con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. Al di là di questa possibilità, non c’è dubbio che l’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e in altri ambiti”.
Così inizia l’esortazione apostolica ‘Laudate Deum’ di papa Francesco, nella quale si ritrova alcuni temi principali delle sue due encicliche precedenti, ‘Laudato sì’ e ‘Fratelli tutti’: l’urgenza di affrontare la crisi sociale e ambientale, l’ascolto della scienza, la critica al paradigma tecnocratico, la volontà di costruire un ‘noi’ in grado di prendersi cura della casa comune, mediante il lavoro delle istituzioni internazionali e il protagonismo della società civile.
A Macerata la scuola missionaria della diocesi ha invitato l’architetto Antonio Caschetto, Pojecct Manager del Centro ‘Laudato Sì’ ed Advisor del Programma Globale dei Circoli ‘Laudato sì’, a cui abbiamo chiesto di spiegarci il motivo per cui papa Francesco invita a lodare Dio: “E’ nella natura dell’uomo essere creatura ed è dovere di ognuno di noi lodare il Signore attraverso le sue creature”.
Quali sono le motivazioni spirituali dell’enciclica ‘Laudate Deum’?
“L’enciclica è un documento molto pratico, perché è un invito alla transizione ecologica in maniera chiara; però all’interno di essa ci sono motivazioni spirituali molto forti, che attingono alla tradizione della Chiesa ed ai documenti del magistero. Il papa ribadisce in questo documento queste motivazioni spirituali. Con diverse citazioni da ‘Laudato sì’, è richiamata la comprensione biblica del mondo come creazione e possesso esclusivo di Dio, l’atteggiamento di Gesù che sapeva cogliere nel mondo la bellezza seminata dal Padre e la presenza del Risorto che avvolge il mondo materiale. Viene rimarcata l’opposizione tra la fede che ci fa sentire uniti alle altre creature e il paradigma tecnocratico che ci isola dalle realtà circostanti”.
Ad Assisi nascerà nel mese di maggio il Centro ‘Laudato Sì’: di cosa si tratta?
“L’idea è quella di rendere Assisi un luogo di promozione dell’ecologia integrale attraverso il ‘Cantico delle creature’ ed attraverso il creato, perché la città parla con una spiritualità particolare. Con la collaborazione della diocesi e con i francescani cerchiamo di portare avanti questi temi. Consentirà, a tutti coloro che operano nell’ambito dell’ecologia integrale e ai pellegrini in visita ad Assisi, di vivere i luoghi francescani con attività di formazione, incontro e spiritualità nel creato”.
Cosa sono i ‘luoghi Laudato sì’?
“Tutto il Movimento ‘Laudato Sì’, e coloro che hanno a cuore l’ecologia integrale, vedono in Assisi un punto di riferimento. Il cammino sinodale svolto in questi anni con la diocesi di Assisi, con i francescani, con le religiose e i religiosi, i laici, la Pro Civitate Christiana, il FAI ed il Comune, ci ha suggerito di proporre un ‘ecosistema di luoghi’ che possano rappresentare per i pellegrini e per i visitatori opportunità di sensibilizzazione, di formazione e spiritualità. ‘Terra Laudato Sì’ nasce dal desiderio di vivere luoghi dell’incontro nella città del Poverello. Soprattutto il nostro desiderio è che siano luoghi di incontro tra persone in contatto in varie parti di Italia e del mondo, ma anche luogo di incontro con Dio che ci parla attraverso il creato. San Francesco può essere un ottimo modello per entrare in dialogo con Dio attraverso questo linguaggio”.
A maggio si terrà anche la ‘Settimana Laudato Sì’ sul tema della speranza: di cosa si tratta?
“Questa settimana si celebra a fine maggio per ricordare la pubblicazione dell’enciclica, fatta il 24 maggio 2015. Non è solo un ricordo, ma un modo per attivarsi concretamente. Quest’anno il tema è la speranza. E’ molto bello, perché la Santa Sede invita tutte le comunità a camminare insieme ed a prendere impegni concreti per la tutela dell’ambiente. La speranza è uno strumento che ci consente di superare la legge naturale del decadimento. La speranza ci è data da Dio come protezione e guardia contro la futilità. Solo attraverso la speranza possiamo realizzare in pienezza il dono della libertà. Libertà di agire non solo per raggiungere divertimento e prosperità, ma per raggiungere la fase in cui siamo liberi e responsabili”.
Per quale motivo sperare per la terra è sperare per l’umanità?
“La speranza è quell’ancora che dà senso alla vita. Molto spesso il mondo sembra dirci che non abbiamo speranza; invece abbiamo bisogno di riprendere quest’ancora con maggior consapevolezza. C’è una frase comunemente attribuita a sant’Agostino che dice: ‘La speranza ha due belle figlie; i loro nomi sono Rabbia e Coraggio. Rabbia per come stanno le cose e coraggio di vedere che non rimangano come sono’. Mentre assistiamo alle grida e alle sofferenze della terra e di tutte le creature, lasciamo che la santa rabbia ci spinga verso il coraggio di essere fiduciosi e attivi per la giustizia. Crediamo che l’incarnazione del Figlio di Dio offra una guida che ci consenta di affrontare questo mondo inquietante. Dio è con noi nel tentativo di rispondere alle sfide del mondo in cui viviamo”.
Con mercoledì delle ceneri è iniziato il tempo quaresimale: cosa propongono i circoli ‘Laudato sì’ per vivere questo tempo?
“A livello internazionale il movimento propone un cammino con l’invito a fermarsi ad ascoltare. E’ un invito a rallentare i ritmi della propria vita ed a vivere nel creato la quaresima come tempo di ascolto attraverso un impegno concreto per un mondo migliore. Lo facciamo con la preghiera e con l’aiuto dei sussidi, che sono inviati quotidianamente attraverso whattsap a chi si iscrive nel sito del movimento”.
Presentata l’enciclica ‘Laudate Deum’

Dopo la pubblicazione dell’esortazione ‘Laudato Sì’ nei giorni scorsi è stata presentata l’esortazione apostolica ‘Laudate Deum’, pubblicata nel giorno della festa di san Francesco d’Assisi dal premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, dall’attivista ambientale indiana Vandana Shiva, dal fondatore di ‘Slow food’ Carlo Petrini, che insieme ad altri ambientalisti e studiosi hanno partecipato alla conferenza organizzata dalla Sala Stampa Vaticana e dal Dicastero per la comunicazione sul tema: ‘Laudate Deum: voci e testimonianze sulla crisi climatica’.
Papa Francesco: solo Cristo disseta

“La Messa è azione di grazie, ‘Eucaristia’. Celebrarla in questa terra mi ha fatto ricordare la preghiera del padre gesuita Pierre Teilhard de Chardin, elevata a Dio esattamente 100 anni fa, nel deserto di Ordos, non molto lontano da qui… Padre Teilhard era impegnato in ricerche geologiche. Desiderava ardentemente celebrare la Santa Messa, ma non aveva con sé né pane né vino. Ecco, allora, che compose la sua ‘Messa sul mondo’, esprimendo così la sua offerta: ‘Ricevi, o Signore, questa Ostia totale che la Creazione, mossa dalla tua attrazione, presenta a Te nell’alba nuova’. E una preghiera simile era già nata in lui mentre si trovava al fronte durante la Prima guerra mondiale, dove operava come barelliere”.
Ad Amelia ‘Madre Terra, Sorelle Stelle’
Pellegrinaggio all’ultimo martire di Tibhirine

‘Semplice, solenne, quasi gioioso’. Mi parla del rito di sepoltura di père Jean-Pierre, l’ultimo monaco sopravvissuto di Tibhirine. Anne me ne parla con quella freschezza di emozione, come fosse accaduto ieri… e sono passati quasi due anni. In tutti i presenti, – confessa, poi – vi era la consapevolezza, triste e serena, di seppellire l’ultimo pezzo della storia di Tibhirine.
Un grido dal mondo: salvare la terra

“Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato. Perciò, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio”: con questi tweet papa Francesco ha ricordato la Giornata della Terra, celebratasi sabato 22 aprile.
XX domenica Tempo Ordinario: sono venuto a portare il fuoco sulla terra!
La terra deve essere salvaguardata

Oggi nel mondo si celebra la Giornata della Terra, l’Earth Day, che da 52 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la salvaguardia del pianeta, con il tema ‘Invest In Our Planet’ (‘Investire nel nostro pianeta’), focalizzato sull’accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.