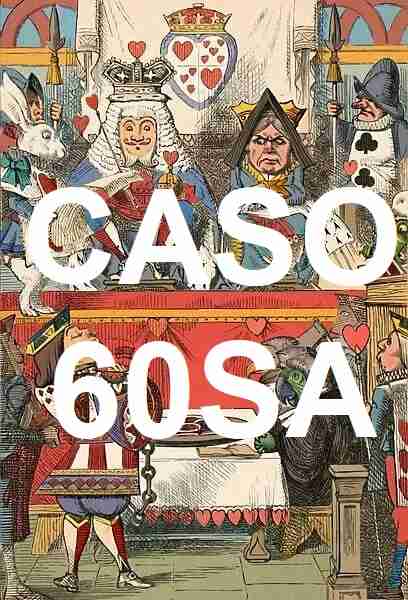Che fine ha fatto il giornalismo? Perché si accentua sempre di più l’autocensura, lo scrivere sotto dettato e con le veline, pure scritte male, copiate e incollate a malo modo?

Le abbiamo provato tutte. Tutte le vie abbiamo percorso, per provare a far capire dove sono andati a finire i vaticanisti, quei giornalisti, accademici o commentatori la cui area di competenza è lo studio e la comprensione del modo di operare della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano e della Chiesa Cattolica Romana (tre realtà specifiche e distinte, di cui il Sommo Capo con poteri assoluti è il Vescovo di Roma e, quindi, quasi sempre al centro dell’attenzione. Dove sono andati a finire, non nel senso di un luogo o di una testata di appartenenza, ma del loro modo di esercitare la loro professione.
L’abbiamo fatto con conoscenza diretta di quel mondo da circa mezzo secolo, ex professo per tre decenni di servizio presso la Sala Stampa della Santa Sede, l’Olimpo a cui aspira ogni “vaticanista”. Anche se non è sufficiente avere la tessera di accreditamento per essere per davvero un vero vaticanista, non solo di nome seduto nella Sala di lavoro intitolata (per merito di un suo successore, anche se solo ad interim e per tempi troppo brevi, Alessandro Gisotti) al indimenticabile Joaquín Navarro-Valls, direttore, amico e maestro. Lo si diventa – me lo spiegò un acuto monsignore della Congregazione per il Clero all’inizio degli anni ’70 – consumando scarpe, caffè e cene per alcuni decenni, crescendo con i monsignori della Curia romana che diventano cardinali (e talvolta anche papi).
Abbiamo provato a spiegare lo stato comatoso in cui versa la comunicazione istituzionale della Santa Sede & Co (al cui mondo appartengono i vaticanisti come giornalisti embedded, anche se spesso e volentieri se lo dimenticano cosa significa questa condizione professionale, liberamente scelta), con dei ragionamenti logici, con l’esposizione dei fatti che non sono opinioni, con la denuncia dei malcostumi (lo scrivere sotto dettato e riportando delle veline scritte pure male, spesso non essendo in grado di scrivere bene, neanche di fare un dignitoso copia-incolla, quindi peggiorando le cose), dell’esposizione delle assenze (l’autocensura e l’autoinganno), del vizio della marchetta (per ringraziarsi il “protettore-informatore” di turno per niente desinteressato… trattandosi di un stupido e volgare do ut des, piuttosto che di un intelligente e signorile do ut facias), ecc.
Spesso ci viene anche detto che perdiamo nostro tempo (che è prezioso, vero), perché in questi tempi di analfabetismo funzionale (e non solo) la maggioranza dei lettori non va oltre una foto, un meme o un titolo e – se va veramente bene – legge pure un incipit (io, invece, spesso inizio con le conclusioni, per andare a ritroso).
Però, visto che nostro scopo non è di far cambiare opinione al lettore, ma di far ragionare in modo informato e logico, proseguiremo con resilienza sulla via della metacognizione.
Ieri abbiamo riportato un’osservazione di un vaticanista acuto osservatore dei costumi del sottobosco della Curia romana – non è necessario essere d’accordo sempre con un commentatore, per apprezzare le sue esposizioni dei fatti (non si guarda il dito ma la luna che indica) – il Direttore dell’aggregatore para-vaticano Il Sismografo, che scrive [QUI]: «Lo sconcerto e disorientamento di fronte a delle decisioni e comportamenti di Francesco e di alcuni suoi collaboratori hanno posto a moltissimi cattolici domande che tuttora restano senza risposte. Forse la critica principale fa riferimento all’autoritarismo del Pontefice, questione sulla quale buona parte della stampa specializzata accentua sempre di più l’autocensura e non si capisce il perché».
Oggi proviamo un’altra volta a trovare una risposta alla domanda sul perché il silenzio stampa è calato e la quasi totalità dei “vaticanisti” si è incredibilmente omologato all’oscurità. Proviamo di andare oltre la spiegazione fornita da Franca Giansoldati, la vaticanista del Messaggero, perché si sa ”altrimenti ti sanzionano”. Anche se queste tre parole sono già una sentenza letale, emessa da una giornalista con cui siamo entrati spessi in polemica, ma a cui dobbiamo dare merito che non le manca la grinta e a cui qualche spinta giornalistica vera è ancora rimasta. Nonostante tutto.
Oggi lo proviamo con l’ironia o il sarcasmo, con la parabola, l’iperbole o la similtudine – scegliete voi (che siete arrivati fino a qui) di quale figura retorica si tratta, dopo aver letto quanto esposto – usata dalla giornalista e scrittrice Benedetta de Vito [**], nel rilancio del 26 marzo 2021 sul blog Stilum Curiae di Marco Tosatti, che si domanda: “Ma che fine hanno fatto i giornalisti in Italia? Quelli veri, dico”. Anche se qui si parla di giornalismo in generale, nostri attenti lettori non avranno difficoltà di trovare paragoni con la particolare categoria dei vaticanisti [*].
Commenta Tosatti, giornalista vaticanista di razza di altri tempi: «Benedetta de Vito compie una mesta riflessione sullo stato della categoria professionale a cui appartiene, i giornalisti. Tutto quello che c’è da dire è che mi sembri sia persino troppo gentile e misericordiosa. Non siamo mai stati una categoria onorevolissima, nell’insieme; ma purtroppo da quello che si vede stiamo toccando livelli da sonda petrolifera. L’informazione così come ci viene propinata oggi dai grandi giornali e dalle televisioni farebbe venire l’acquolina in bocca a Goebbels e ai direttori della Pravda… Mesta lettura».

“I gatti di Gasparo Gozzi e le patate di Gianpietro Talamini”
«Per diventar giornalista professionista, scrissi, tanti anni orsono, una tesina intitolata “I gatti di Gasparo Gozzi e le patate di Gianpietro Talamini”. Erano cinque paginette dedicate al giornalismo veneziano, essendo Gozzi il fondatore della “Gazzetta veneta” e Talamini quello del “Gazzettino”, dove allora lavoravo.
Che c’entravano i gatti con le patate, è spiegato in riassunto così: i gatti di Gozzi somigliano, secondo lui e anche secondo me, ai giornalisti. E Talamini era un vero giornalista. Un cadorino, che, per far camminare la sua barchetta in laguna, vendeva patate del Cadore, stipate nelle stanze della redazione.
E prima di continuare e di arrivare dalla buccia al sodo, ecco in dono per voi la descrizione, deliziosa, che Gozzi fa dei suoi gatti-giornalisti: “Il gatto solo ha conosciuto, come Aristotile, la via del mezzo, e tanto si rese domestico quanto può bastare al suo mantenimento, e tanto rimase selvatico, quanto può fare che gli uomini non gli comandino liberamente” [lo confermano Chanel e Seville, i due felini miei padroni di casa, che – in questo senso – mi tollerano come coinquilino, dandoli in ricambio riparo, cure, giochi, lettiera e acqua puliti, crocchette e umido. V.v.B.].
E questi, sissignore, erano i giornalisti di una volta, quelli che, come il mio amato caporedattore Giampiero Rizzon, mi hanno insegnato il mestiere, insieme al dizionario e alla grammatica italiana. Quelli di un tempo, certo, perché i giornalisti di oggi, ai tempi della psico-pandemia, mi sembrano dei ripetitori automatici delle veline che qualcuno scrive (e male) per loro.
E torniamo, se avrete la pazienza di leggermi un poco, ab ovo. Ho preso la tessera rossa, da professionista, quando già la redazione romana del Gazzettino stava chiudendo la porta, lasciandomi, senza più scrivania, sola e smarrita, in Piazza San Silvestro.
Per anni, per più di vent’anni, seduta al mio banco, con lo sguardo in delizia alla torre campanaria di San Silvestro in Capite, nel suo girotondo di maioliche color sfumature del mare, avevo scritto in qualità di “pubblicista part time”, pezzi belli e brutti su tutto ciò che mi veniva richiesto, dal Csm al pacchetto anti-racket, fino dalla Biennale di architettura. Per sostenere l’esame di Stato, però, avevo studiato molto, pur già donna fatta e madre, mancando ai miei studi la giurisprudenza.
Ma il giornalismo: lavorare nel rumore, sentire la gente per la strada, scrivere per i gondolieri, no, quello lo avevo imparato sul campo, stando tra notizie, agenzie e colleghi, fin da ragazza ancora da laureare. Sapevo, io, che per dare una notizia, bisognava approfondire, aver le prove, fonti credibili. E ci vuole tempo. Sentiamo Sergio Lepri, mitico ex direttore dell’Ansa, che mette tutto in ordine: il giornalista è mediatore tra la fonte e il lettore. Il giornalista raccoglie le notizie, le controlla, le seleziona e le offre al lettore.
Capirete voi che questo processo non si può fare in un fiat. Tutto ciò premesso e ben inamidato, sbigottita assisto da un anno e più a tutto il contrario, in spregio del manuale di deontologia. Cioè allo spettacolo dei miei colleghi che, mi pare, con gran superficialità, snocciolano dati, cifre, elenchi senza chiedere, ad esempio, di verificare le cartelle cliniche di chi muore, di guardare le carte, di leggere i bugiardini di farmaci e vaccini. Di verificare, insomma, studiare, meditare, verificare e selezionare le notizie.
Niente, tutto in fretta e furia, sparato con il megafono e con i macabri toni della paura. Quando mostrano le terapie intensive, o due letti e tanti palombari intorno oppure panoramiche pietose (e i diritti del malato?) su persone di cui dobbiamo credere che siano lì per il Covid…
Intanto, nelle nostre città paralizzate da Moloch che soffia fiato di Malefica, e che dovrebbero essere percorse solamente da ambulanze in corsa, che portano i pazienti in ospedale a farsi intubare, non si sente mai ronzare una mosca e tantomeno suonare una sirena. E questo, per me, davvero un mistero. Si vede che, a forza di fare gli inutili corsi (obbligatori) sui massimi sistemi per la formazione continua, si è perduto il nocciolo della professione che è, alla fin fine, fiutar la notizia, seguirla e trovar gli appoggi per sostenerla. E usar occhi, orecchie, cervello e cuore. Più che giornalisti, mi sembra, e dico sembra, che siano tutti uffici stampa del governo, del comitato scientifico, dei vari ministri. O di chissà chi altro.
E cosa quanto mai sorprendente, nel vomitar paura in forma di numeri, i telegiornali sono diventati, sissignore, tutti uguali, identici, spiccicati. Tutti quanti tgCovid. Giornali in uniforme, come me ai tempi verdi quando frequentavo l’Istituto Mater Dei e le anime belle di sinistra criticavano la gonna blu, la camicetta bianca e il basco in testa. Bei tempi, devo dire, quando il Tg1 era della diccì, del Psi il Tg2 e il tg3, TeleKabul, cioè dei comunisti.
Oggi, no, tutto è monocorde, monoparola, un verbo che non è il Verbo. Oggi, un tiggì vale l’altro perché niente sfugge al controllo del brodo nero del terrore, servito a tutte le ore. Un virologo, ad esempio, intervistato alle 13 45 al Tg1 te lo ritrovi al Tg4, alla sera, a dir le stesse cose, oppure cambiate un poco. Che fa tanto nel diluvio di parole al vento nessuno più si accorge di nulla. Sono i giornalisti come dei fedeli, devoti alla Parola che viene loro data dal Comitato Scientifico, gran sacerdote della verità (!), tutta umana, di cui si fanno eroici promotori.
Mentre spengo televisore e radio, sento in me una voce (che amo) che mi chiama. Sì sì, perché mi meraviglio, è quel che accade a me, da quando dodici anni orsono, il Signore mi ha chiamata, obbligandomi a lasciar tutto ciò che facevo e che ho ripreso a fare soltanto ora che di anni ne sono passati due sporte piene.
In che senso, chiedete? Nel senso che anche i giornalisti di cui ho scritto sono come me: hanno fede! Solo che io ho fede nel Signore e da Lui soltanto mi lascio condurre. Loro, invece, han fede nella scienza, nella politica, nei vaccini, nelle cose del mondo. In tutto il latinorum che siede sotto l’arcobaleno di Satana.
Quando l’Italia fu chiusa, lo scorso anno, han creduto che, in estate tutto sarebbe tornato come prima.
Poi han creduto e ci han fatto credere che a Natale ci saremmo abbracciati.
Poi che il vaccino, fatto arrivare nel nostro Paese, in pompa magna, proprio nel giorno in cui nasceva il Santo Bambino, cioè il vero e unico Salvator mundi fosse la panacea. E invece forse uccide.
Poi han creduto nei tamponi, nelle varianti, nel lockdown, nell’orrido “tutto andrà bene”. E ora siamo di nuovo prigionieri e ci tocca anche celebrare il giorno della memoria.
Sai che risate si fa la scimmia, l’altro, il Capo loro!
Vabbè, tenendo in braccio Casper, lui sì un gatto giornalista, corro alla mia Santa Messa quotidiana e al Signore lascio il giudizio che non spetta, per fortuna, a me su tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi».
Benedetta de Vito
[*] Il vaticanista – un neologismo nato con la grande diffusione della stampa e dei media, nella prima metà del XX secolo – è una figura professionale specialistica presente presso varie testate giornalistiche, sia laiche sia religiose, analoga al cosiddetto giornalista embedded che è al servizio di una parte in guerra, il parlamentarista, il quirinalista, lo sportivo, ecc.

[**] Benedetta de Vito è una giornalista e scrittrice che, per quanto ancora giovane, ha avuto una vita ricca di esperienze, sentimentali e professionali, che l’hanno segnata sicuramente nel bene. Ma c’era qualcosa in lei che, lo sentiva, non andava, un senso di imperfezione che voleva assolutamente correggere. “La mia vita era in fiamme” scrive nel libro C’ero una volta. La mia vita nel respiro del Mistero (Oltre edizioni 2019, 146 pagine). Così si è messa in viaggio, in cerca di una meta della quale lei stessa non aveva idea. Poi l’incontro con Beata Elisabetta Canori Mora e quindi con Santa Caterina, che l’hanno instradata nella fede, donandole la pace del cuore.

Questo libro è il racconto della sua ricerca, in un confronto con le due sante che è molto coinvolgente sul piano esistenziale e culturale anche per un non credente. Perché, se è vero che la religione cattolica le ha offerto gli strumenti per condurla alla fede, è anche palese che, come leggeremo attraverso la sua prosa non esente da momenti di alta poesia, l’autrice non la vive come un piatto già pronto e cucinato come per la maggioranza dei fedeli che la seguono, ma in lotta continua col dubbio.
“C’ero una volta”
«Nel mio andar controcorrente, fin da bambina, mai pensavo che un giorno (molti e molti anni dopo), da lassù, la grazia mi avrebbe portato, nella santa purificazione, a vivere nella vita vera, faccia a faccia con la verità nuda, con la pace nel cuore. E ora che, dieci anni dopo la chiamata in fiamme, tutto si stira in una mia segreta e dolce consacrazione, tra le braccia della Santa Romana Chiesa, ho pubblicato un libro piccino che racconta, con storiette, aneddoti, alla maniera delle storie tragicomiche che qui ho scritto per anni e mesi e giorni, gli incontri che han segnato il mio cammino, nel bacio del divino che incontra noi miseri mortali.
Il libro si intitola “C’ero una volta”, perché davvero non sono più quella che ero, con sottotitolo “La mia vita nel respiro del Mistero” perché la vera vita è, sì, un Mistero. La casa editrice, neanche a farlo apposta, si chiama Oltre edizioni, ed è una piccola casa editrice ligure, che conoscevo appena».
Benedetta de Vito
L’itinerario percorso da Benedetta de Vito, per altro molto colto, presso le bambine di Dio, ci ha dato un libro molto bello proprio per questa lettura personale e profonda che anche il più laico di noi può apprezzare per la luce di verità che trasmette, segnando un cambiamento dopo il quale poter dire, mutuando, per la sua storia, dall’inizio di tutte le favole “C’ero una volta”. Un libro denso di fede e di memoria, molto personale, come potrete capire da questo incipit del viaggio di Benedetta nella santità di due donne straordinarie, e nella ricchezza eccezionale di Roma.
“Nella comunione dei Santi”
«Bambina, ho avuto la gioia e il privilegio di avere una nonna, Lisetta, (rimasta un poco bimba anche nel suo nome vezzoso) che, al pomeriggio, quando stanco il dopopranzo sembrava non sciogliersi mai nell’ora di merenda, tirava fuori un gran libro con copertina cartonata dal titolo semplice, “I Santi del giorno”, e leggeva a voce alta, qui e lì. Da lei seppi ad esempio che il termine cappella viene da cappa, ossia mantello: il mantello che San Martino diede, tagliandolo a metà, a due poveri infreddoliti e che i re merovingi veneravano nel loro oratorio. Un angolo chiamato per metonimia (cioè una parte per il tutto) col nome di cappella, piccola cappa. La parola ora indica un particolare luogo consacrato in tutte le chiese del mondo.
San Martino, lo conoscevo appunto, per il mantello donato ai mendicanti e perché, a metà novembre, regalava la sua fragile estate radiosa. Io, piccola, lo vedevo vivo nell’atto del dono. Conoscevo già anche le due Terese, la grande e la piccola, e alla piccola preferivo, non so perché, la grande. Poi c’era Santa Monica che aveva un figlio scapestrato di nome Agostino, Sant’Agnese coi bei capelli lunghi a coprir le nudità, Santa Caterina, bionda, bellissima, con la ruota e le mistiche nozze col Bambino. Li conoscevo, i Santi, nei racconti della nonna Lisetta, che mi faceva vedere il vermiglio delle loro gote, i piedi innocenti, gli occhi in preghiera.
Poi gli anni sono passati, la nonna è andata lassù (con pianto mio), io mi sono fatta donna e ho letto molti e molti libri di e sui Santi, compresa la “Filocalia” e l’”Imitazione di Cristo e la “Salita del Monte Carmelo” e certo ora ne so tanto di più. Eppure l’incanto infantile continua a colorarli di stupore. Luminosi, i racconti della nonna Lisetta li restituiscono alla memoria e addirittura al mio sguardo e mi sembra quasi di conoscerli meglio, passando attraverso la bimba che sono stata. Mi pareva, allora, nella mia età verde, che la verità che cercavo fosse tutta quanta racchiusa in quelle misteriose esistenze perdute nella lontananza dei secoli passati. Nel leggere i loro scritti, adesso in età matura, ne ammiro la modernità, il logico ragionare, entro in muto colloquio con loro, li sento vicini, facendoli entrare nella mia vita. Ma, nell’innocenza bambina, con l’amore acceso e il cuore in impeto di petto, li conoscevo, diciamo così, per osmosi, come abitando dove abitano loro, con la sapienza tenera del cuore che è la verità…
Ad esempio, io, tornata piccina pur già donna e mamma, camminando tra il Rione Monti e Trinità dei Monti, ho incontrato la Beata Elisabetta Canori Mora, trinitaria scalza, sposa e madre e con lei non ho smesso mai di camminare.
Ma prima che ciò avvenisse, prima, cioè, che Elisabetta prendesse a camminarmi al fianco, doveva accader altro, un piccolo prodigio che mi s’apparecchiò davanti durante una delle tante mie libere passeggiate romane, in solitaria, in compagnia soltanto del respiro, nel dolce meriggiare d’autunno».
Benedetta de Vito
Si può acquistare il libro “C’ero una volta” QUI.
Sul blog Storie di Territori di Giampaolo Pepe potete leggere alcuni articoli recenti di Benedetta de Vito: QUI.
Articolo precedente di Benedetta de Vito [Nell’era della sciatteria galoppante, il ricordo e la difesa dell’eleganza regale dell’umile Papa Benedetto XVI – 3 dicembre 2020].