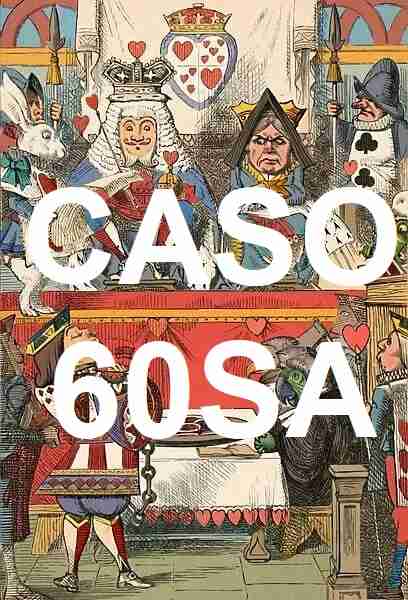Canto d’ usignolo e gracidio di rane

Giovanni Pascoli, tra le tante sue splendide poesie, ce ne offre una dal titolo: Nozze a G. V.
Pur nella sua semplicità, apparentemente infantile, la poesia rivela tanta saggezza. Leggiamola:
Dava moglie la Rana al suo figliolo.
Or con la pace vostra, o raganelle,
il suon lo chiese ad un cantor del brolo.
Egli cantò la cobbola giuliva
parve un picchierellar trito di stelle
nel ciel di sera, che ne tintinniva.
Le campagne addolcì quel tintinnio
E i neri boschi fumiganti d’oro.
tiò tiò tiò tiò tiò tiò tiò tiò tiò
torotorotorotorotix
torotorotorotorolililix.
È notte: ancora in un albor di neve
sale quest’inno come uno zampillo;
quando la Rana chiede, quanto deve:
se quattro chioccioline, o qualche foglia
d’appio o voglia un mazzuolo di serpillo,
o voglia un paio di bachi, o ciò che voglia.
Oh! rispos’egli: nulla al Rosignolo,
nulla tu devi delle sue cantate:
ei l’ha per nulla e dà per nulla: solo,
si l’ascoltate e poi non gracidate.
Oggi, quanto gracidio in questa bufera d’arte musicale, e non solo!
Oggi, ci troviamo di fronte alla difficoltà di un linguaggio consunto e ripetitivo. In effetti, la vita è intessuta di ripetizioni e si sa che l’uso corrode ciò che è usato e si consuma. La ripetizione, però, si dovrebbe compiere in tutta la freschezza della sua novità, come se si realizzasse per la prima volta.
Oggi, certa vuota retorica giornalistica e occasionale non scende nella profondità del pensiero pensante del cuore. La pubblicità sconsiderata a base di superlativi, talvolta falsi e dannosi, che imperversa sia in campo politico e sportivo che soprattutto in campo commerciale, ha tolto la fiducia in qualsiasi realtà che abbia valore culturale. L’uomo rischia di perdere il suo centro interiore che dà sostegno alla personalità e orientamento al corso della sua vita.
Nonostante la pretenziosità dei suoi discorsi e il rumore che fa col suo agire, l’uomo contemporaneo diventa sempre più incerto e sotto la sua baldanza sta in agguato un’angoscia sempre più minacciosa e mortale.
La valanga di parole, poi, che si riversano ininterrottamente senza ordine e scelta dai mezzi di comunicazione, ha saturato la società con una sottocultura di basso profilo: la parola non ha più senso e valore perché è diventata gracidio ambiguo e volgare. È necessario, pertanto, eliminare la “Babele” sonora con una convincente e avvincente “carità culturale”.
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! (Ap 19, 9).
Oggi, la beatitudine degli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello è espressa con la nobiltà del canto o con il volgare gracidio? Mi riferisco a quell’arte musicale che è a sevizio della Santa Celebrazione Liturgica. Siamo d’accordo per l’apertura a tutti i linguaggi, ma purché questi non siano espressioni di carnevalesco gracidio, infantilistico e festaiolo, privo di quell’arte degna d’inneggiare, col cuore e con le labbra, al Mistero trinitario che s’incarna nella nostra vita attraverso il sublime sacramento del suo venire-restare con noi. L’invito a partecipare alla cena di Nozze dell’Agnello è beatitudine che ci fa vedere e gustare, nel mistero, il dialogo teandrico del rapporto personale-comunitario con Dio.
È urgente, pertanto, recuperare la “nobile semplicità” della vera bellezza che è mezzo supremo per celebrare con serietà i divini Misteri. La “nobile semplicità” di cui parlava Paolo VI non è da confondere con la “vagans imbecillitas” di un mondo senza verità e privo di serietà cui appartengono i cultori della “spiritual fiction”. È vero che la bellezza non è tutto, ma occorre stare attenti a non cadere nel presupposto di carattere romantico che l’arte trova in se stessa la sua ragion d’essere e la propria giustificazione. Semplicità e bellezza, sintesi di perfezione, sono irradiazione di una raggiunta verità.
Diversamente da Platone, la santa Scrittura non bandisce l’arte dall’universo morale dell’uomo, tuttavia “sdivinizza” sia l’artista sia l’opera d’arte; inoltre, smaschera la tentazione di fare dell’opera d’arte un idolo senza speranza della Bellezza assoluta e come oblio dell’Eterno Infinito. Il bello non è un assoluto in sé, ma un itinerario verso l’Assoluto.
Il “munus musicae sacrae” di SC 112 serve per tenere lontano dall’equivocità il linguaggio musicale. Il “munus” difende la musica liturgica sia dall’arte “cainica”, che è offertorio dello scarto, del brutto e del consueto, sia di quell’arte “idolatrica” che cattura in sé l’attenzione dello sguardo in maniera intransitiva. Il “munus” esige un’arte “diaconica” che è servizio della bellezza come specchio che riverbera ed effrange la “sacramentalità” della liturgia. Nell’arte liturgica, la bellezza non canta se stessa quasi protagonista di un’auto-celebrazione compiacente e narcisistica; non è coreografica spettacolarità quasi vitello d’oro attorno al quale si danza, dimentichi di celebrare l’Agnello immolato e glorificato. La divina Liturgia è dialogo d’amore sponsale teantropico, è purissima forma d’amore tra ineffabilità divina ed effabilità umana.
Quanto più trascendente è la Rivelazione, tanto più esigente è il compito imposto alla virtù dell’arte musicale che diventa così rivelazione del contenuto più profondo della Parola all’interno dei santi Riti. Quanto più trascendente è la rivelazione interiore, di per sé ineffabile, tanto più esigente e, per così dire, tormentoso, è il compito imposto alla virtù dell’arte liturgica. Canto e musica diventano, così, epifania in bellezza del contenuto della Parola divina rivelata o del testo umano sostanziato di santa Scrittura.
Ai musicisti si richiede, pertanto, l’audacia di creare la bellezza di un canto che, alla nobile semplicità e praticabilità, unisca dignità d’arte e sensibilità di preghiera. Ai responsabili si richiede che eliminino dalle celebrazioni liturgiche pietismi superficiali, vacuità decadenti, anacronistici archeologismi o astrusi avanguardismi.
Oggi, purtroppo, nell’arte liturgico-musicale si avverte l’omologazione verso la non qualità, la volgare banalità o la caduta di stile. Canti e musiche sono resi sempre più “facili” per potersi adeguare all’imbecillitas humanae mentis ed essere così più commerciabili e vendibili. Canti e musiche rischiano di essere penalizzati e di muoversi in spettacolo per sopravvivere e mercificare il fenomeno. Se un individuo agisce male con l’intenzione di fare del bene trasgredisce la legge morale; così se un sedicente musicista scrive pessima musica con l’intenzione di creare musica accessibile e cantabile, rimane sempre un pessimo musicista.
La vera professionalità liturgico-musicale è fondamentale per essere capaci di cantare e far cantare il Mistero in nobile e semplice solennità. La celebrazione liturgica è tanto più semplice quanto più è nobile, tanto più è nobile quanto più è semplice. La semplicità è sintesi di perfezione. La nobiltà è illustre in chiarezza ed eccellente in qualità. La solennità s’impone per se stessa senza ricorrere a orpelli fastosi e ornamenti complementari.
Terminate le nozze, la rana non pretende la gratuità, ma chiede all’usignolo quanto deve per la sua prestazione artistica. L’usignolo risponde che non prende nulla poiché ha ricevuto il dono gratuitamente, ma è l’usignolo che decide la gratuità.
Nel linguaggio quotidiano ci sono parole molto semplici che hanno, però, un valore grandissimo, soprattutto quando sono pronunciate con convinzione, senza gentile fariseismo o pura formalità, perché sono parole che sgorgano dal cuore. Una di queste parole è saper dire “grazie”: espressione comunissima di chi riconosce un dono ricevuto e sa apprezzarlo. Questa parola breve, elegante e densa di significato, è capace di pronunciarla soltanto chi possiede quella spiccata sensibilità che non solo fa accogliere il dono ricevuto, ma, innanzitutto, sa vedere in quel dono la persona che lo offre e si comunica attraverso di esso.
Oggi, diseducati dalla società dell’”avere” e del “ricevere”, è difficile saper dire “grazie” o agire gratuitamente nella libertà di cuore. Si pretende, si esige, s’impone; talvolta si ferisce, si schernisce, addirittura si annulla come se tutto fosse dovuto, senza riconoscere e ricompensare né lavoro né meriti né sacrifici. La vera carità ci insegna che a ogni gesto di stima e di affetto devono sempre fare da contrappunto la riconoscenza e la gratitudine: gesti che, oltre che a onorare un profondo senso di giustizia, servono a edificare gli uni gli altri e a incoraggiare il lavoro e il dono sincero di sé, anche in situazioni complesse e faticose.