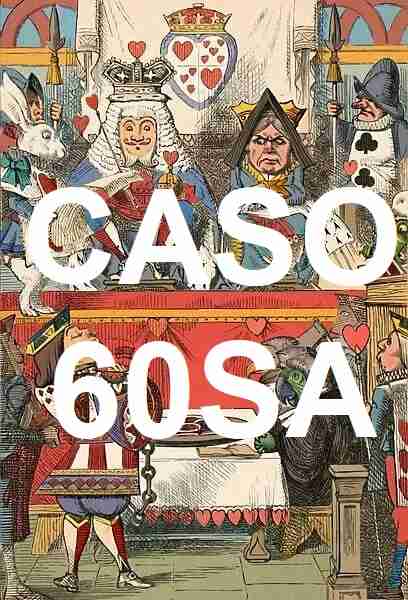Cosa cambia nei musei italiani

La nomina dei nuovi direttori dei 20 principali musei d’arte statali – tra i quali 7 non italiani – pubblicizzata in una conferenza stampa al Collegio romano il 16 settembre scorso e l’approvazione da parte del Governo di un D.L. in merito al restringimento del diritto di sciopero nei musei, monumenti e siti archeologici italiani (definito dai giornali “D.L. Colosseo”) sono i più recenti tasselli di un’azione tesa al cambiamento di musei e soprintendenze da parte del “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” Dario Franceschini.
Da più parti – con toni e prosopopea di saggia lungimiranza – si è sollevata l’obiezione e la giaculatoria che il bilancio del MIBACT è in picchiata da più di dieci anni, che il personale del ministero non viene reintegrato del turn-over, che gli organici di custodi e soprintendenze sono sottodimensionati, che i restauri sono pochi e insufficienti ecc. lasciando intendere che queste rilevazioni oggettive possano mettere in discussione la politica di Franceschini e addirittura invalidarla. D’altra parte, su tali questioni, si è replicato – con pari fondatezza e spirito di verità – che critici, intellettuali ecc. non hanno granché compreso in cosa debba consistere una “politica dei beni culturali” e quale possa essere oggi una azione in questo campo del Governo.
Coloro che governano il Paese – che non sono dei Premi Nobel e neppure degli eruditi e degli enciclopedisti – hanno l’obiettivo specifico di rispettare il bilancio dello stato, di ridurne il debito, di far fruttare le risorse pubbliche, di indirizzare secondo una prospettiva politicamente sensata l’attività dei pubblici dipendenti. Con una sola frase: i politici devono dare finalizzazione e ritmo all’apparato statale al cui vertice sono stati posti, tenendo conto di tutte le variabili oggi vigenti (interne e internazionali). Insomma, ed è una consapevolezza: sorta fin dagli albori del mondo moderno, tra il piano della cultura – o dell’arte, o semplicemente della sensibilità dell’intellettuale – e il piano dell’azione del cervello politico del Paese intercorre una necessaria asimmetria, per non dire una strutturale discordanza. E ciò non è un male: è piuttosto il modo di funzionare dei sistemi liberali e democratici. In essi non vi è uno stato ideologico e patriarcale che secerne “sapienza” e ostenta rispetto per le “tradizioni culturali”. Neppure vi sono intellettuali asserviti allo stato che fanno da obbediente cinghia di trasmissione di ciò che fanno i partiti in Parlamento. Nei Paesi liberali, alla politica spetta il monopolio sulla prassi e sull’amministrazione, agli intellettuali spetta quello teoria e sul giudizio, sulla vita civile e sulla militanza culturale. Insomma: ognuno deve fare il suo lavoro.
Ad esempio: i politici ritengono che l’introduzione delle tecnologie digitali in ogni comparto della Pubblica Amministrazione possa consentire allo Stato di risparmiare risorse e personale. Oppure, pensano che potenziando il ruolo dei dirigenti e dei managers le istituzioni pubbliche siano meglio in grado di cercare in autonomia nuove fonti di finanziamento per la propria attività. Gli intellettuali – da parte loro e se lo ritengono opportuno – possono intraprendere azioni libere ed autofinanziate per fare tutt’altro. Penso – ancora ad esempio – alle azioni di Alberto Asor Rosa per difendere il paesaggio lì dove vive o a quanto fanno organizzazioni autonome e filantropiche tipo FAI. Con lo stato vi può essere scambio dialettico e non semplicemente insubordinazione.
E i dipendenti pubblici? Possono consultare i sindacati e vedere se conviene loro di più aprire vertenze o piuttosto di lavorare alacremente lì dove è la loro sede di servizio. Tutto ciò nella consapevolezza che loro – sia detto rispettando ogni diritto del lavoro – sono pur sempre lo “strumento” dell’azione politica e di governo e non certo la finalità di essa.
Il cittadino preoccupato dell’andamento della cosa pubblica, sembra esprimere un apprezzamento per il fatto che – dopo 20 anni di azioni politiche inutili, guidate da interessi personali e da improvvisazioni ideologiche – ci sia finalmente in Italia un Governo che ha un programma politico e lo attua in modo incalzante e continuativo. In particolare, nel campo dei beni culturali e dei musei, dove pare cercare di intensificare la produttività del settore, per ottenere – senza aggravi per lo stato e senza incrementi clientelari di spesa – un potenziamento dei servizi e una finalizzazione delle risorse umane al raggiungimento di standards europei.
Tutto ciò richiede – da parte di chi al MIBACT o con il MIBACT ci lavora – una capacità di interpretare in modo creativo e innovativo le risoluzioni del Governo in merito a dirigenti, scioperi e tecnologie, intendendone davvero il senso e le finalità. In breve: più che sentirsi perseguitati, sentirsi artefici di un cambio di passo. Agli osservatori, ai critici e ai sapienti spetta, invece, di formulare il giudizio teorico sulla fase storica, di comparare fini e mezzi, di valutare le implicazioni del mutamento sociale e culturale che stiamo attraversando e – se a loro pare – di avviare, in prima persona, altri tipi di politiche.
Da ultimo ma non per ultimo, ai cittadini, ai turisti, agli appassionati di arte spetterebbe di valutare se il Ministro stia o no facendo del bene al Paese in questo campo, se stia migliorando la possibilità di fruire dei beni culturali da parte dei cittadini e dei turisti, insomma: se lo Stato stia restituendo in termini di godimento estetico e culturale i costi della conservazione e della valorizzazione dei beni artistici.
Nella foto: Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.