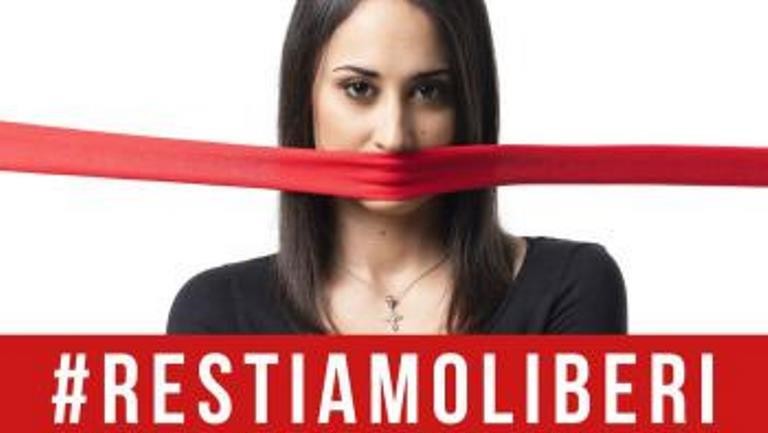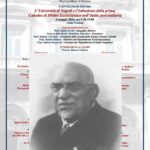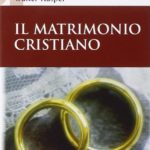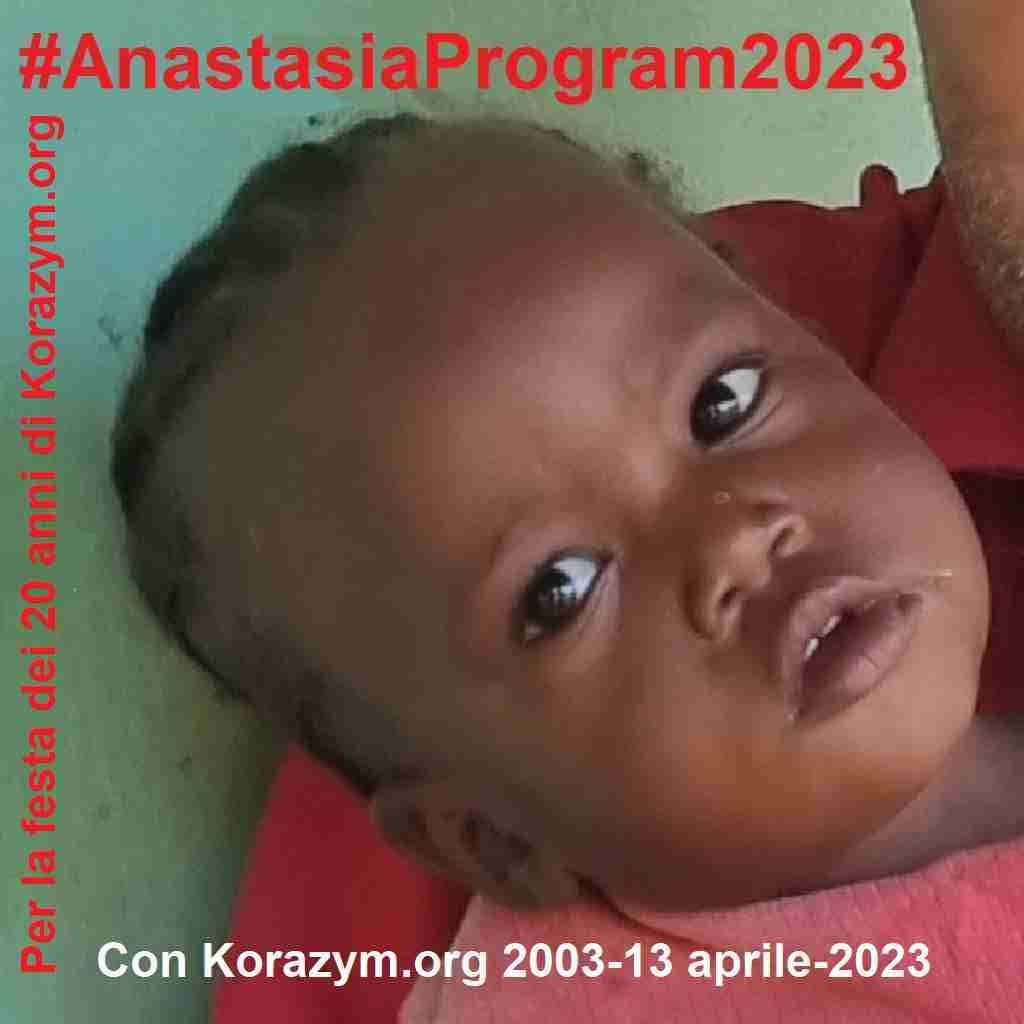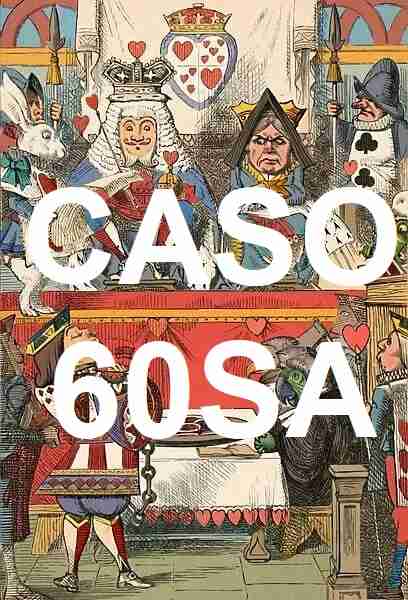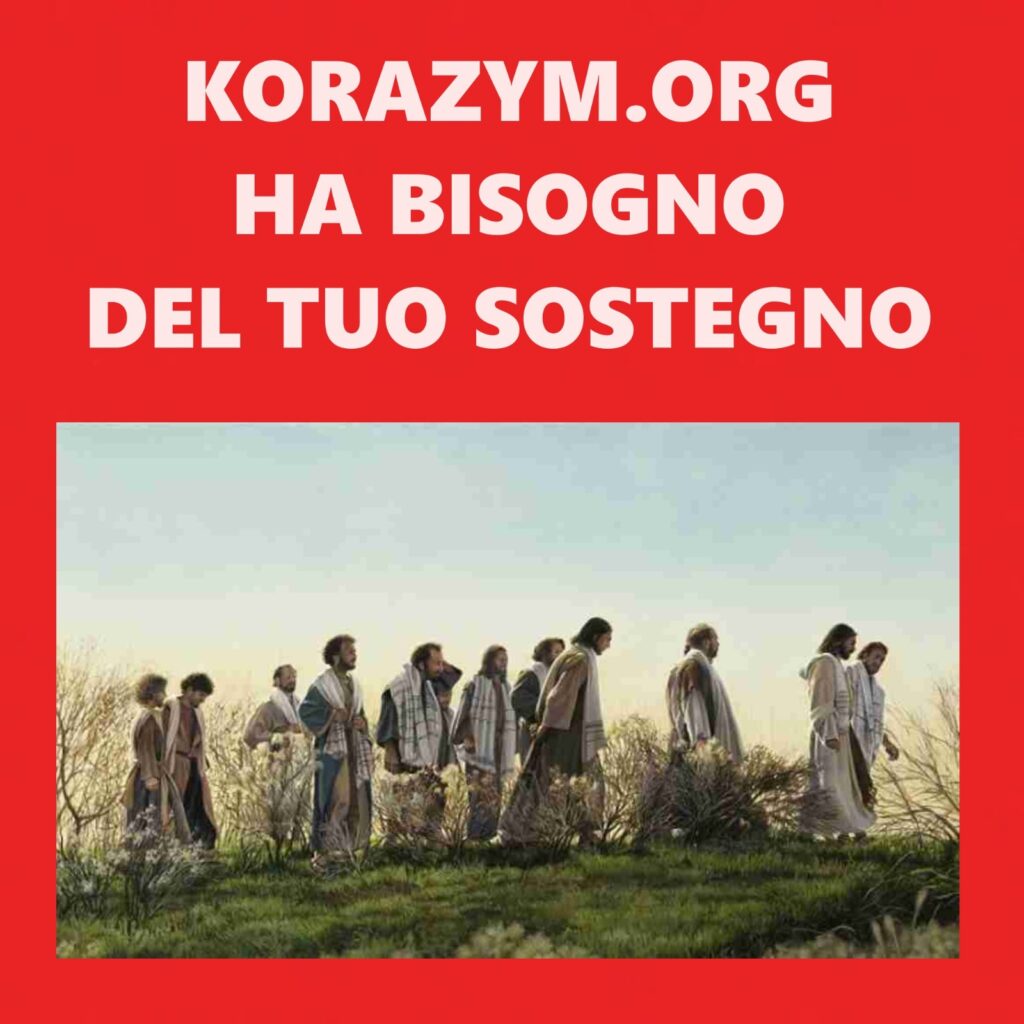Il tutto nel frammento

Forse ti starai chiedendo: ma c’è proprio necessità di un blog sulla teologia? A ben vedere diversi sono i blog sulla teologia e alcuni di questi sono anche molto validi. Persone competenti parlano e trattano di teologia. Tuttavia vorrei dare vita ad un’avventura un po’ diversa per tre motivi.
Primo: perché vorrei raccogliere materiale già pubblicato e offrirlo al pubblico. Quindi qui sarà possibile trovare qualcosa di me che si trova altrove; è una sorta di ‘raccoglitore’.
Secondo: perché il mio intento – spero di riuscirci – è quello di offrire qualcosa di inedito, cioè qualcosa che non si trova nelle riviste specializzate, nei blog più citati e chiacchierati. Io vorrei volare basso ed evitare, inoltre, sterili polemiche contro qualcuno o qualcosa.
Terzo: perché credo che si possa fare teologia anche in una forma inconsueta, in un blog appunto con piccoli frammenti che fanno immaginare il tutto, balenare un orizzonte più ampio. Non resta che dirti ancora una volta: benvenuto/a e buona lettura! Io, che scrivo, sono theologicalmind, cioè Fabio Cittadini.