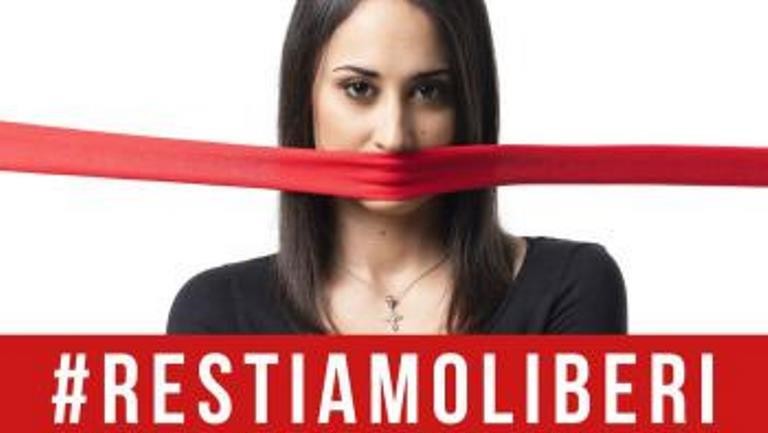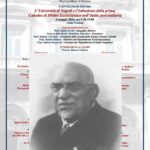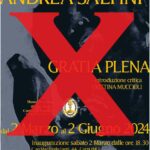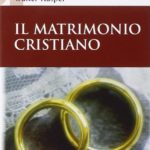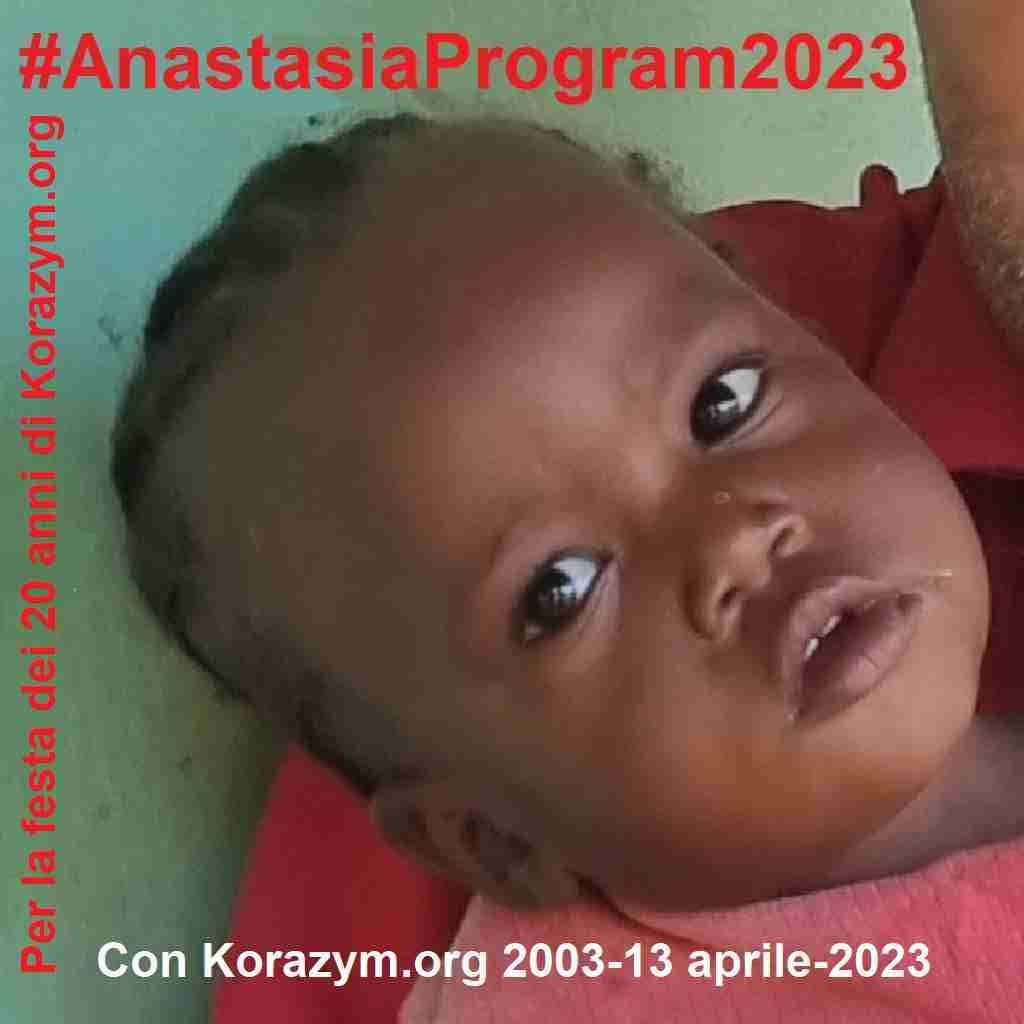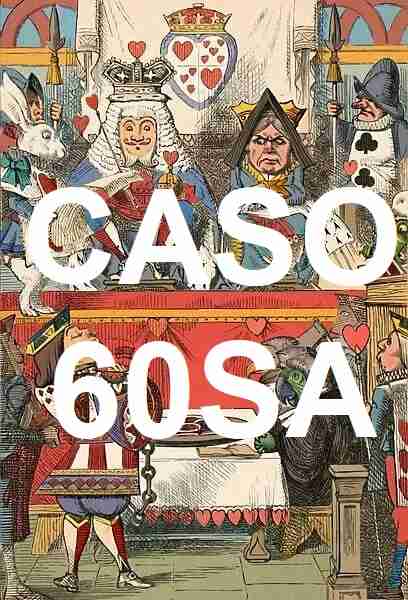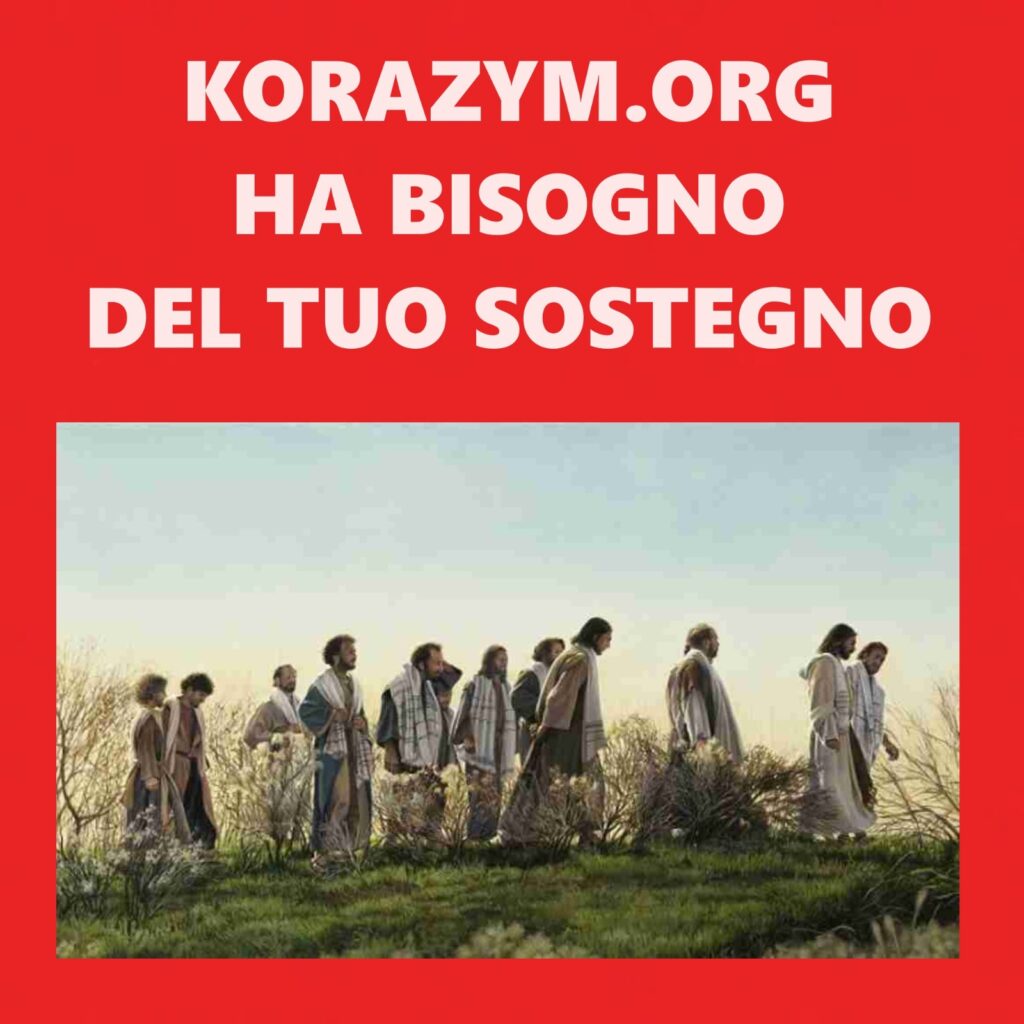Tag Archives: persona
Papa Francesco: trasmettere la storia è vita

“Sono lieto di potervi accogliere in questa ‘Città’ vaticana che, come quelle che rappresentate, conserva una ricca eredità di cui siamo custodi”: oggi papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri del gruppo ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, fondato in Spagna nel 1993 mettendo in rete le città dichiarate patrimonio mondiale dell’umanità, ed è riconosciuto anche a livello governativo.
Nell’incontro il papa ha sottolineato la responsabilità e la vocazione delle città culturali:”In questo senso penso che il nostro interesse per il patrimonio non possa rimanere nell’ambito artistico-culturale, ma debba avere una prospettiva più ampia, abbracciando l’integrità della persona che riceve questa eredità e delle persone che ce la hanno trasmessa. Le situazioni storiche (con le loro luci e ombre) ci parlano di uomini e donne veri, di sentimenti autentici, che dovrebbero essere per noi lezioni di vita, più che pezzi da museo”. S
Infatti le città sono state fondate per la trasmissione di cultura e di fede: “Sono le sofferenze e i desideri delle persone che hanno costruito le loro città nel corso del tempo, la mescolanza di culture e civiltà che si sono verificate in esse e, naturalmente, la loro fede in Dio, che fa battere i loro cuori con passione. Chiedo al Signore che, insieme alla bellezza delle loro città, conceda loro la grazia di trasmettere la fede, la speranza e la carità della loro gente”.
Tutto ciò permette di trasmettere la storia: “La contemplazione dei diversi monumenti permetta sia a chi li abita, sia a chi li visita, di riconsiderare la prudenza e la forza che ne hanno reso possibile la realizzazione. Si sentano interpellati dagli insegnamenti di giustizia e di temperanza che ogni situazione storica contiene. Parleremo così di città, di persone, di una storia non contemplata, ma realizzata, con un occhio al passato e un altro al futuro, per avere sempre le mani sul presente che ci interroga ogni giorno”.
Mentre ai membri del Consiglio Nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI), in occasione del 70^ anniversario dalla fondazione, il papa ha sottolineato il titolo dell’incontro, ‘Più vita alla vita’: “Lo avete voluto incarnare in alcuni progetti-simbolo da realizzare: donare una culla termica al Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Lampedusa; costruire una falegnameria nautica in Zambia; e piantare un bosco ad Argenta, in Romagna”.
E la vita è un valore fondamentale, offrendo una riflessione sulla natalità: “Primo: la culla, che ci ricorda l’amore per la vita che nasce. Viviamo in un tempo di drammatica denatalità. L’età media degli italiani è 46 anni, l’età media degli albanesi è 23: questo ci fa capire. Una drammatica denatalità in cui l’uomo sembra aver smarrito il gusto del generare e del prendersi cura dell’altro, e forse anche il gusto di vivere. Una culla simboleggia invece la gioia per un bimbo che viene alla luce, l’impegno perché possa crescere bene, l’attesa e la speranza per ciò che potrà diventare”.
La culla è attenzione per ogni vita: “La culla ci parla della famiglia, nido accogliente e sicuro per i piccoli, comunità fondata sulla gratuità dell’amore; ma anche, di riflesso, ci parla di attenzione per la vita in ogni sua fase, specialmente quando il passare degli anni o le asperità del cammino rendono la persona più vulnerabile e bisognosa. Ed è significativo, in questo senso, il fatto che il vostro dono sia destinato al Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Lampedusa: ciò sottolinea ulteriormente che l’amore per la vita è sempre aperto e universale, desideroso del bene di tutti, al di là della provenienza o di qualsiasi altra condizione”.
La seconda iniziativa messa in campo dal Masci è la falegnameria, che richiama la famiglia di Nazaret: “La falegnameria è un simbolo caro a noi cristiani, perché il Figlio di Dio l’ha scelta come luogo in cui prepararsi alla sua missione di salvezza nel suo villaggio, a Nazaret, lavorando umilmente ‘con mani d’uomo’. In un mondo in cui si parla tanto, forse troppo, di fabbricare armi per fare la guerra… essa ci rimanda alla vocazione fondamentale dell’uomo di trasformare i doni di Dio non in mezzi di morte, ma in strumenti di bene, nell’impegno comune di costruire una società giusta e pacifica, dove a tutti sia data la possibilità di una vita dignitosa. La dignità della vita: lavorare per la dignità della vita”.
Ed infine il bosco: “Esso ci ricorda la nostra responsabilità per la casa comune, che il Creatore ha affidato alle nostre mani. Il rispetto, l’amore e il contatto diretto con la natura sono caratteristiche peculiari dello scoutismo, fin dalle sue origini. E sono valori di cui abbiamo tanto bisogno oggi, mentre ci scopriamo sempre più impotenti di fronte alle conseguenze di uno sfruttamento irresponsabile e miope del pianeta, prigionieri di stili di vita e comportamenti tanto egoisticamente sordi ad ogni appello di buon senso, quanto tragicamente autodistruttivi; insensibili al grido di una terra ferita, come pure alla voce di tanti fratelli e sorelle ingiustamente emarginati ed esclusi da un’equa distribuzione dei beni”.
Tutto ciò è stato realizzato per ricordare don Giovanni Minzoni: “Egli è stato un parroco coraggioso che, in un contesto di violenta e prepotente ostilità, si è battuto, anche attraverso lo scoutismo, per formare i suoi giovani ‘a una solida vita cristiana e a un conseguente impegno per la trasformazione della società’. Anche questo è un richiamo importante a quell’ecologia integrale che, partendo dal farsi carico delle emergenze climatiche e ambientali, amplia la propria riflessione considerando, a monte, il ‘posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda’”.
‘Dignitas infinita’: il magistero della Chiesa per la tutela della dignità umana

“Nel Congresso del 15 marzo del 2019, l’allora Congregazione per la Dottrina della Fede decise di avviare ‘la redazione di un testo evidenziando l’imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all’interno dell’antropologia cristiana e illustrando la portata e le implicazioni benefiche a livello sociale, politico ed economico, tenendo conto degli ultimi sviluppi del tema nell’ambito accademico e delle sue ambivalenti comprensioni nel contesto odierno’.
Un primo progetto al riguardo, elaborato con l’aiuto di alcuni Esperti nel corso dell’anno 2019, venne ritenuto insoddisfacente da una Consulta ristretta della Congregazione, svoltasi l’8 ottobre dello stesso anno. Si procedette ad elaborare ex novo un’altra bozza del testo da parte dell’Ufficio Dottrinale, sulla base del contributo di diversi Esperti. La bozza venne presentata e discussa da una Consulta ristretta svoltasi il 4 ottobre del 2021. Nel gennaio 2022 la nuova bozza fu presentata nella Sessione Plenaria della Congregazione, durante la quale i Membri hanno provveduto ad abbreviare e semplificare il testo”.
Con queste parole introduttive il prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, card. Victor Manuel Fernandez, ha firmato la dichiarazione ‘Dignitas infinita’, che ricorda il 75^ anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, riaffermando ‘l’imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all’interno dell’antropologia cristiana’, dopo un lavoro durato cinque anni di lavoro con l’inclusione di alcuni temi portanti del recente magistero pontificio che affiancano quelli bioetici: violazioni della dignità umana, aborto, eutanasia, maternità surrogata, guerra, povertà, migranti, tratta delle persone, superando la dicotomia esistente tra chi guarda in modo esclusivo nella difesa della vita nascente o morente, e tra chi si concentra sulla difesa dei poveri e dei migranti.
Infatti nell’introduzione si richiama la definizione di persona: “Giova qui, infine, ricordare che la definizione classica della persona come ‘sostanza individuale di natura razionale’ esplicita il fondamento della sua dignità. Infatti, in quanto ‘sostanza individuale’, la persona gode della dignità ontologica (cioè a livello metafisico dell’essere stesso): essa è un soggetto che, ricevendo da Dio l’esistenza, ‘sussiste’, vale a dire esercita l’esistenza in modo autonomo. La parola ‘razionale’ comprende in realtà tutte le capacità di un essere umano: sia quella di conoscere e comprendere che quella di volere, amare, scegliere, desiderare”.
Ed il ‘razionale’ non costituisce un pericolo per la ‘natura’: “Il termine ‘razionale’ comprende poi anche tutte le capacità corporee intimamente collegate a quelle sopradette. L’espressione ‘natura’ indica le condizioni proprie dell’essere umano che rendono possibili le varie operazioni ed esperienze che lo caratterizzano: la natura è il ‘principio dell’agire’. L’essere umano non crea la sua natura; la possiede come un dono ricevuto e può coltivare, sviluppare e arricchire le proprie capacità. Nell’esercitare la propria libertà per coltivare le ricchezze della propria natura, la persona umana si costruisce nel tempo.
Anche se, a causa di vari limiti o condizioni, non è in grado di mettere in atto queste capacità, la persona sussiste sempre come ‘sostanza individuale’ con tutta la sua inalienabile dignità. Questo si verifica, per esempio, in un bambino non ancora nato, in una persona priva di sensi, in un anziano in agonia”.
Dopo un breve excursus nel tempo il documento ha evidenziato il concetto di dignità: “Per chiarire meglio il concetto di dignità, è importante segnalare che la dignità non viene concessa alla persona da altri esseri umani, a partire da determinate sue doti e qualità, in modo che potrebbe essere eventualmente ritirata.
Se la dignità fosse concessa alla persona da altri esseri umani, allora essa si darebbe in modo condizionato e alienabile, e lo stesso significato di dignità (per quanto meritevole di grande rispetto) rimarrebbe esposto al rischio di essere abolito. In realtà, la dignità è intrinseca alla persona, non conferita a posteriori, previa ad ogni riconoscimento e non può essere perduta. Di conseguenza, tutti gli esseri umani possiedono la medesima ed intrinseca dignità, indipendentemente dal fatto che siano in grado o meno di esprimerla adeguatamente”.
Anche il magistero della Chiesa ha apportato un contributo alla definizione di dignità: “Lo stesso magistero ecclesiale ha maturato con sempre maggior compiutezza il significato di tale dignità, unitamente alle esigenze ed alle implicazioni ad esso connesse, giungendo alla consapevolezza che la dignità di ogni essere umano è tale al di là di ogni circostanza…
Questo principio nuovo nella storia umana, per cui l’essere umano è tanto più ‘degno’ di rispetto e di amore quanto più è debole, misero e sofferente, fino a perdere la stessa ‘figura’ umana, ha cambiato il volto del mondo, dando vita a istituzioni che si prendono cura delle persone che si trovano in condizioni disagiate: i neonati abbandonati, gli orfani, gli anziani lasciati soli, i malati mentali, le persone affette da malattie incurabili o con gravi malformazioni, coloro che vivono per strada”.
Quindi il documento del dicastero invita a non abusare della parola ‘dignità umana’: “… il concetto di dignità umana, a volte, viene usato in modo abusivo anche per giustificare una moltiplicazione arbitraria di nuovi diritti, molti dei quali spesso in contrasto con quelli originalmente definiti e non di rado posti in contrasto con il diritto fondamentale della vita, come se si dovesse garantire la capacità di esprimere e di realizzare ogni preferenza individuale o desiderio soggettivo. La dignità s’identifica allora con una libertà isolata ed individualistica, che pretende di imporre come ‘diritti’, garantiti e finanziati dalla collettività, alcuni desideri e alcune propensioni che sono soggettivi”.
La dignità umana si fonda su diritti e doveri: “Ma la dignità umana non può essere basata su standard meramente individuali né identificata con il solo benessere psicofisico dell’individuo. La difesa della dignità dell’essere umano è fondata, invece, su esigenze costitutive della natura umana, che non dipendono né dall’arbitrio individuale né dal riconoscimento sociale.
I doveri che scaturiscono dal riconoscimento della dignità dell’altro e i corrispondenti diritti che ne derivano hanno dunque un contenuto concreto ed oggettivo, fondato sulla comune natura umana. Senza un tale riferimento oggettivo, il concetto di dignità viene di fatto assoggettato ai più diversi arbitrii, nonché agli interessi di potere”.
Quindi è ripresa la concezione di dignità umana, che si fonda sulla libertà, come ha enucleato san Giovanni Paolo II: “La dignità umana, alla luce del carattere relazionale della persona, aiuta a superare la prospettiva riduttiva di una libertà autoreferenziale e individualistica, che pretende di creare i propri valori a prescindere dalle norme obiettive del bene e dal rapporto con gli altri esseri viventi.
Sempre più spesso, infatti, vi è il rischio di limitare la dignità umana alla capacità di decidere discrezionalmente di sé e del proprio destino, indipendentemente da quello degli altri, senza tener presente l’appartenenza alla comunità umana. In tale comprensione errata della libertà, i doveri e i diritti non possono essere mutuamente riconosciuti di modo che ci si prenda cura gli uni degli altri”.
Quindi la libertà è indispensabile: “Si tratta di una liberazione che dal cuore delle singole persone è chiamata a diffondersi e a manifestare la sua forza umanizzante in tutte le relazioni. La libertà è un dono meraviglioso di Dio. Anche quando ci attira con la sua grazia, Dio lo fa in modo tale che mai la nostra libertà sia violata.
Sarebbe pertanto un grave errore pensare che, lontani da Dio e dal suo aiuto, possiamo essere più liberi e di conseguenza sentirci più degni. Sganciata dal suo Creatore, la nostra libertà non potrà che indebolirsi e oscurarsi. Lo stesso succede se la libertà si immagina come indipendente da ogni riferimento che non sia se stessa e avverte ogni rapporto con una verità precedente come una minaccia. Di conseguenza, anche il rispetto della libertà e della dignità degli altri verrà meno”.
Il documento si conclude con un ‘forte’ richiamo al rispetto della dignità umana, condannando tutte le violenze contro di essa con un invito agli Stati di difenderla e tutelarla: “E’ in questo spirito che, con la presente Dichiarazione, la Chiesa ardentemente esorta a porre il rispetto della dignità della persona umana al di là di ogni circostanza al centro dell’impegno per il bene comune e di ogni ordinamento giuridico.
Il rispetto della dignità di ciascuno e di tutti è, infatti, la base imprescindibile per l’esistenza stessa di ogni società che si pretende fondata sul giusto diritto e non sulla forza del potere. Sulla base del riconoscimento della dignità umana si sostengono i diritti umani fondamentali, che precedono e fondano ogni civile convivenza…
Anche oggi, davanti a tante violazioni della dignità umana che minacciano seriamente il futuro dell’umanità, la Chiesa incoraggia la promozione della dignità di ogni persona umana quali che siano le sue qualità fisiche, psichiche, culturali, sociali e religiose. Lo fa con speranza, certa della forza che scaturisce dal Cristo risorto, il quale ha rivelato in pienezza la dignità integrale di ogni uomo e di ogni donna”.
(Foto: Vatican News)
Anche in Emilia-Romagna braccio di ferro sul suicidio medicalmente assistito

“Nascere, vivere, morire: tre verbi che disegnano la traiettoria dell’esistenza. La persona li attraversa, forte della sua dignità che l’accompagna per tutta la vita: quando nasce, cresce, come quando invecchia e si ammala. Sperimenta forza e vulnerabilità, intimità e vita sociale, libertà e condizionamenti. Gli sviluppi della medicina e del benessere consentono oggi cure nuove e un significativo prolungamento dell’esistenza. Si profila così la necessità di modalità di accompagnamento e di assistenza permanente verso le persone anziane e ammalate, anche quando non c’è più la possibilità di guarigione, continuando e incrementando l’ampio orizzonte delle “cure”, cioè di forme di prossimità relazionale e mediche”.
Così inizia il giudizio della Conferenza episcopale dell’Emilia- Romagna sulle ‘Istruzioni tecnico-operative’ con le quali la giunta regionale aveva tracciato lo scorso 9 febbraio il percorso per ottenere il suicidio medicalmente assistito. Nella nota i vescovi hanno sottolineato che procurare la morte contrasta con il valore della vita:
“Alla base di questa esigenza ci sono il valore della vita umana, condizione per usufruire di ogni altro valore, che costruisce la storia e si apre al mistero che la abita, e la dignità della persona, in intrinseca relazione con gli altri e con il mondo che la circonda”.
Per questo il valore della vita impone la difesa delle persone fragili: “Il valore della vita umana si impone da sé in ogni sua fase, specialmente nella fragilità della vecchiaia e della malattia. Proprio lì la società è chiamata ad esprimersi al meglio, nel curare, nel sostenere le famiglie e chi è prossimo ai malati, nell’operare scelte di politiche sanitarie che salvaguardino le persone fragili e indifese, e attuando quanto già è normato circa le cure palliative. Impegno, questo, che qualifica come giusta e democratica la società. Procurare la morte, in forma diretta o tramite il suicidio medicalmente assistito, contrasta radicalmente con il valore della persona, con le finalità dello Stato e con la stessa professione medica”,
Per i vescovi dell’Emilia-Romagna la proposta del ‘suicidio medicalmente assistito’ è sconcertante, proponendo un loro contributo: “Esprimiamo con chiarezza la nostra preoccupazione e il nostro netto rifiuto verso questa scelta di eutanasia, ben consapevoli delle dolorose condizioni delle persone ammalate e sofferenti e di quanti sono loro legati da sincero affetto.
Ma la soluzione non è l’eutanasia, quanto la premurosa vicinanza, la continuazione delle cure ordinarie e proporzionate, la palliazione, e ogni altra cosa che non procuri abbandono, senso di inutilità o di peso a quanti soffrono”.
Tali ragioni possono trovarsi nell’umanità del cristianesimo, che si fonda sulla vita: “Tale prossimità e le ragioni che la generano hanno radici nell’umanità condivisa, nel valore unico della vita, nella dignità della persona, e trovano sorgente, luce e forza ulteriore in Gesù di Nazareth che, proprio sulla Croce, nella fase terminale della esistenza, ci ha redenti e ci ha donato sua madre, scambiando con Lei, con il discepolo amato e con chi condivideva la pena, parole e un testamento di vita unico, irrinunciabile, non dissimili a quelle confidenze che tanti cari ci hanno lasciato sul letto di morte”.
A tale giudizio il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è disponibile ad ogni approfondimento, affermando che “le sentenze della Corte Costituzionale si applicano, come prescrive la Costituzione italiana. Possono certamente essere discusse e non condivise, ma non disattese, in ossequio al principio di legalità.
Come noto, la Corte Costituzionale si è pronunciata per colmare un vuoto sulla materia prodotto dall’inerzia prolungata del Parlamento. E lo ha fatto, ancora una volta, chiedendo alle Camere di legiferare, di discutere e approvare una legge nazionale. E questo è anche il mio auspicio”.
Nel frattempo la regione ha disposto le modalità di accesso all’istituto del suicidio medicalmente assistito: “E lo ha fatto perché ciò è dovuto in uno Stato di diritto, scongiurando viceversa quanto altrove già accaduto e ancora rischia di accadere: che un paziente, peraltro in condizioni drammatiche, debba ricorrere al giudice ordinario per vedersi riconosciuto quello che, va ribadito, è un diritto ora sancito dalla Corte costituzionale. Sono certo che sul principio di legalità anche la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna non possa che convenire”.
Papa Francesco ai dipendenti dell’ospedale ‘Miulli’: al centro la cura della persona
Papa Francesco: attenzione e professionalità ai bisogni delle persone

La settimana di papa Francesco è iniziata con due incontri ai dipendenti di due strutture importanti per la macchina burocratica degli Stati: il revisore generale e la prefettura. Quindi, ricevendo il personale dell’ufficio generale dello stato vaticano, riformato a seguito del motu proprio ‘Fidelis dispensator et prudens’, papa Francesco ha sottolineato tre caratteristiche, di cui la prima è l’indipendenza:
Festa della Repubblica: il presidente Mattarella ricorda il valore della democrazia
Accademia per la Vita: la teconologia non può superare il limite umano

Mercoledì 22 febbraio si è conclusa la XXVIII Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita sul tema ‘Converging on the person. Emerging Technologies for the Common Good’, i cui risultati sono stati presentati da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato il valore dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla vita:
Giornata della Vita: la cultura della morte non è la soluzione

E’ incentrato sulla diffusione di una cultura della morte il messaggio dei vescovi italiani per la 45^ Giornata della Vita, che si celebra oggi nelle diocesi, affrontando il tema ‘La morte non è mai una soluzione. Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte’, tratto da un passo del libro della Sapienza.
Papa Francesco indica alle confraternite ed ai medici la cura della persona

Mancano pochi anni al prossimo giubileo dell’Anno Santo ed ieri papa Francesco ha incontrato i membri del Consiglio Direttivo della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, fondata durante il giubileo del 2000 per coordinare le attività delle Confraternite locali: “Ora vi accingete a celebrare, fra due anni, il vostro 25° anniversario nel contesto di un altro Giubileo, quello del 2025, che ha come motto ‘Pellegrini di speranza’. Ci stiamo preparando a questo momento forte della vita della Chiesa, e voi siete una realtà molto significativa per questa preparazione e poi per la celebrazione”.