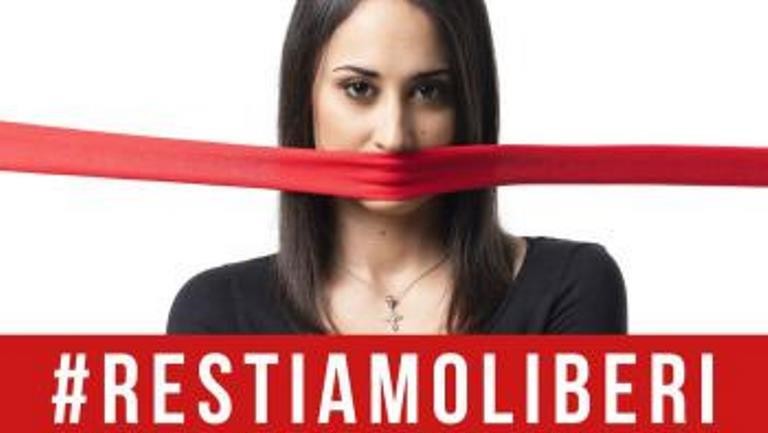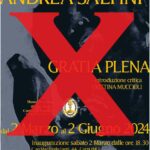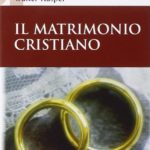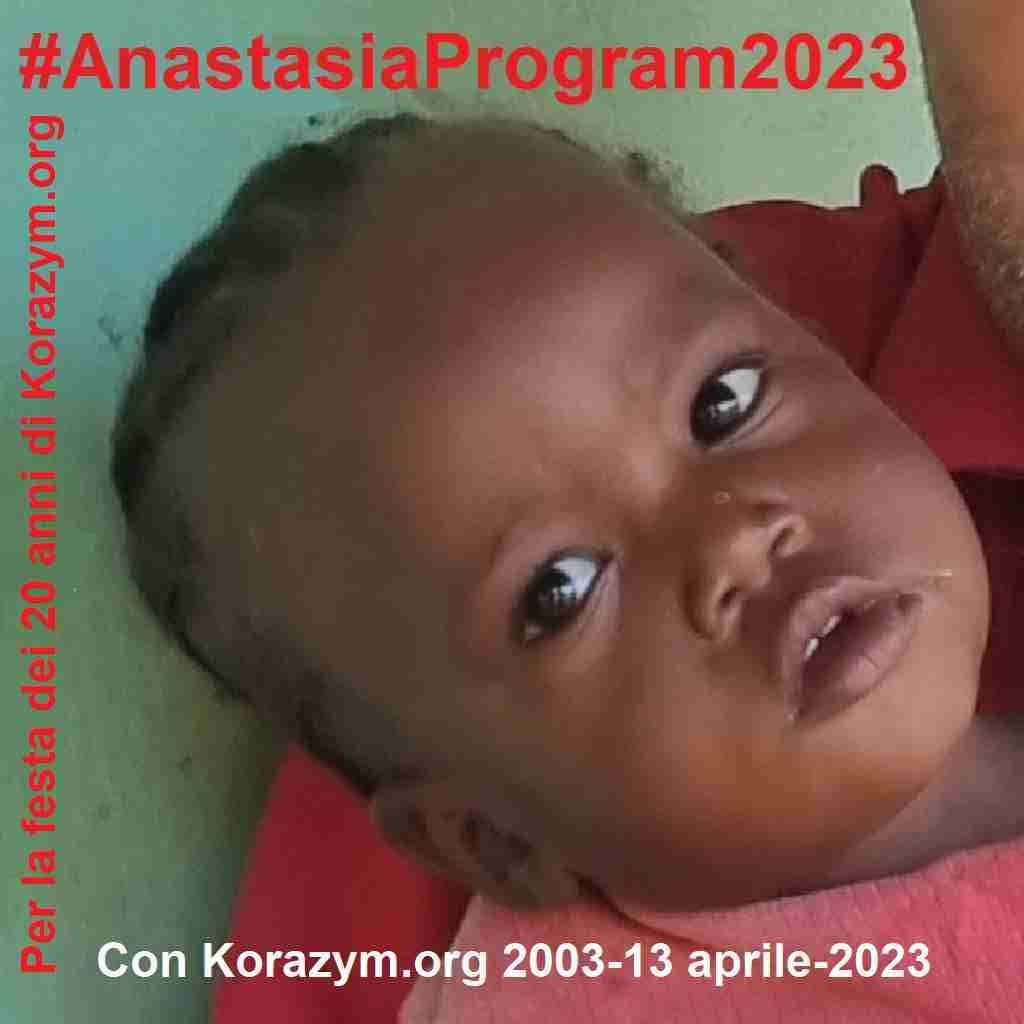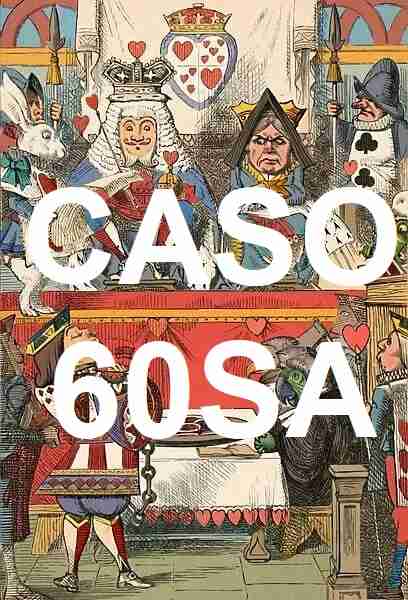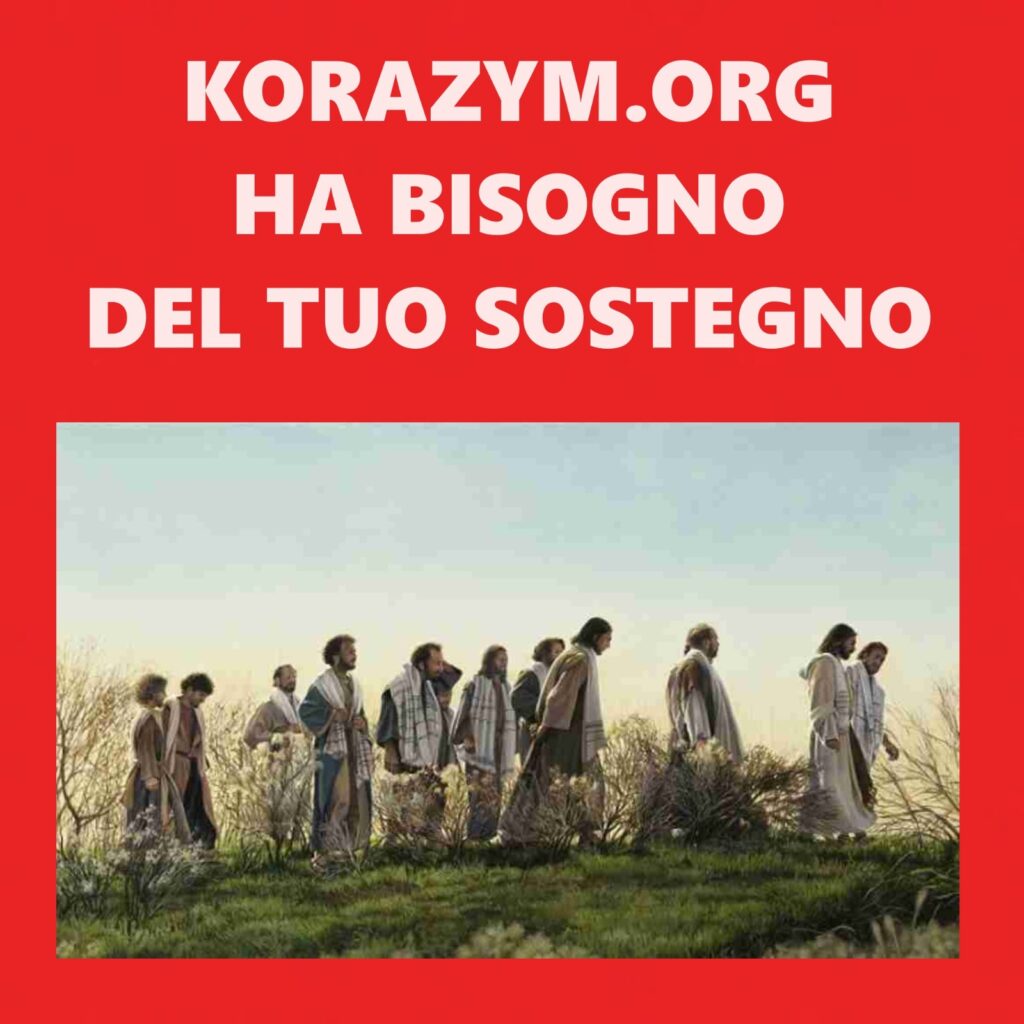Dal dialogo ebraico cristiano un invito a consolare il popolo
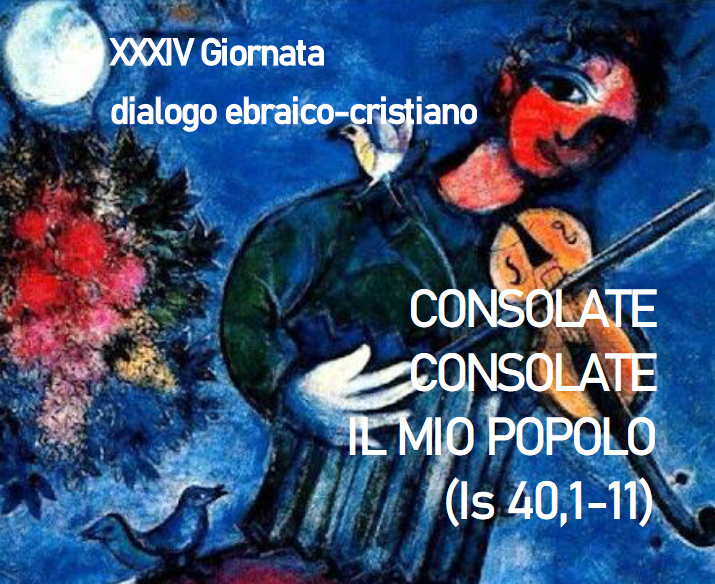
Oggi, 17 gennaio, si svolge la XXXIV Giornata del dialogo ebraico cristiano sul tema tratto dal brano del profeta Isaia sulla consolazione, ‘Consolate, consolate il Mio popolo’. Tale Giornata si colloca proprio alla vigilia della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (SPUC), che rappresenta un importante momento ecumenico e interconfessionale.
La prima associazione di dialogo ebraico-cristiano nacque a Londra nel 1927, ‘London Society of Christians and Jews’, con la scopo ‘di incrementare la comprensione religiosa e promuovere atteggiamenti di buona volontà e cooperazione tra ebrei e cristiani nel rispetto reciproco delle proprie differenze di fede e di pratica religiosa, e di combattere l’intolleranza religiosa’. National Councils of Christians and Jews (NCCJ) si formarono negli anni seguenti nei paesi anglosassoni: in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ed in Sud Africa.
Ne facevano parte rabbini, pastori protestanti, laici, teologi e studiosi, coinvolgendo per la prima anche esponenti della Chiesa cattolica, sia pure in modo non ufficiale. Per iniziativa dei presidenti del NCCJ americano, il pastore presbiteriano Everett R. Clinchy e il rabbino Morris S. Lazaron, ‘Tolerance Trios’ di ministri ebrei, cattolici e protestanti offrirono conferenze negli anni ‘30 negli Stati Uniti, Canada, Irlanda e Gran Bretagna, per servire poi durante la seconda guerra mondiale come cappellani militari nelle forze alleate in Europa.
Questa esperienza lasciò un’impressione profonda in quanto veniva a modificare schemi secolari di rapporto tra le tre confessioni, e sarà ricordata anche in un episodio del film ‘Paisà’ di Roberto Rossellini (1946).
Per tale Giornata la presidenza dei vescovi italiani invitano alla riflessione sviluppando il tema di ‘uno sguardo nuovo’: “La stagione che stiamo vivendo, segnata dall’auspicata uscita dalla pandemia che per lungo tempo ha fiaccato la vita del Paese, comprese le comunità di fede, ci spinge a interrogarci a fondo sulla nostra presenza nella società come uomini e donne credenti nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
Il passo del profeta Isaia, scelto quest’anno come nucleo ispiratore per la Giornata del 17 gennaio (Is 40,1-11), è un annuncio di consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che il suo Signore non lo abbandonerà: ‘Nahamù nahamù ‘ammì’, ‘Consolate, consolate il mio popolo’. Possiamo avere fiducia nel futuro perché la Parola di Dio ci garantisce che egli è fedele. Fondati in lui, troviamo la forza per dar credito alla vita ed essere fiduciosi, perché ci sentiamo preceduti e ‘superati’ dalla sua azione. Dio, infatti, opera oltre le nostre stesse attese”.
Il testo del profeta di Isaia è un invito a non ‘rassegnarsi’: “Di fronte all’annuncio dell’iniziativa inattesa di Dio e all’invito a gridare, risuona l’interrogativo: ‘Che cosa dovrò gridare?’. La domanda nasce dalla constatazione delle nostre fragilità, oltre che del nostro peccato: ‘Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo’. Certo, se guardiamo alle nostre forze, ‘veramente il popolo è come l’erba’!
Questi anni di pandemia, il dramma della guerra, la crisi energetica ecologica ed economica, hanno messo a nudo le crepe delle organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, aprendo a potenziali inquietanti scenari di complessa interpretazione. Ci hanno fatto toccare con mano la nostra debolezza e ci hanno messo di fronte all’incostanza nel rispondere alla Parola di speranza che Dio rivolge alla vita”.
L’invito di Dio è quello ad aprire gli occhi: “Dio agisce oltre noi, oltre le nostre comunità. Come operò nel sovrano pagano Ciro , che divenne strumento di liberazione nelle mani del Signore. Dio è all’opera nell’estraneo e nello straniero.
Dobbiamo quindi impegnarci insieme in un lavoro di ascolto e di discernimento per trovare il Signore là dove sta operando, al di là delle nostre attese e dei nostri progetti. Usciamo per incontrare il Signore, che si muove oltre i nostri ristretti confini!”
Quello dei vescovi è un invito a cambiare lo sguardo: “Fondati sull’amore incrollabile dell’Eterno, siamo in grado di guardare con fiducia al tempo che ci sta davanti, indagando nuovi percorsi, creando sentieri per costruire insieme un futuro di speranza, portando il nostro servizio nella società e nelle città”.
Anche il Consiglio dell’Assemblea Rabbinica Italiana legge il brano attraverso la specificità ebraica: “E’ innanzitutto la sua speciale collocazione liturgica, che a sua volta è espressione di un pensiero importante. Nel calendario ebraico, si celebra d’estate un periodo speciale, particolarmente austero, di tre settimane, che inizia con un digiuno (il 17 di Tamuz) e finisce con un altro digiuno, ancora più rigoroso, quello del nove di Av. In questo giorno si ricordano le distruzioni del primo e del secondo Santuario di Gerusalemme e molte altri eventi luttuosi che hanno funestato la storia ebraica.
Nel sabato che precede il 9 di Av si legge, con melodia struggente, il capitolo 1 di Isaia, quello della ‘Visione’, severa e minacciosa. Nel sabato successivo l’atmosfera cambia, è il momento della ripresa, della consolazione, il brano scelto per segnalarlo è proprio Isaia 40, che inizia con le parole Nachamù nachamù ‘amì, ‘Consolate, consolate il Mio popolo’. Questa volta la melodia è solenne e festiva”.
Tale melodia festiva è data da una precisa situazione: “Tutto questo per dire che c’è una precisa interpretazione storica nell’uso di quel brano. Il popolo di Israele, pur colpito da sciagure, sa che dopo il lutto viene la consolazione, la vita riprende, il legame con il Signore torna ad esprimersi su toni più sereni, nell’attesa fiduciosa della completa redenzione, su questo percorso il messaggio è sempre valido. Tanto radicata è la consuetudine di quel brano, che si presta pure, nel linguaggio dialettale degli ebrei italiani, a un proverbio meteorologico: Nachamù, nachamù e l’estate non c’è più”.
Il messaggio del profeta Isaia è profetico: “Il brano di Isaia inizia con il messaggio consolatorio, ma propone altre riflessioni importanti. C’è l’invito a costruire nel deserto una strada per il Signore. Il testo ebraico dice: Qol qorè: bamidbàr panù derekh Hashèm ‘una voce che chiama: nel deserto sgombrate la strada del Signore’.
Togliendo i due punti è diventato Vox clamantis in deserto, espressione proverbiale, che però sovverte il senso originale. Anche qui l’esegesi ebraica inserisce una chiave interpretativa storica: la strada serve perché gli esuli ritornino nella loro terra;
il riferimento al deserto rinnova il ricordo del percorso di liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto, come allora il Signore guidò il suo popolo, proteggendolo dai nemici e facendogli superare le insidie del deserto, così al tempo della redenzione curerà il ritorno verso la terra promessa e nuovamente coll’aiuto dell’Eterno tutti gli ostacoli potranno essere superati ‘ogni valle si innalzerà, ogni monte e ogni altura si abbasseranno, quello che era ondulato diverrà piano’”.
E’ un messaggio che sollecita l’iniziativa dell’uomo, invitandolo a rimuovere gli ostacoli: “Questa sollecitazione all’iniziativa dell’uomo, in termini di elevazione morale e purificazione spirituale, un’azione dell’uomo necessaria per dar modo alla provvidenza divina di manifestarsi pienamente, si coniuga con l’altra grande idea di questo brano, quella della fragilità, della caducità, dell’inconsistenza della natura umana in contrapposizione allo spirito divino”.
Tale brano è molto incisivo per il tempo presente: “Sono messaggi che ci parlano intensamente anche nel tempo presente. In questi ultimi anni sono successe tante cose negative e non ne siamo ancora venuti fuori. Il passo profetico indica una strada, una direzione, una consolazione, purché l’essere umano sappia mettersi in ascolto della voce del Signore e con tale guida comprenda quale è il suo ruolo e il suo compito”.