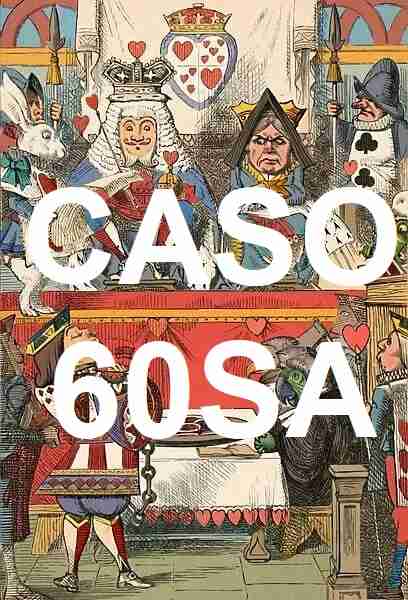Raccontare la vita con la fotografia: a colloquio con Marco Gualazzini, vincitore del World Press Photo

Il fotografo parmense Marco Gualazzini ha vinto, ad inizio anno, la categoria ‘Ambiente’ del ‘World Press Photo’, prestigioso premio fotografico, per il suo reportage sulla crisi del lago Ciad (qui la fotografia vincitrice); il vincitore della foto dell’anno è stato John Moore, corrispondente di Getty Images, con un’immagine scattata in Texas ai confini con il Messico.
Nato a Parma nel 1976, Marco Gualazzini ha iniziato la sua carriera come fotografo nel 2004, con il quotidiano locale della sua città, la Gazzetta di Parma. I suoi lavori più recenti includono la fotografia di reportage sulla microfinanza in India, sui media in Laos, nonché sulla discriminazione dei cristiani in Pakistan.
I suoi reportage sono stati pubblicati in pubblicazioni nazionali e internazionali, tra cui Internazionale, Io Donna, L’Espresso, M (Le Monde), Newsweek Giappone, Sette (Corriere della Sera), The New York Times e Vanity Fair. Ha ideato e realizzato il documentario per la RAI sul sistema delle caste in India, selezionato all’IDFA – The International Documentary Film Festival di Amsterdam.
Ed a Parma, dopo Roma e Milano, fino al 27 ottobre sarà ospitata la sua mostra ‘Resilient’, che è un suo libro da cui sono tratte le fotografie che raccontano i reportage realizzati in Africa dal 2009 al 2018: “La mostra è una conseguenza del libro ‘Resilient’, edito da Contrasto, grazie ad un collezionista d’arte, Giampaolo Cagnin, che mi ha spinto a tirare le somme dopo 10 anni di lavoro in Africa su crisi e conflitti umanitari nel 2009 e nel 2018 ho fatto un reportage sul conflitto umanitario in Ciad.
Dopo il libro Roberto Cochi ed Alessandra Mauro mi hanno offerto di fare una mostra a Milano. Però dal libro sono state estrapolate circa 40 immagini per la mostra. Adesso portiamo la mostra a Parma fino a fine ottobre, in previsione di ‘Parma 2020’, in quanto il prossimo anno è designata come ‘capitale della cultura italiana’. Questa mostra sarà il prologo degli eventi che saranno fatti il prossimo anno”.
Cosa significa vincere un premio come il ‘World Press Photo’ e cosa comporta per la professione e per il progetto?
“Penso che il ‘il World Press Photo’ sia il riconoscimento più prestigioso, e al tempo stesso, più utile per chi fa il mio mestiere. Perché non è solo un premio, ma è anche un supporto concreto all’attività di reportage. Faccio tutt’ora fatica a realizzare che io, Mr. nessuno, lo abbia vinto.
Poi però, se faccio un passo indietro, mi rendo conto che il premio non è per alimentare il mio ego di fotografo, ma mi è concesso perché io possa essere un ponte tra voi e quello che mostro. In questo paradigma io sono un semplice nunzio. L’importante è la testimonianza, la storia, il messaggio. I soldi mi aiuteranno a ritornare in Africa a cuor un più leggero, e a portare avanti il mio progetto.
Ma l’Africa che vive in queste condizioni, per chi vuole fare il mio mestiere, è estremamente cara. Adesso so solo che alla mie spalle adesso ho uno dei migliori partner che un fotografo potrebbe desiderare, e questo mi permetterà di concentrarmi maggiormente sulle fotografie sul campo, piuttosto che la distribuzione o la presentazione di queste”.
Come si è avvicinato al fotogiornalismo?
“Ho iniziato a seguire la cronaca per la Gazzetta di Parma. Questa collaborazione è durata sette anni durante i quali ho messo in pratica tutta la teoria che con il tempo avevo acquisito. E’ stata un’esperienza fondamentale perché mi ha consentito di conoscere da vicino le dinamiche di una notizia che, seppur piccola come per esempio può essere un’incidente di provincia o una rapina, va raccontata secondo regole generali che valgono anche per avvenimenti di più ampio respiro.
Poi mi sono avvicinato alla fotografia come passione negli anni ‘90, in un periodo in cui c’erano grandi crisi umanitarie in corso. Sono stati diversi fotografi che ammiro e che stavano coprendo con i loro servizi quelle crisi umanitarie a farmi avvicinare alla fotografia. Fotografare è stata la mia maniera per portare avanti una testimonianza, andare lì e scattare è stata una necessità che è poi diventata una questione personale indipendentemente dai media e il tornarci più volte lo considero una forma di rispetto nei confronti di chi ho incontrato”.
Perché ha scelto di raccontare l’Africa?
“Mi sono avvicinato alla fotografia negli anni ’90 grazie ad un professore di università, Gianluigi Colin, art director del Corriere della Sera, ci introdusse nel mondo del fotogiornalismo impegnato nelle crisi umanitarie ad iniziare dal genocidio del Rwanda e la guerra in Somalia. Quando ho iniziato a fotografare mi è sembrato di raccogliere quel testimone”.
Come mai la scelta di raccontare la Repubblica Democratica del Congo, da cui è appena rientrato?
“Su di me il Congo ha sempre esercitato un grande ‘fascino’. Ho deciso di tornarci dopo una prima esperienza perché ho là dei legami affettivi. Missionari ai quali sono profondamente legato. Una terra sconfinata, con una storia estremamente tragica, di conflitti irrisolti, che si ripropongono in un qualche modo a cadenze quasi regolari da mezzo secolo, dai primi massacri tra Hutu e Tutsi degli anni ‘60 in Rwanda.
Oltretutto quando mi avvicinai al fotogiornalismo, erano gli anni del genocidio, e i fotografi che più mi hanno ispirato, come Nachtwey o Gilles Peress, stavano lavorando proprio a Goma. Nachtwey dice in un’intervista, che dopo aver documentato il genocidio, si spostarono a Goma perché era appena scoppiata un’epidemia di colera.
Vittime e carnefici, erano mischiati tra loro, agonizzanti e morenti. Per lui fu come prendere un ascensore per l’inferno. Le foto di quel periodo sono scioccanti, e visto che furono proprio quelle le foto che mi fecero avvicinare a questo mestiere, sento di avere un obbligo morale nei confronti del Congo. Di base dal 2009 ad oggi non è cambiato praticamente nulla”.
E perché il Ciad?
“Quando ho iniziato a lavorare in Somalia negli anni ‘90, il problema era il movimento ‘Al Shabaab’, cioè l’integralismo islamico. Quindi abbiamo iniziato a raccontare l’integralismo islamico in Africa. Raccontando il fenomeno di Boko Haram in Nigeria, sono finito in Ciad, perché la crisi umanitaria in corso è legata al cambiamento climatico, che ha causato quasi 2.000.000 di profughi, che diventano facili prede per l’estremismo islamico che li arruola o li uccide. Quindi nel raccontare ho voluto raccogliere il testimone dei grandi fotoreporter”.
Vale la pena raccontare le storie che incontriamo?
“Raccontare il dramma fine a sé stesso nel momento in cui non hai nessuna forma di speranza, non ha senso, perde qualunque valore. Se tutto è perduto, non vale la pena allora raccontarlo. Se ci sono missionari o gente del luogo che hanno sacrificato la propria vita e chi la mette in discussione, io mi fido di loro e credo che ci sia una speranza ad andare oltre.
Quindi non credo ci sia motivo per non raccontare una storia che ci affascina o nella quale crediamo. L’unico ostacolo potrebbe essere un discorso etico d’approccio. A mio parere l’approccio etico ad una storia è l’unica cosa che ci legittima o meno a fotografarla. Poi però ognuno, dal fotografo al photoeditor, al lettore, ha la propria coscienza”.
Nell’epoca dei social network quale importanza riveste la fotografia?
“Nel 2015 Instagram ha festeggiato 5.000.000.000 fotografie condivise sul social; recentemente ho letto un libro sulla fotografia nel Novecento, ’Lo specchio dell’anima’, in cui in un momento storico legato alle avanguardie artistiche ed alla rivoluzione industriale in Italia, i fotografi rispetto all’arte giocano ‘in difesa’: fotografano i paesaggi e si inventano lo stile delle città d’arte.
Invece di raccontare l’Italia di quegli anni preferiscono fotografare i borghi ed i reperti archeologici. E Lucas fa questa osservazione: guardando a posteriori quelle fotografie di quegli anni rappresentano l’immobilismo economico italiano di quegli anni.
Quindi, se Instagram ha festeggiato tale traguardo, di cui il 97% sono selfie o fotografie di cibo o di animali, ciò rappresenta la sterilità culturale che le nostre generazioni stanno attraversando. In questo contesto si inseriscono le fotografie mie e dei miei colleghi, che sognano una fotografia di controtendenza e di protesta contro una società effimera, nella quale non ci identifichiamo più. La nostra è una fotografia che necessita di essere fatta e per paradosso diventa una fotografia di protesta, perché racconta il volto umano”.
(Foto: Marco Gualazzini)