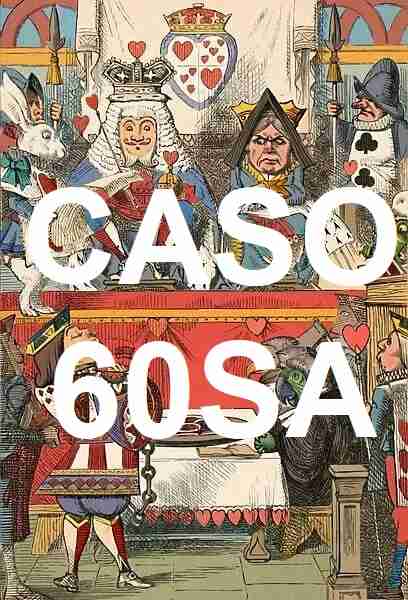Pace per il Sudan

Nel mese di maggio le parti coinvolte nel conflitto in Sud Sudan si sono riunite nella capitale etiope per discutere la ripresa dell’attuazione dell’accordo di pace firmato il 12 settembre scorso, un processo rimasto in stallo, grazie all’iniziativa dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo in Africa orientale (Igad) per rilanciare l’accordo che mira a porre fine alla guerra civile scoppiata a dicembre 2013 nello stato più giovane del mondo, provocando circa 380.000 vittime e oltre 4.000.000 di sfollati.
Il Sud Sudan è nato nel 2011 dopo essersi separato dal Sudan. L’ultima versione dell’accordo, firmata sempre ad Addis Abeba, prevedeva un periodo di transizione di otto mesi (con scadenza fissata al 12 maggio) al termine del quale si sarebbe dovuto formare un governo di unità nazionale. Profonde divergenze fra governo e ribelli hanno però provocato forti ritardi nell’applicazione dell’accordo.
Oltre alla mancanza di sicurezza, i principali problemi della questione sudsudanese da risolvere sono la creazione di un esercito nazionale, lo smantellamento dei gruppi armati e il numero di stati regionali. Il 10 e 11 aprile scorsi i due leader sudsudanesi, insieme con altri alti esponenti politici e con autorità civili ed ecclesiastiche del paese, erano stati protagonisti insieme in Vaticano di un ritiro spirituale (organizzato di comune accordo tra la Segreteria di Stato e l’Ufficio dell’Arcivescovo di Canterbury) conclusosi con l’incontro con papa Francesco a Santa Marta.
I gruppi etnici più numerosi sono: arabi (circa 70%), baggara, fur, nuba, fallata e le religioni di riferimento sono musulmani sunniti (96%), cattolici (3%, per lo più sudsudanesi emigrati), altri cristiani (1%). Però i massacri non cessano e nei primi giorni di giugno un’operazione militare ha causato 35 morti e 650 feriti. In un discorso alla televisione di stato il capo della giunta militare transitoria (Tmc) Abdel Fatah al-Burhan, si è rammaricato del fatto l’operazione abbia superato i limiti di quanto pianificato, promettendo l’apertura di un’indagine.
In risposta i manifestanti hanno indetto uno sciopero generale a oltranza contro la giunta militare transitoria (TMC) di Khartoum ha imboccato la strada della repressione. Secondo la rivista missionaria ‘Nigrizia’ la svolta è stata preparata da dichiarazioni, trasmesse dalla televisione di stato, in cui si affermava che la zona del presidio davanti al quartier generale dell’esercito, che dura ormai da quasi due mesi, era diventato un posto pericoloso per episodi di microcriminalità diffusa.
La dichiarazione, letta immediatamente con preoccupazione e sospetto dall’opposizione, faceva seguito all’uccisione di una donna in gravidanza, colpita da un militare che, secondo le autorità militari, era ubriaco, e di un ragazzo colpito durante uno scambio di colpi tra diverse forze di sicurezza.
Secondo il Central Committee of Sudan Doctors (CCSD), che raccoglie e diffonde le informazioni di tipo medico dalla parte dell’opposizione, i feriti sarebbero moltissimi, ma è ancora troppo presto per poter fare un bilancio delle vittime.
Secondo fonti ospedaliere della capitale Khartoum, oltre 100 persone sono state uccise dal 3 giugno, quando le forze di sicurezza sudanesi (compresa la famigerata Forza rapida di supporto, un’unità speciale creata dal precedente governo, già responsabile di massacri in Darfur) hanno aperto il fuoco contro un accampamento di manifestanti e le successive proteste.
Internet e altri canali di comunicazioni sono stati bloccati, ma la tragedia è trapelata comunque in tutta la sua brutalità. Cina, Russia e Kuwait hanno bloccato la condanna dell’Onu, rilanciata da Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Svezia.
In questa guerra però i comboniani hanno messo in evidenza il ruolo delle donne: “L’abbiamo vista, era donna. A Khartoum, in questi mesi di proteste di piazza, è stata lei l’immagine della libertà e del cambiamento. Lei che si staglia, ritta nel suo toob bianco, il braccio che incoraggia la folla, lo sguardo che cerca l’intesa di chi l’ascolta, la fotografa, segue il suo parlare incalzante.
Agli orecchi, un dettaglio che ai sudanesi non è sfuggito: dei pendenti che chiaramente ricordano le Candàci, le regine sudanesi dei tempi faraonici. Un protagonismo che smentisce il luogo comune che nel mondo arabo o musulmano le donne siano passive, se non addirittura sottomesse, e che non abbiano alcun peso nella vita politica. Una presenza così esplicita e ancorata nella storia (le regine Candàci) ha un impatto su tutti i sudanesi.
In un paese dove vige la legge islamica da 36 anni e dove la Fratellanza mussulmana ha promosso con orgoglio una campagna di arabizzazione della popolazione (con tutto quello che questo ha comportato in regioni come il Darfur e i Monti Nuba), l’affermazione delle radici africane, antecedenti l’arrivo dell’islam, è una vera e propria sterzata del discorso sociale. Uno degli slogan più scanditi nei giorni della rivoluzione è stato ‘Ana Afriqi, ana sudani’ (Io sono africano, io sono sudanese). Vale un patrimonio perché la nuova generazione di studenti e di professionisti non vuole più indossare obbligatoriamente una identità importata da fuori”.
Nel frattempo l’Unicef ha denunciato che i bambini soldato il Sud Sudan sono 19.000. Anche se entrambi gli schieramenti negano ogni coinvolgimento nei reclutamenti forzati, gli eventi raccontano un’altra storia come ha detto Marko Madut, responsabile di una organizzazione non governativa locale: “Se i figli scappano sono i genitori a rimetterci perché i soldati si vendicano”.